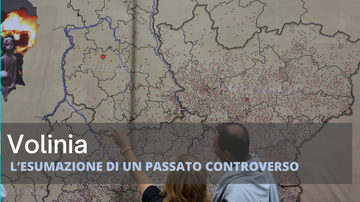Volinia, quei massacri sospesi tra passato e presente
I massacri compiuti in Volinia dai nazionalisti ucraini dell’UPA hanno riacceso tensioni sopite tra Ucraina e Polonia, complice un passato mai realmente affrontato dalle due parti. Un’intervista allo studioso statunitense-canadese John-Paul Himka

Volinia-quei-massacri-sospesi-tra-passato-e-presente
Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy e il presidente polacco Andrzej Duda dopo aver commemorato le vittime della tragedia di Volinia nella cattedrale di San Pietro e Paolo a Lutsk, Ucraina, il 9 luglio 2023 © Shutterstock/paparazzza
Guardare a un biennio di massacri senza tener conto degli antefatti e del complesso contesto del tempo rischia di dar luogo a interpretazioni troppo semplicistiche, facili da strumentalizzare. John-Paul Himka è un autorevole studioso statunitense-canadese di origini ucraine, che si è occupato lungamente dei gruppi armati nazionalisti ucraini attivi durante la Seconda Guerra Mondiale. In questa conversazione prova a inquadrare la tragedia della Volinia dentro i cicli di violenza e contro-violenza che hanno interessato l’area soprattutto dagli anni ‘30 in poi, provando a capire come l’episodio giochi ancora un ruolo nelle retoriche governative del presente.
Negli ultimi tempi, i dibattiti riguardanti i massacri portanti avanti dall’UPA in Volinia e nella zona orientale della Galizia così come le ritorsioni perpetrate dalle forze polacche dell’Armia Krajowa durante gli anni a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, hanno riacceso tensioni sopite nei rapporti fra Ucraina e Polonia. Dal suo punto di vista, qual è il modo corretto per inquadrare quegli eventi?
Non ho mai analizzato i massacri della Volinia con la profondità che meritano, ma ho scritto sulla situazione della popolazione ucraina nella Polonia fra le due guerre e sulla partecipazione dell’Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini (OUN) e dell’Esercito Insurrezionale Ucraino (UPA) nelle uccisioni di massa ai danni della comunità ebraica in Ucraina. A margine dei miei studi sui gruppi nazionalisti e l’Olocausto mi sono inoltre confrontato con documenti diretti e con alcuna della letteratura secondaria riguardante le uccisioni da parte dei nazionalisti ucraini ai danni della popolazione polacca in Volinia e Galizia.
Per come la vedo io, la situazione che era venuta creandosi fra le due guerre ha posto le basi per ciò che poi avvenne nella primavera del 1943, lungo due dinamiche principali. Innanzitutto, sia il nazionalismo ucraino che quello polacco erano andati intensificandosi in quel periodo. In questo senso, la “pacificazione” polacca del 1930 rappresenta forse il punto più basso, ma in generale l’attitudine del governo di Varsavia nei confronti degli ucraini e delle altre minoranze divenne ancora più dura verso la fine del decennio, quando il paese era guidato dai “colonnelli”. La repressione polacca alimentò il nazionalismo della controparte, e così le forze nazionaliste ucraine iniziarono a immaginare e concepire la possibilità di uccidere un gran numero di polacchi presenti sul territorio ucraino e assimilare i sopravvissuti dentro la nazione ucraina.
Il secondo fattore che ha giocato un ruolo da incubatrice per la violenza generalizzata del 1943-44 furono le politiche adottate dai vicini della Polonia, la Germania nazista da un lato e l’Unione Sovietica dall’altra. Entrambi questi stati incoraggiavano la violenza e ne facevano largo uso. Un episodio emblematico della politica nazista fu il pogrom del novembre 1938. Per sua parte, lo stalinismo riuscì a essere ancora più violento durante gli anni ‘30: uccisioni di massa colpirono sia ucraini che, in proporzioni diverse, polacchi. Con queste due potenze che accerchiavano la Polonia prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, anche il clima sociale ed etico in territorio polacco mutò radicalmente. Non penso che gli sviluppi del periodo fra le due guerre abbiano determinato linearmente la violenza che poi si produsse in Volinia e in Galizia, ma diciamo che hanno preparato il terreno.
Un altro importante elemento emerse poi sia durante la guerra che come risultato di quest’ultima: le condizioni in termini di potere e capacità d’azione sia dei gruppi clandestini ucraini che polacchi. Nel momento in cui la Germania iniziò a perdere terreno, si pose la domanda: in che modo verrà ricostituita l’Europa del dopoguerra? La Polonia sarebbe stata ripristinata come nazione nei suoi confini del 1939, includendo quindi ampie porzioni di territorio abitate da ucraini e da lemchi ? L’Ucraina sarebbe riuscita, magari grazie all’appoggio degli alleati, a formare uno stato indipendente? Data la poderosa avanzata dell’Armata Rossa verso ovest, nessuno di questi due scenari appariva probabile ma né le truppe polacche dell’Armia Krajowa né l’Esercito Insurrezionale Ucraino sembravano pronti ad abbandonare le proprie aspirazioni. Dal punto di vista dei nazionalisti ucraini, la presenza polacca sul loro territorio metteva a repentaglio la formazione di un’Ucraina indipendente. Ma i tedeschi li avevano addestrati e avevano dato loro le capacità per risolvere il problema in un certo modo.
Su premesse non così dissimili, nella Polonia del dopoguerra prese forma invece l’Operazione Vistola che fu un progetto di pulizia etnica, come molti ce ne sono stati nella storia e che come tale va giudicato. La Polonia uscita dal secondo conflitto mondiale, che aveva visto l’uccisione della propria comunità ebraica e che aveva espulso dal proprio territorio i tedeschi, era uno stato praticamente monoetnico. È chiaro che per quei gruppi politici che intendevano preservare una tale unità etnica, l’espulsione di lemchi e ucraini rappresentava un passo positivo. Così come per gli stalinisti, l’espulsione dei polacchi dai territori dell’Ucraina occidentale dopo la guerra (che avvenne come parte di uno scambio di popolazione) rappresentava una continuazione delle politiche messe in campo già in precedenza. Stalin non solo aveva ucciso numerosi polacchi dentro i confini pre-1939 dell’Unione Sovietica, ma ne aveva anche deportato e giustiziato molti altri durante i ventuno mesi di occupazione sovietica dell’Ucraina occidentale prima che Hitler iniziasse l’Operazione Barbarossa.
Timothy Garton Ash ha notato che queste operazioni di pulizia etnica avvenute nell’Europa Centrale durante la Seconda Guerra Mondiale hanno probabilmente poi permesso che le transizioni dal comunismo all’indipendenza del 1989 avvenissero in modo relativamente pacifico, al contrario di quanto accaduto in quegli anni nella ex-Jugoslavia. Ma allo stesso tempo, una grossa parte del tessuto etno-culturale di quelle zone è scomparso per sempre e le nuove società, “etnicamente pulite”, hanno inizialmente ignorato il proprio passato oscuro per poi riabbracciarlo.
Durante gli anni ‘90 infatti la questione dei massacri in Volinia non ha creato tensioni fra Polonia e Ucraina, per poi riemergere negli anni successivi. Come mai questo mutamento?
Daterei questo passaggio a metà degli anni Duemila. Il PiS arrivò al potere in Polonia nel 2005 e nello stesso anno Viktor Juščenko divenne presidente dell’Ucraina. Entrambi questi cambianti elettorali rappresentavano una vittoria per la destra nazionalista. Non direi però che il lavoro dei rispettivi Istituti della Memoria sotto la guida dei due leader siano di per sé responsabili della rinnovata tensione fra i due paesi rispetto alla questione dei massacri della Volinia. Dopotutto, prima che avvenisse una effettiva svolta politica verso destra, l’Istituto della Memoria Nazionale in Polonia ha portato avanti ricerche molto interessanti che investigavano i fatti da una prospettiva auto-critica. Cosa molto significativa, ha difeso e sviluppato le scoperte di Jan Gross in merito alla partecipazione dei polacchi nell’Olocausto. Dall’altro lato, l’Istituto per la Memoria Nazionale ucraino venne fondato nel 2006 e immediatamente iniziò a glorificare sia l’OUN che l’UPA. In questo senso venne sostenuto dai servizi segreti del paese, l’SBU.
Certamente, le manipolazioni governative hanno giocato un ruolo importante nell’alimentare un sentimento nazionalista da entrambi i lati del confine ma, per quanto riguarda i massacri condotti dall’UPA a danno della popolazione polacca nell’Ucraina occidentale, la memoria della gente comune in tutt’e due i paesi ha avuto il suo peso. È chiaro che si tratta di memorie divergenti. Molti polacchi, che sono fuggiti dall’Ucraina generalmente verso i territori che vennero integrati dalla Germania sconfitta nello stato polacco, ricordavano la barbarie delle uccisioni di massa in Volinia e Galizia. Ciononostante, non potevano parlarne pubblicamente durante il periodo del regime comunista che è durato fino al 1989. Ma, in quanto persona di origine ucraina che ha passato un anno della propria vita in Polonia fra il 1975 e il 1976, posso testimoniare che si trattava di una ferita sentita in maniera bruciante dalla popolazione polacca.
La nuova Polonia nata dopo il comunismo aveva un governo di orientamento liberale la cui politica nei confronti dell’Ucraina si può riassumere grossomodo nella volontà di lasciarsi il passato alle spalle. L’intellettuale più influente di quel periodo fu Adam Michnik, che guidava il quotidiano anch’esso di orientamento liberale Gazeta Wyborcza. C’era da parte sua una connessione personale verso l’Ucraina: il padre aveva infatti servito come primo segretario del Partito Comunista dell’Ucraina Occidentale (ho avuto modo di conoscere questo legame fra Michnik e l’Ucraina grazie un amico in comune, lo storico e demografo Janus Radziejowski). Nel periodo fra il 1989 e il 2005 non c’era davvero lo spazio politico perché le violenze subite dalla popolazione polacca in Volinia diventassero una questione pubblica. Questo spinse i discendenti delle vittime dell’UPA, i cosiddetti kresowiacy, dritti nelle braccia della destra e il momento della loro riscossa arrivò appunto nel 2005.
In Ucraina la promozione governativa di una rilettura nazionalista del passato giocò un ruolo più prominente, in particolare durante la presidenza Juščenko (2005-10) e poi con la successiva presidenza di Petro Porošenko (2014-19). Ma la memoria popolare pure costituì un fattore di enorme importanza. L’UPA aveva portato avanti uccisioni di massa ai danni di polacchi, ebrei, russi e altri gruppi nel biennio 1943-44. In un certo senso, la situazione demografica era diventata meno variegata e complessa con la riconquista sovietica dei territori occidentali dell’Ucraina: polacchi ed ebrei non c’erano più. Nonostante pure in questo periodo l’UPA uccise alcuni dei polacchi e degli ebrei superstiti, il suo sforzo si concentrò primariamente a organizzare un’insurrezione clandestina contro il governo sovietico e fu capace di mettere in campo una resistenza notevole dal 1945 fino al 1950. Dal momento che era ancora fresca la memoria della violenza sanguinaria del precedente periodo di potere sovietico (1939-41) il gruppo nazionalista incontrò molta simpatia presso la popolazione. Ma ancora più significativo fu il modo in cui il regime staliniano pose fine all’insurrezione: in maniera brutale e generalizzata.
Ecco che risulta chiara l’importanza delle narrazioni di impronta governativa. Nel suo tentativo di insurrezione anti-sovietica, l’OUN-UPA uccise innanzitutto dei compatrioti, contadini dell’Ucraina occidentale: persone che si erano unite alle fattorie collettive o avevano collaborato con le autorità sovietiche da poco ristabilitesi nell’area. Pertanto, molte famiglie hanno ricordi nelle proprie fila di due tipi di vittime: parenti uccisi dal governo e parenti uccisi dai nazionalisti ucraini. Sotto il regime sovietico, i giornali locali pubblicavano interviste e articoli che riguardavano esclusivamente le atrocità commesse dall’OUN-UPA, e non avevano bisogno di inventarsi nulla. Ma quando, sotto la presidenza di Juščenko, i nazionalisti non solo vennero riabilitati ma esaltati, tutto questo segmento di storia venne rimosso dal dibattito pubblico.
Come si è articolato questo discorso sulla memoria col panorama politico più generale dell’Ucraina?
Dal 2005 al 2009, invece di concentrarsi su problematiche sociali come la sanità pubblica o gli alloggi, la politica ucraina ha promosso campagne che riguardavano i simboli nazionali. Juščenko e Porošenko hanno sostenuto con fervore la riabilitazione dell’OUN-UPA e si sono impegnati per il riconoscimento della carestia indotta del 1932-33 (Holodomor) come genocidio contro il popolo ucraino. Al contrario Viktor Janukovyč (2010-14) ha fatto appello all’eredità della vittoria dell’Armata Rossa contro il fascismo e considerava la carestia come una tragedia condivisa assieme ad altre popolazioni dell’Unione Sovietica.
Le elezioni del 2019 hanno segnato un rottura in queste dinamiche. Porošenko ancora una volta si fece promotore di un programma politico di stampo ultra-nazionalistico, ma l’elettorato votò in maniera schiacciante per avere come presidente una celebrità televisiva, Volodymyr Zelensky, che rappresentava una piattaforma anti-corruzione, scevra di retoriche riguardanti la simbologia nazionale. Dal momento della sua elezione (maggio 2019) fino al 2022, Zelensky ha cercato di non schierarsi né con gli elementi più nazionalisti né con quelli più filorussi presenti in Ucraina. Ha rimpiazzato il presidente dell’Istituto della Memoria Nazionale, Volodymyr Viatrovych, che era un ardente promotore dell’eredità dell’OUN-UPA. Allo stesso tempo, però, Zelensky e i suoi più stretti collaboratori non hanno sviluppato né un’ideologia coerente né delle politiche in grado di consolidare questa nuova linea di neutralità fra le tradizionali fazioni contrapposte.
Una volta che la Russia ha lanciato la sua invasione su larga scala, tuttavia, Zelensky ha dato prontamente spazio alle frange più nazionaliste. Da quel momento, inoltre, una buona fetta della popolazione russofona ha subito diverse restrizioni e umiliazioni, così come la Chiesa Ortodossa Ucraina, che è stata associata alla Chiesa Ortodossa Russa fino a maggio 2022, è stata perseguitata e sta per essere bandita.
Come giudica le esumazioni che sono iniziate in Ucraina occidentale e come è possibile avviare un processo di rielaborazione storica sui massacri della Volinia senza alimentare retoriche e tensioni nazionalistiche?
Per ora, le esumazioni in quello che fu il villaggio di Puzhnyky nell’oblast di Ternopil hanno riprodotto lo stesso conflitto di memoria già in corso fra polacchi e ucraini, coi primi che enfatizzano il loro ruolo di vittima e i secondi che ripetono le giustificazioni addotte dall’OUN-UPA. Senza esumazioni che interessino i luoghi di maggiore violenza, nello specifico le città e gli insediamenti in Volinia che vennero distrutti fra la primavera del 1943 e l’estate del 1944, non possiamo aspettarci conferme archeologiche di ciò che viene tramandato dai documenti e dalle memorie personali.
Penso che l’unico modo per rielaborare criticamente la vicenda sia indagare seriamente tutto ciò che è successo, nella sua complessità e senza preoccuparsi di chi sia stato l’eroe e chi il cattivo. Si tratta di un lavoro accademico da svolgere senza sconti, che non porterà ad alcuna narrazione sintetica e, soprattutto, consolatoria per nessuno dei due “ego nazionali” coinvolti. Prima viene intrapreso tale percorso, meglio è. Solo il tempo può lenire le ferite. Intanto, l’Ucraina dovrebbe guardare in maniera distaccata e oggettiva alle violenze che l’OUN-UPA ha inflitto a minoranze nazionali e oppositori. Penso anche che i polacchi debbano riconoscere i grossi e dolorosi errori commessi dal loro stato nel periodo fra le due guerre e valutare criticamente le aspirazioni dei loro movimenti clandestini nel corso del secondo conflitto mondiale. Sarebbe inoltre d’aiuto se i russi, dal canto loro, riuscissero a far chiarezza rispetto a cosa ha significato lo stalinismo per ucraini e polacchi. Ma certo si tratta di un compito che eccede le possibilità del presente, che vede un’invasione in corso e continui combattimenti.
Segui le pubblicazioni nel dossier dedicato