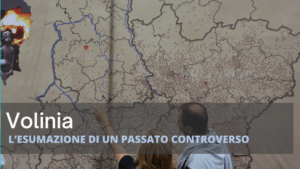Volinia, Polonia e Ucraina ostaggi dei propri miti
Le divisioni tra Ucraina e Polonia sui massacri in Volinia sono legati in modo profondo ai miti nazionali elaborati dalle due nazioni negli ultimi anni. Per lo storico ucraino Yaroslav Hrytsak, per superare le divergenze serve un approccio metodologico nuovo e “spiazzante”

Rivne,,Ukraine.,10,October,2024.,Monument,To,Klym,Savur,,The
Rivne, Ucraina, monumento a Klym Savur, comandante dell'armata ribelle ucraina in Volinia - © weha/Shutterstock
I massacri della Volinia del 1943-44 non rappresentano solo una specifica controversia storica: sono eventi che interrogano anche le diverse narrazioni e mitologie nazionali su cui si è andata fondando l’identità della Polonia da un lato e dell’Ucraina dall’altro. L’interpretazione storica di quei fatti deve dunque tener conto di tutto queste complessità, soprattutto se ci si vuol porre in un’ottica di riconciliazione e non di strumentalizzazione politica. Ne abbiamo parlato con lo storico ucraino Yaroslav Hrytsak, autore di “Storia dell’Ucraina. Dal medioevo a oggi”.
Sulla questione dei massacri in Volinia, Polonia e Ucraina sembrano dividersi perché i due paesi hanno nel tempo elaborato dei “miti nazionali” molto diversi fra loro. Spesso questi miti vengono anche strumentalizzati per portar avanti politiche escludenti o per rafforzare concezioni di stampo etnico delle società. Che atteggiamento assumere in un contesto simile?
Si tratta di una questione che ne contiene in sé molte altre, tutte molto delicate e complesse. Proverò a partire da alcune considerazioni generali. Innanzitutto, penso sia vero che nessuna società può esistere senza miti o narrazioni collettive, ma tali “miti” non devono per forza essere di carattere escludente: alcuni lo sono, altri no. Secondariamente, quando parliamo dei rapporti fra Polonia e Ucraina, è bene non dimenticarsi che più o meno a partire dal crollo del comunismo è effettivamente emerso un processo di riconciliazione fra i due paesi. Credo si tratti di qualcosa di estremamente significativo che potrebbe essere paragonato alla riconciliazione franco-tedesca successiva alla Seconda Guerra Mondiale nella misura in cui, se quest’ultima ha servito da pietra miliare su cui si è basata la creazione dell’Unione Europea, così la riconciliazione polacco-ucraina ha aperto la possibilità per un allargamento dell’Unione a est. Detto in maniera molto semplice: esiste un equilibrio, per cui chiunque salga al potere a Varsavia o a Kyiv è portato a vedere il proprio vicino come un partner strategico.
Questa riconciliazione è fondata su un calcolo di natura pragmatica, vale a dire il timore comune ai due paesi di un’aggressione da parte della Russia. Ma è anche il risultato di un profondo e continuo sforzo per superare il passato, portato avanti da intellettuali e rappresentanti della società civile di entrambi i lati, che a sua volta si fonda sul mutuo riconoscimento che nessuna delle due nazioni può vantare un diritto di possesso o di intervento sulle “terre storiche” che oggi si trovano al di là delle frontiere stabilite, e dove persistono legami etnici con lo stato confinante: Volinia e Galizia in Ucraina o Nadsianie in Polonia. Per consolidare tale sforzo vengono appunto utilizzate delle narrazioni – le possiamo chiamare “miti” – che hanno a che fare con una tradizione di collaborazione fra Polonia e Ucraina che è comunque esistita nel passato.
Ciò detto, i massacri della Volinia e la questione del movimento nazionalista ucraino dell’UPA costituiscono effettivamente delle possibili “pietre d’inciampo” nel processo di riconciliazione fra i due paesi. In questo caso abbiamo a che fare con miti nazionali estremamente asimmetrici: nel corso degli ultimi dieci anni, i massacri della Volinia sono diventati un elemento centrale nella memoria storica della comunità polacca, un po’ come possono essere l’Olocausto per quella ebraico o l’Holodomor nel caso ucraino, mentre nella memoria storica dell’Ucraina questi massacri occupano un posto piuttosto marginale.
La più parte degli ucraini possiede solo una vaga idea di cosa è successo in quel periodo in quelle zone, e sono pronto a scommettere che lo stesso presidente Zelensky non ne sapesse molto fino a qualche tempo fa. Perciò, in generale, gli ucraini non comprendono come mai le élite polacche, che dovrebbero essere alleate di Kyiv, agitino una tale questione mentre è in corso una guerra con la Russia. Sospettano anzi che si tratti di un’iniziativa di disturbo portata avanti da Mosca, nell’intenzione di rompere l’alleanza fra Polonia e Ucraina.
Ho preso parte a diversi eventi e iniziative che si ponevano l’obiettivo della riconciliazione dei rapporti fra ucraini e polacchi e, se alcuni di questi hanno avuto esiti di successo, lo stesso non posso dire delle occasioni dedicate alla Volinia. In questo caso, ho assistito solo a spettacolari fallimenti. Ecco perché la mia esperienza personale mi fa amaramente pensare che le possibilità di una vera riconciliazione sono molto esili, e comunque sarebbero necessari molto più tempo e molti più sforzi di quelli messi in campo adesso.
Con l’invasione russa in Ucraina ha ripreso enfasi l’esigenza espressa da una parte del mondo accademico di “decolonizzare” la storia dell’Europa centro-orientale. Come valuta il ruolo delle nuove interpretazioni storiche degli sviluppi nella regione, che emergono anche grazie alla possibilità di accesso ad archivi che un tempo era negata? Di converso, vede il rischio che il clima di nazionalismo e patriottismo possa produrre visioni distorte e poco accurate?
Le guerre rappresentano sempre dei punti di svolta. Nello specifico, l’invasione russa ha alterato in modo significativo il profilo della società ucraina. Innanzitutto, il paese ha perso la Crimea e il Donbas che erano le regioni a maggioranza russofona. Dal punto di vista etnico e linguistico, l’Ucraina è effettivamente diventata più omogenea. A questo si aggiunge il fatto che, come conseguenza dell’aggressione russa e soprattutto degli incessanti bombardamenti russi, anche tanti russofoni stanno abbandonando la propria madrelingua per l’ucraina. Lo si può notare in maniera molto chiara nelle grandi città di Karkhiv o Odesa, per esempio. Anzi, potremmo affermare per assurdo che il presidente russo Vladimir Putin è il principale “de-russificatore” dell’Ucraina. Ora, dato l’insieme di tutti questi fattori, la guerra sta portando a una maggiore etno-nazionalizzazione dell’Ucraina e questo processo si riflette anche nell’evolversi della memoria storica.
Un esempio su tutti: il leader nazionalista Stepan Bandera prima della guerra rappresentava la figura storica più divisiva del paese – nelle regioni dell’ovest era tendenzialmente visto come un eroe, mentre in quelle dell’est veniva trattato come un bandito e un collaborazionista dei nazisti – e ora viene valutato positivamente dalla maggioranza degli ucraini in quanto simbolo della lotta contro la Russia. Ma è un simbolo rifinito e sgrossato di molti dei suoi elementi, ridotto appunto al suo lato di opposizione alla Russia mentre gli altri connotati relativi al suo antisemitismo o alla sua opposizione alla Polonia vengono espunti dal mito. Qualcosa di simile avviene con la comunità ebraica o tatara: tradizionalmente erano considerati nemici storici dell’Ucraina, mentre ora vengono considerati alleati stretti e, anzi, legittimi membri della nazione ucraina.
In altre parole, siamo di fronte a due tendenze divergenti di cui una conduce verso una concezione etnica dell’identità ucraina e l’altra verso una concezione civica (e di conseguenza multietnica) dell’identità nazionale. Prima che scoppiasse la guerra su larga scala, mi sento di dire che la concezione civica prevalesse su quella etnica, anzi si era affermata come tendenza egemone nella società ucraina da circa un anno. Ancora è difficile dire se gli eventi in corso segneranno una discontinuità, e molto dipende dalla durata e dall’esito del conflitto. Ciò detto, non per forza l’identità di stampo civico e di stampo etnico sono mutualmente esclusive. Anzi, molto spesso e in molti casi convivono l’una con l’altra. Perciò la vera questione è: quale sarà il “nocciolo duro” dell’identità ucraina dopo la guerra? Credo che la concezione etnica verrà messa maggiormente al centro, ma cionondimeno l’Ucraina preserverà il proprio carattere di nazione civica.
Per arrivare alla domanda, dunque: sì, c’è un rischio di rafforzamento dei nazionalismi ma penso che il rischio resti comunque basso. Due sono i fattori che frenano: la decisione del governo ucraino di impostare i percorsi educativi statali con insegnamenti di storia che combinano la storia nazionale con quella globale e la prospettive di un’integrazione del paese nell’Unione Europea. Ma il tempo dirà.
Assieme ad altri storici polacchi e ucraini lei si è impegnato nell’elaborazione di un comunicato congiunto affinché i massacri della Volinia vengano trattati dalle classi politiche in maniera più pragmatica, senza strumentalizzare la memoria dolorosa di quegli eventi. In generale, che tipo di metodologia si dovrebbe adottare per leggere la storia tenendo insieme le sofferenze che hanno segnato le sofferenza di polacchi, ucraini ed ebrei in queste zone. Insomma, senza scadere né in un vittimismo competitivo né in una relativizzazione delle diverse responsabilità?
Nel nostro comunicato abbiamo tentato di avanzare una proposta metodologica spiazzante: nell’indagare i massacri della Volinia, occorre trattare tutte le vittime come vittime in comune fra Polonia e Ucraina. Al momento, il messaggio che abbiamo lanciato non è stato fatto proprio da alcun politico. Ma in ogni caso, si possono adottare anche paradigmi più tradizionali: se ci si pone l’obiettivo di operare una riconciliazione fra la memoria storica di due nazioni è sempre meglio evitare di imporre dall’alto schemi interpretativi, ma procedere maggiormente attraverso le storie e le testimonianze che vengono “dal basso”, storie e testimonianze di persone comuni.
Posso fare un esempio recente: qualche anno fa, prima che scoppiasse l’invasione su larga scala, uno storico ucraino e uno polacco avevano scoperto durante una summer school che i loro genitori provenivano dallo stesso villaggio della Volinia. Non solo: la nonna dello storico ucraino aveva protetto il nonno dello storico polacco dai parenti della prima che lo avrebbero voluto uccidere, salvandogli la vita. Questa storia è stata pubblicata sul quotidiano polacco Gazeta Wyborcza e da lì hanno iniziato a scrivere un libro sulla Volinia che ricostruisce le vicende partendo proprio dalle storie familiari.
Come valuta le esumazioni in corso? Pensa che l’Unione Europea dovrebbe inserirsi nel processo per facilitare che si vada verso la riconciliazione fra i due paesi? In più: se i recenti progressi sembrano ascrivibili ai buoni rapporti fra il primo ministro polacco Tusk e il presidente ucraino Zelensky, intravvede il rischio che altre forze politiche possano minare i loro sforzi?
In primo luogo, vorrei far notare che le esumazioni stanno avvenendo in aree che non hanno nulla a che vedere con i massacri della Volinia. Per ora si stanno concentrando in Galizia, dove le violenze ci sono state solo due anni più tardi. Una strana scelta, e non ho visto alcuna spiegazione ufficiale del perché. Credo si tratti di una decisione data dalla volontà di iniziare il processo da zone “meno sensibili”, per evitare reazioni eclatanti. Ma è solo una supposizione.
Per quanto riguarda il ruolo che dovrebbe giocare l’Unione Europea, partiamo dal fatto che esistono figure politiche e voci pubbliche in Polonia che chiedono di bloccare l’accesso dell’Ucraina in Europa finché non ci saranno delle scuse ufficiali per i massacri della Volinia. Dal mio punto di vista si tratta di un assunto sbagliato, che anzi andrebbe ribaltato: l’ingresso dell’Ucraina in Europa accrescerebbe la possibilità di una riconciliazione polacco-ucraina sulla Volinia. Vorrei far riferimento al dibattito che ha avuto luogo in Polonia in merito alle responsabilità della società polacca nell’Olocausto, un dibattito che venne suscitato dal libro Vicini dello storico Jan Gross e che ha infine portato Varsavia a riconoscere le proprie responsabilità. Ora: questo riconoscimento sarebbe avvenuto se in quel momento il paese fosse stato in guerra e senza alcuna prospettiva di ingresso nell’Unione? Secondo me no, secondo me essere dentro l’Europa è precondizione per una riconciliazione.
Infine, rispetto a Tusk e Zelensky. In realtà, molti dei momenti in cui la controversia storica attorno ai massacri della Volinia si è surriscaldata oppure ha conosciuto distensioni sono avvenuti mentre questi due leader erano alla guida dei propri rispettivi paesi. A settembre dello scorso anno, ho assistito a un alterco piuttosto acceso fra Zelensky e il ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski proprio sulla questione della Volinia. Dopodiché, entrambi sono giunti alla conclusione che occorresse superare le proprie divergenze il più presto possibile. Penso che un ruolo cruciale venga giocato dal ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha: è una persona dalle grandi competenze diplomatiche e conosce molto bene la Polonia in tutte le complessità dei suoi rapporti con l’Ucraina. A ogni modo conosceremo presto altri dettagli, ma questo non significa che occorre fermare gli sforzi di riconciliazione.
Segui le pubblicazioni nel dossier dedicato
Tag: