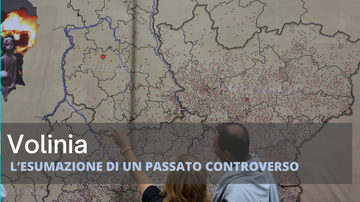Volinia, fuori dal paradigma vittimario
L’inizio delle esumazioni in Volinia, per portare alla luce i corpi delle vittime dei massacri perpetrati da gruppi nazionalisti ucraini contro comunità polacche nel biennio 1943-44, segnano una svolta nelle relazioni fra Varsavia e Kyiv. Intervista allo storico polacco Adam Leszczyński

Volinia-fuori-dal-paradigma-vittimario
Varsavia, monumento ai massacri di Volinia - © MOZCO Mateusz Szymanski/Shutterstock
L’inizio delle esumazioni in Volinia segnano un punto di svolta nelle relazioni fra Varsavia e Kyiv sul tema: prima di questo momento, i passi in avanti nella ricerca di giustizia storica e nel processo di riconciliazione erano stati scarsi, accompagnati fra le altre cose da un certo grado di strumentalizzazione da parte delle forze di destra in Polonia così come da una certa ritrosia dei governi in Ucraina a farsi carico delle proprie responsabilità. Ma tanti interrogativi restano sul tavolo, a partire da quale sia il paradigma più corretto con cui leggere quegli eventi. Ne abbiamo parlato con lo storico polacco Adam Leszczyński.
Come valuta le esumazioni in corso e il clima politico che vi si sta creando attorno, soprattutto con la recente campagna elettorale per le presidenziali polacche?
Il tema delle esumazioni non è stato chiaramente il tema maggiormente dibattuto nella campagna elettorale, ma comunque vi ha giocato un ruolo importante così come in generale si è discusso delle relazioni fra la Polonia e l’Ucraina. Per capire il perché occorre guardare al contesto: l’aumento della migrazione dall’Ucraina a causa dell’invasione russa sta avendo diverse ripercussioni nella società polacca su molteplici livelli. Un primo livello è quello economico: per esempio, molti produttori del settore agricolo in Polonia hanno timore della concorrenza ucraina. Insomma, un’incrinatura degli equilibri che si ripercuote a catena su molti altri livelli come quello dei salari, dell’occupazione lavorativa o delle questioni identitarie. Ma le visioni sono miste: c’è chi reagisce in senso più xenofobico e chi, anche nel mondo degli affari, si sente solidale o vede questa ondata migratoria come un’opportunità.
Un tale clima si intreccia con le stratificazioni storiche dei rapporti fra i due paesi. La presenza polacca nelle regioni che formavano i suoi territori orientali (e che dalla Seconda Guerra Mondiale sono invece parte dell’Ucraina) ha subito dinamiche complesse. In generale, possiamo dire che da parte degli ucraini fu quasi sempre percepita come oppressiva: spesso i polacchi presenti in quelle zone erano nobili o proprietari di terre e coltivavano sentimenti nazionalisti fortemente anti-ucraini. Al contrario, dal punto di vista polacco, si trattava quasi di una missione civilizzatrice: le persone polacche si recavano nei territori ucraini convinti di dover “civilizzare” gli abitanti del luogo, con un atteggiamento sostanzialmente colonialistico.
Oggi, in Polonia, i due principali partiti usano retoriche contrapposte per accusarsi a vicenda di aver incrinato i rapporti con l’Ucraina rispetto al tema dei massacri in Volinia. Se alla destra nazionalista si rimprovera di strumentalizzare la questione e di porsi in un’ottica di pura contrapposizione nei confronti di Kyiv, alla piattaforma di centro-sinistra si rinfaccia di non porre sufficienti pressioni per mandare avanti il processo di ricerca di giustizia storica. Si evince quindi che le stesse esumazioni stanno dentro un contesto più generale che è molto complicato e toccano “corde politiche” molto sensibili.
Per quanto mi riguarda, credo comunque che le esumazioni siano un atto dovuto e penso che trovare i corpi delle vittime e identificare le fosse comuni sia un dovere nonché un obbligo morale per lo stato polacco. Certo, l’Ucraina è stata piuttosto riluttante ad ammettere le proprie responsabilità per diversi motivi, a partire dal fatto che gruppi e figure coinvolte nei massacri del 1943-44 fanno parte della narrazione ufficiale in merito alla fondazione dello stato.
Quale sarebbe la lente più corretta con cui guardare a quegli eventi?
Il dibattito in Polonia è su più livelli, legale, politico e storico. È fuori questione il fatto che un grosso numero di cittadini polacchi siano stati uccisi fra il 1943 e 1944, principalmente nella regione della Volinia (le stime vanno da 60mila alle 300mila persone). Si è trattato di un’azione coordinata dei gruppi nazionalisti ucraini, che con tutta probabilità venne accettata quando non direttamente supportata dalle truppe tedesche che erano presenti sul territorio (l’esercito della Germania controllava principalmente le città ma non le campagne), e che rispondeva all’obiettivo di creare un’Ucraina etnicamente pura, in cui non ci fossero polacchi, ebrei o altre nazionalità… Ripeto, tutto ciò è fuori discussione ed è oramai ben investigato: abbiamo gli ordini dei gruppi ucraini che pianificavano le uccisioni, ecc. Questi sono fatti.
Si può allora interrogarsi sulle definizioni. Direi che è abbastanza chiaro che si trattò di un crimine di guerra e di un caso di pulizia etnica. Alcuni si spingono a parlare di genocidio, ma altri sostengono che il caso della Volinia non rientri nei parametri legali di un evento di questo tipo. È un dibattito complesso, e nemmeno lo stato polacco ha le idee chiare in merito: dipende dai partiti e dal clima politico del momento. In generale, negli ultimi 10/15 anni è stata messa una forte pressione sulle istituzioni ucraine affinché si scusassero per i massacri: l’attuale presidente Zelensky lo ha fatto, magari con una certa ritrosia, ma anche in passato un presidente ucraino si era assunto responsabilità. Ma per certi gruppi d’opinione in Polonia gli ucraini dovrebbero scusarsi in continuazione, in un ciclo infinito.
I massacri della Volinia sono accaduti ormai parecchi anni fa, ma la memoria delle storie delle persone coinvolte in quegli eventi è ancora viva e si intreccia con questioni identitarie e politiche. Perciò, è difficile adottare un solo approccio chiaro e onnicomprensivo. Anche la collaborazione con la controparte ucraina è difficoltosa: sebbene a livello presidenziale magari ci sia ora piena disponibilità a procedere con le esumazioni, poi capita che le diverse amministrazioni locali oppongano resistenza.
In più, ci sono le ingerenze esterne…
Sì, e penso che in questo campo l’attore più importante sia la Russia. Sono membro della commissione governativa che si occupa dell’influenza russa in Polonia e in base alle informazioni che abbiamo raccolto vediamo chiaramente come per il Cremlino la questione dei massacri in Volinia rappresenti un elemento molto proficuo da sfruttare per esacerbare le divisioni fra Varsavia e Kyiv. La propaganda russa lo utilizza un po’ dappertutto, su internet e sui social. Questo complica le cose, perché la Polonia assieme alla ricerca di giustizia storica deve anche tener conto di non fare il gioco di Mosca.
I massacri della Volinia si inseriscono nel più ampio contesto delle relazioni storiche polacco-ucraine, che hanno conosciuto numerosi momenti di attrito…
Sì, così come in Volinia si è verificato un processo di quasi-colonizzazione da parte polacca e poi la repubblica fra le due guerre ha adottato politiche repressive nei confronti delle minoranza (tra cui quella ucraina), anche dopo la Seconda Guerra Mondiale in Polonia ci sono stati casi di repressione e pulizia etnica contro gli ucraini. Su scala minore rispetto ai massacri in Volinia, ma ci sono stati.
Per riassumere: entrambi i lati posso avanzare legittime lamentele rispetto a determinati casi. Il fatto è che – come troppo spesso accade in Europa centro-orientale – tutti tendono a percepirsi sempre come vittime e mai come carnefici. Ho assistito a tantissime discussioni di questo tenore, in cui non si fa altro che perdersi in un ciclo infinito di accuse e contro-accuse.
Ma è vero: la questione della Volinia rappresenta un’eredità della presenza polacca nelle regioni dell’ovest ucraino. Migrazione polacca, relazioni quasi-coloniali della comunità polacca con le terre ucraine… Se si vuole arrivare alle radici del problema si può arrivare fino al XIV-XV secolo.
Come uscire dal paradigma vittimario?
Al momento, la quasi totalità delle persone direttamente coinvolte nei massacri è scomparsa e le politiche della memoria rispetto a quell’evento sono per la più parte politiche elaborate dallo stato. A loro volta, in Polonia, queste politiche vengono formulate dall’Istituto della Memoria Nazionale che è una realtà di tendenza nazionalista e che gode di grandi disponibilità in termini di fondi, pubblicazioni, programmi per le scuole, mostre ecc. La più parte dei rappresentanti di questa istituzione è convinta che l’Ucraina debba assumersi tutta la responsabilità, che debba avere un atteggiamento di scuse, ecc ecc. Quindi, c’è un problema rispetto a chi “controlla” la narrazione nel paese.
Ma io credo che si debba guardare più al modello delle relazioni franco-tedesche o polacco-tedesche per come si sono sviluppate in un’ottica di riconciliazione dopo la Seconda Guerra Mondiale. Occorre riconoscere i fatti e al tempo stesso riconoscere che entrambi i lati hanno delle responsabilità, rispetto alle quali va capito il grado e la scala caso per caso. Solo così è possibile costruire dei rapporti bilaterali di amicizia basati sul riconoscimento della verità storica e non su accuse reciproche. Il processo di riconciliazione franco-tedesco o polacco-tedesco ha permesso di levare il peso delle dispute storiche dalla vita ordinaria delle persone. In ogni caso, ripeto, per intraprendere questo percorso è necessario che vengano portate avanti le esumazioni e che le morti siano correttamente commemorate.
Segui le pubblicazioni nel dossier dedicato