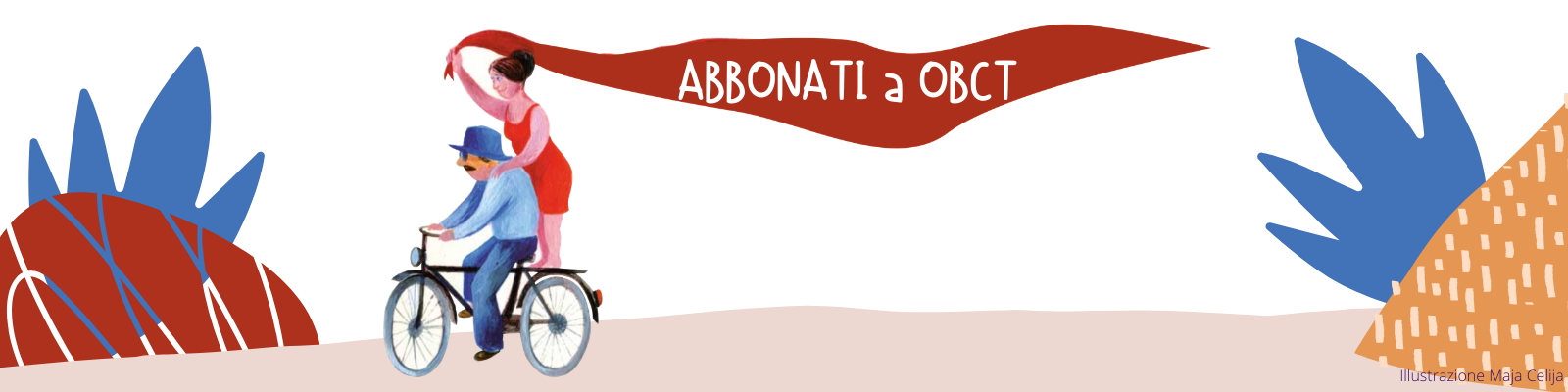Unanimità, un’insostenibile prassi nel processo di adesione all’UE
Secondo i Trattati dell’UE, il diritto di veto è previsto solo all’inizio dei negoziati, non per ogni decisione intermedia. Come ogni prassi, potrebbe essere modificata attraverso la volontà politica. Intervista a Christophe Hillion, professore di diritto europeo all’Università di Oslo

Unanimita-un-insostenibile-prassi-nel-processo-di-adesione-all-UE
Bruxelles, sala degli incontri dei 27 del Consiglio europeo - © Alexandros Michailidis/Shutterstock
L’intransigente opposizione dell’Ungheria di Viktor Orbán ai negoziati di adesione dell’Ucraina all’UE sembra incrollabile. Le istituzioni europee si interrogano su come superare lo stallo imposto dal premier ungherese, che da mesi sta impedendo con il suo potere di veto di aprire il primo gruppo di capitoli negoziali con Kyiv, nonostante il via libera della Commissione europea.
Eppure, se si analizza la questione dalla prospettiva giuridica, privandola della retorica politica e delle tensioni di Budapest con Kyiv e Bruxelles, la soluzione appare inaspettatamente semplice. Perché nell’articolo 49 del Trattato sull’Unione europea (TUE) – quello che definisce le basi del processo di allargamento – "non è possibile trovare alcuna disposizione che stabilisca l’obbligo di aprire e chiudere 33 capitoli negoziali sulla base di una decisione unanime", mette in chiaro Christophe Hillion, professore di diritto europeo all’Università di Oslo, in un’intervista per OBCT.
Interrogato sui fondamenti giuridici del processo di adesione all’Unione, Hillion, uno dei massimi esperti su questo tema, mette in chiaro che il passaggio da circa 150 decisioni all’unanimità nelle fasi intermedie del processo – per aprire e chiudere ogni singolo capitolo negoziale – è "esclusivamente una prassi istituzionale, che non è prevista dalla legislazione europea e che, come ogni prassi, può essere modificata". Non ponendosi nemmeno un tema di modifica dei Trattati fondanti dell’UE, ciò che manca al momento è solo la volontà politica.
Cosa dicono i Trattati dell’UE a proposito dell’unanimità nel processo di allargamento?
La procedura prevista dall’articolo 49 del Trattato prevede un solo momento in cui il Consiglio delibera all’unanimità, cioè all’inizio del processo, quando risponde formalmente alla candidatura di un Paese terzo. Inoltre, alla fine del processo è necessario che venga negoziato un Trattato di adesione tra gli Stati membri e il candidato, e che tale Trattato sia poi ratificato dagli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
È prevista solo una procedura che permette al Consiglio di sospendere il processo di un candidato attraverso un voto a maggioranza qualificata, nel caso in cui il candidato stesso stia venendo meno ai propri impegni. Ma non si tratta di una procedura che consente a un qualsiasi Stato membro di bloccare il processo perché non è di suo gradimento.
Perché attualmente è in vigore la prassi dell’unanimità durante le fasi intermedie?
Dal punto di vista giuridico, effettivamente è molto difficile capire perché siano necessarie così tante decisioni all’unanimità nelle varie fasi dei negoziati, considerato il fatto che non sono richieste dai Trattati.
A mio avviso, questo eccesso di decisioni all’unanimità serve solo a rallentare il processo. In sostanza, si sta cercando un modo per non attuare una decisione sull’allargamento dell’Unione che è già stata presa in precedenza [in occasione del mandato dei 27 capi di Stato e di governo riuniti nel Consiglio europeo, ndr].
Esiste una tensione costituzionale fondamentale tra quanto previsto dai Trattati e il modo in cui gli Stati membri hanno sviluppato ogni tipo di strategia per rallentare o ostacolare l’attuazione di questa decisione politica.
Sarebbe possibile modificare in corsa la prassi e passare a decisioni per maggioranza qualificata?
Sì, come ogni prassi può essere modificata. Resta però da capire se esiste una volontà politica di cambiarla.
Tutti i Paesi membri strumentalizzano più che mai il potere di veto per perseguire i propri interessi nazionali – se non addirittura personali, in alcuni casi – anche a scapito dell’attuazione della decisione strategica del 2022 per rilanciare l’allargamento e accettare la candidatura di nuovi Stati.
Per cambiare la prassi è necessario il consenso su un qualche tipo di accordo, questo è il problema. Spero che si raggiunga un’intesa sul fatto che non sono necessarie decine di decisioni per portare a termine il processo, ma che serve flessibilità, riducendo il numero di decisioni e insistendo sul dovere di cooperazione leale da parte di tutti i Paesi membri coinvolti.
Cosa potrebbe succedere se l’Ungheria di Orbán, per esempio, si opponesse?
In qualsiasi modo andrà, non sarà davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea che si concluderà la questione, semplicemente perché non esiste una legge dell’UE che l’Ungheria possa invocare contro il Consiglio o gli altri Stati membri, se questi decidono di proseguire i negoziati con l’Ucraina.
Al contrario – e questa è una cosa poco ricordata – gli Stati membri potrebbero decidere di portare l’Ungheria davanti alla Corte per abuso del diritto di veto, considerato che rende difficile mettere in atto una decisione presa dal Consiglio ai sensi dell’articolo 49.
Se la Corte di giustizia dell’UE dovesse davvero avere un ruolo in tutta questa vicenda, sarebbe piuttosto quello di determinare se l’Ungheria stia violando o meno il suo dovere di leale cooperazione ponendo il veto sul processo senza una giustificazione adeguata.
Si tratta insomma di volontà politica da parte degli altri Stati membri, e non credo che Orbán abbia molti strumenti a disposizione per impedire che il processo prosegua. Nella migliore delle ipotesi, potrebbe astenersi dal ratificare il Trattato di adesione alla fine del processo.
Ma allora la domanda è: come interpretare una mancata ratifica del Trattato di adesione? Si tratta di un semplice blocco all’allargamento dell’Unione europea, oppure è una più profonda decisione di non voler far parte di un’Unione allargata a un nuovo membro?
Cosa intende?
A livello giuridico e politico bisogna chiarire se un Trattato di adesione possa essere ratificato ed entrare in vigore senza la ratifica di tutti gli Stati membri. È possibile concepire un Trattato di adesione come un nuovo strumento di diritto primario che determina chi è uno Stato membro dell’Unione e chi non lo è?
In altre parole, bisogna interrogarsi se il rifiuto da parte di un Paese membro di ratificare il Trattato di adesione di un nuovo membro – per motivi che hanno ben poco a che vedere con l’allargamento dell’Unione – possa mettere in discussione la sua stessa adesione.
Se riusciamo a dare luce a questo tema, ciò potrebbe avere un grosso effetto sul clima dei negoziati. La posta in gioco non sarebbe solo l’allargamento dell’Unione europea, ma anche la conferma dell’adesione di tutti coloro che hanno partecipato ai negoziati del Trattato di adesione di un nuovo membro.
Nel frattempo, come si può superare lo stallo provocato dal governo Orbán ai danni dei negoziati dell’Ucraina?
Una delle opzioni sarebbe, appunto, passare dall’unanimità alla maggioranza qualificata per le fasi intermedie. Come dicevo, si può fare perché, trattandosi di una prassi, non è necessario modificare i Trattati. Questa proposta ha una certa attrattiva, ma si basa comunque sull’idea che siano necessarie tutte queste decisioni per aprire e chiudere ogni capitolo negoziale.
Finora non si contesta il fatto che uno Stato membro – l’Ungheria, come altri – ostacoli l’attuazione del processo di allargamento. Questo, a mio avviso, è il vero problema da affrontare. L’esercizio del diritto di veto nazionale è scollegato dal contesto stesso in cui viene esercitato.
In sintesi, il contesto è questo: è in atto un processo strategico dell’UE attivato da una decisione unanime del Consiglio ai sensi dell’articolo 49, ma che viene completamente ignorato dagli Stati membri nel contesto dei negoziati di adesione.
Il potere che gli Stati membri hanno nei negoziati deve essere collegato al fatto che stanno semplicemente attuando una decisione che hanno già preso. Sono dunque soggetti all’obbligo di cooperare per garantire il successo del processo, a condizione, ovviamente, che i candidati soddisfino le condizioni richieste. Il margine di discrezionalità è molto limitato per opporsi alla prosecuzione dei negoziati, se non per questioni puramente tecniche.
Il veto dovrebbe allora sparire?
Sì. Uno Stato membro dovrebbe fornire una giustificazione per dimostrare che la mancata apertura o chiusura del capitolo nazionale è il modo proporzionato per affrontare un problema. Dovrà quindi presentare valide ragioni per convincere gli altri Stati membri che è necessario interrompere il processo. Ma se gli altri Stati membri non sono convinti da queste ragioni, i negoziati dovrebbero proseguire.