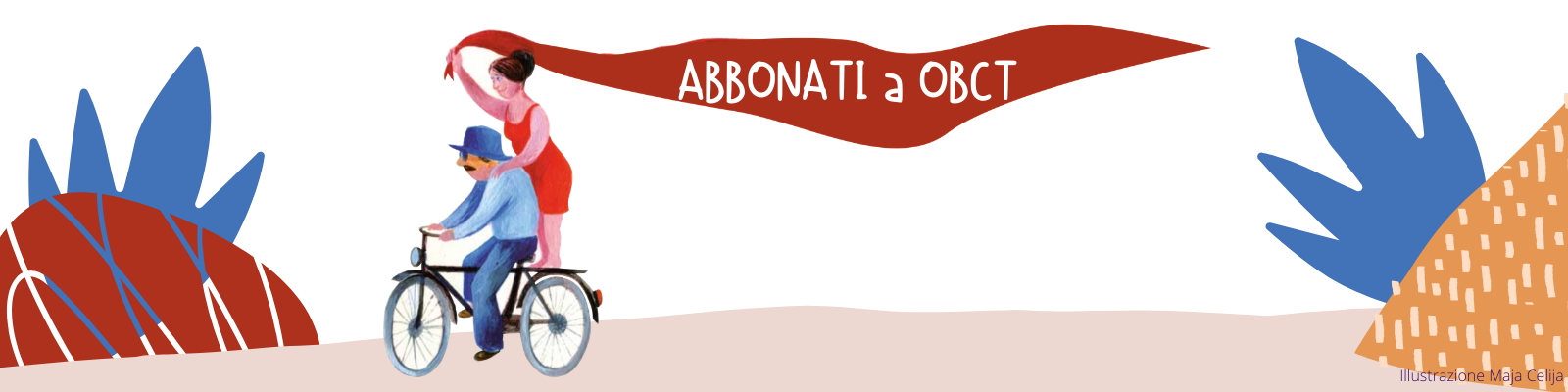Srebrenica, la pace dell’oasi Ekometa
Irvin Mujčić è dovuto fuggire da Srebrenica nel 1992 che era bambino. Dopo diversi anni di vita in Italia, ha deciso di tornare e realizzare un villaggio bucolico immerso nei boschi, nei pressi di Kasapić ai piedi del monte Kak. Nei giorni della commemorazione del luglio scorso, siamo andati a trovarlo

Srebrenica-la-pace-dell-oasi-Ekometa
Il villaggio Ekometa, Srebrenica luglio 2025 - © foto N.Corritore (OBCT)
Cosa ti ha spinto personalmente a tornare a Srebrenica e come ti è venuta l’idea di realizzare Ekometa?
La spinta più importante è arrivata nel 2014 quando lavoravo a Bruxelles per la Commissione europea su un progetto in specifico per il network europeo “Ternype ”, dedicato alla commemorazione del genocidio dei rom e sinti, nel 70esimo anniversario della liquidazione del “Zigeunerlager” ad Auschwitz Birkenau [avvenuta tra il 2 e 3 agosto del 1944, ndr].
Ritenevamo importante preservare quella memoria e collegarla anche a ciò che stava succedendo a livello politico in Europa, cioè la rinascita dei partiti nazionalisti e di estrema destra. Quindi anche con uno sguardo a che cosa può portare la spinta verso il nazionalismo, come ad esempio è accaduto a Srebrenica.
Abbiamo deciso di organizzare un piccolo gruppo di ragazzi, che ho accompagnato per partecipare alla “Marcia della pace” (Marš mira) che si tiene ogni anno in occasione della commemorazione del genocidio. Era il 2014, ed era era la prima volta che tornavo a Srebrenica dal 2007. Mi aspettavo di ritrovarla in condizioni migliori, invece era rimasta in una specie di limbo di decadenza sempre più marcato: meno abitanti, strutture fatiscenti, strade dissestate e così via.
Mi sono posto la domanda su quale ruolo potesse avere la mia generazione, cioè quella che è nata poco prima o durante la guerra degli anni Novanta e che ha avuto la fortuna di sfuggire al conflitto. Ho cominciato a sentire un dovere verso il luogo, verso la memoria e anche verso mio padre… e fare in modo che le persone non fossero morte invano.
Percepivo che se Srebrenica fosse stata lasciata morire, la cultura e l’ideologia nazionalista che era all’origine di quello che è accaduto avrebbero effettivamente vinto. Quindi ho deciso di lasciare il mio lavoro a Bruxelles e a dicembre del 2014 sono tornato a vivere qui.
Hai nominato tuo padre, che è tra gli scomparsi nel genocidio. Ad oggi avete qualche informazione su di lui?
Di informazioni ne abbiamo ricevute svariate: chi l’ha visto qui, chi l’ha visto là e via dicendo… in base alla testimonianza più attendibile, mio padre partì per la marcia [definita la “Marcia della morte”, in cui in circa 15mila tentarono di salvarsi fuggendo da Srebrenica e attraverso i boschi raggiungere la zona libera di Tuzla, ndr] ma poi decise di tornare indietro per rimanere alla base dei Caschi blu di Potočari. In trent’anni non è ancora stato trovato il suo corpo.
Quando hai deciso di tornare avevi già delle idee su cosa fare?
Diciamo che pensavo di sfruttare la mia esperienza e capacità di progettazione europea, sui cui ho lavorato per lungo tempo con focus su diritti umani e memoria. Nell’anno in cui mi sono dato per capire come indirizzare quelle idee e vedere di cosa avesse più bisogno un territorio come questo, ho avuto parecchio tempo libero.
Per cui, zaino in spalla ho fatto lunghi viaggi a piedi nella zona di Srebrenica, e sono rimasto colpito dall’immagine che tendenzialmente una persona non ha di questo luogo: i tanti boschi che la circondano, i piccoli villaggi immersi nella natura e ricostruiti dopo la guerra dove pochi ritornati ci abitano in maniera molto pacifica, accogliente e umana. Con persone che aprono le proprie porte e ti ospitano, ti offrono da mangiare e da dormire… Ma anche la bellezza del canyon del fiume Drina, del lago Perućac al confine tra la Bosnia e la Serbia.
Non potevo credere che Srebrenica fosse conosciuta esclusivamente per quello che è avvenuto nel 1995 e si scordasse tutto il resto. Non lo trovavo corretto nemmeno verso le persone che sono sopravvissute e sono tornate a viverci. Quasi dovessimo portare sempre addosso questo fardello, cioè il peso di essere nati, cresciuti e aver vissuto a Srebrenica.
Concettualmente consideravo sbagliato fermare la narrativa al 1995, o dopo quella data parlare solo del processo di identificazione con il DNA, delle fosse comuni e via dicendo, scordando di raccontare il processo di ritorno. Un capitolo molto importante – sebbene sia in gran parte fallito per tutta una serie di aspetti – anche solo per il fatto che tra le persone sopravvissute c’è stato chi ci ha provato. Mi sembrava giusto dare voce a tutto questo.
Contemporaneamente, il gruppo italiano "Amici della Natura ", che fa parte della rete internazionale “Naturefreunde ”, aveva deciso di provare qui un progetto. Io avevo già sviluppato una serie di cammini e trekking, collegando diversi villaggi del territorio di Srebrenica con il canyon. Così, le due idee si sono fuse e abbiamo avviato un progetto di turismo sostenibile.
Quali sono state le maggiori difficoltà, all’inizio e in seguito?
Un progetto del genere ottiene subito riscontro mediatico e le persone che hanno espresso più critiche sono state della Federazione e soprattutto della capitale. Addirittura, appena usciva su media nazionali un articolo sul fatto che si stava costruendo qui un eco-villaggio, venivano lasciati commenti molto negativi: del tenore “come si permette di far arrivare dei turisti accanto a un Memoriale con ottomila tombe”… o “trasformano il Memoriale di Potočari in un circo”. Ma anche da persone semplicemente scettiche, perché negli anni avevano visto tanti progetti arrivare ma poi non lasciare nulla dietro.
E quali lati positivi hai raccolto?
Dall’altra invece, una serie di famiglie qui intorno hanno dimostrato subito interesse. Sono le famiglie con le quali ho iniziato a collaborare e collaboro ancora oggi: dove organizzo i pranzi nelle loro case, contadini dai quali compro formaggi, uova, frutti di bosco, marmellate. Qui in zona come in altri luoghi attorno al canyon della Drina, nei trekking più lunghi che prevedono il pernottamento.
Certo, questo progetto non cambia radicalmente la loro situazione economica, però in qualche modo la migliora. Ad esempio, chi aveva le mucche non riusciva a vendere il latte e i suoi derivati come i formaggi, e avere dieci persone a dormire o a cena, ai quali offri i tuoi prodotti va a riempire il bilancio familiare di sussistenza.
Ma anche, non meno importante, “riempie” sul piano umano. Tutti questi momenti diventano occasione di scambio e costruzione di legami: si è ospitati da una famiglia, – e sappiamo che tendenzialmente i bosniaci sono molto ospitali – per cui si creano interazioni grazie alle quali persone ospitate e ospitanti diventano amiche e continuano a rimanere in contatto anche dopo. Ci sono persone che tornano per andare appositamente a trovare quella specifica famiglia conosciuta l’anno o mesi prima, durante il trekking.
Come sei stato percepito in loco, quando sei tornato?
Appena arrivato mi sono sentito “straniero nella mia città”. Ho ripreso possesso della casa di mio nonno ma non conoscevo nessuno, e nel fine settimana venivano ogni tanto solo mia zia o mio cugino da Tuzla.
Inizialmente le persone del luogo sospettavano che io fossi una spia. A casa di mio nonno non avevo internet e quindi andavo a connettermi al vecchio Motel Alić o al bar. Mi sentivano parlare in bosniaco, italiano, francese, inglese durante le diverse chiamate, ed era periodo pre-elettorale… per cui si erano fissati su questa idea. Addirittura, un ragazzo con cui poi ho fatto amicizia mi ha raccontato che per un periodo avevano cominciato a seguirmi per vedere dove andavo e cosa facevo! Finché mio cugino ha spiegato loro chi ero. Le persone più anziane si sono ricordate di mio padre che giocava nella squadra Guber ed era stato allenatore dei cadetti, così hanno collaborato a mettere gli animi in pace…
Poi è andata meglio?
Sì, mi sono riconnesso con il luogo e le persone. Sebbene sia rimasto etichettato come “l’italiano” per come parlo il bosniaco, con forte accento bresciano o per come sbaglio la grammatica perché è una lingua che non ho mai studiato. Ma anche perché è rimasta una sorta di divario tra chi abita qui e chi vive all’estero, la diaspora viene percepita in un’altra maniera: persino coloro che sfollati a forza ai tempi oggi vivono a Sarajevo o Tuzla, qui vengono chiamati – con accezione negativa – “vikendaši”, cioè persone che vengono nel week end.
Quando hai piantato il primo legno nel tuo villaggio Ekometa in mezzo a dei boschi?
Il primo legno è nato assieme all’idea ma potrei dire dal 2016, quando ho deciso che ogni anno mi sarei fatto un regalo con il quale volevo compensare il fatto che non avevo avuto un’infanzia normale. Così, ad un compleanno mi sono regalato un cavallo, che avevo sognato come la maggior parte dei bambini, che ho chiamato Charlotte. A cui si è aggiunta la puledra Chanel e l’ultimo, uno stallone, chiamato Chisco che poi ho deciso di liberare nel branco di cavalli selvatici nella valle di Livno.
Nell’arco di due anni, le attività hanno cominciato a raccogliere molto interesse, il numero delle richieste a partecipare ai trekking era salito tanto, per cui ho deciso di fare un altro passo, costruire un centro nella natura, che nel suo piccolo diventasse un luogo di pace nel senso più ampio del termine: pace tra gli esseri umani, pace con la natura, pace con se stessi, armonia con ciò che ti circonda.
Quante persone sono passate da Ekometa e cosa ti aspetta nel futuro prossimo?
Ad oggi, in media passano circa duemila persone all’anno, tra chi viene per brevi periodi e chi resta più a lungo. Organizziamo anche dei campi di lavoro. D’estate si tengono residenze di fotografia, di scrittura, abbiamo poi progetti con scuole superiori soprattutto italiane… Quest’anno, ad agosto, ho previsto un trekking di una settimana lungo il canyon della Drina, che intreccia la parte naturalistica a quella storica, sia del periodo della lotta partigiana nella Seconda guerra mondiale, sia del periodo dell’ultima guerra. Un posto meraviglioso dal punto di vista paesaggistico, praticamente non battuto.
Ogni anno a settembre organizziamo anche un campo per giovani architetti che vengono principalmente dalla Facoltà di Dresda: rimangono un mese, ci aiutano nella costruzione delle casette con metodi tradizionali, e a loro vale come credito formativo.
Perché hai scelto proprio questo luogo, dove siamo ora mentre parliamo?
Perché è molto particolare. Si sviluppa lungo il fiume Jadar, importante anche sul piano storico per questa zona: vi correva la linea del fronte dell’ultima guerra e lungo il fiume c’erano allora tanti mulini che sono stati usati per produrre farina o riconvertiti per produrre elettricità.
Perché è un luogo completamente immerso nel bosco, dove c’era il piccolissimo villaggio di Kasapić che durante la guerra è stato completamente raso al suolo e dove non è tornato a vivere praticamente nessuno.
Quindi un luogo simbolico, dove è importante ricostruire “dalle ceneri” di quello che è stato e anche riappacificarci con il passato. Vedendo che da ciò che è stato distrutto non solo può ricrescere qualcosa di nuovo ma che da quell’esperienza possiamo far nascere e crescere concetti positivi.
Irvin Mujčić è il protagonista del documentario "Il ragazzo della Drina" del regista bosniaco Zijad Ibrahimović, di cui OBCT ha scritto nell’aprile scorso.
La fuga da Srebrenica nel 1992 e l’arrivo in Italia, è raccontata dalla sorella Elvira nella nostra intervista realizzata nel 2024.
Vai alla galleria fotografica di Nicole Corritore, dedicata a Ekometa, del luglio 2025.