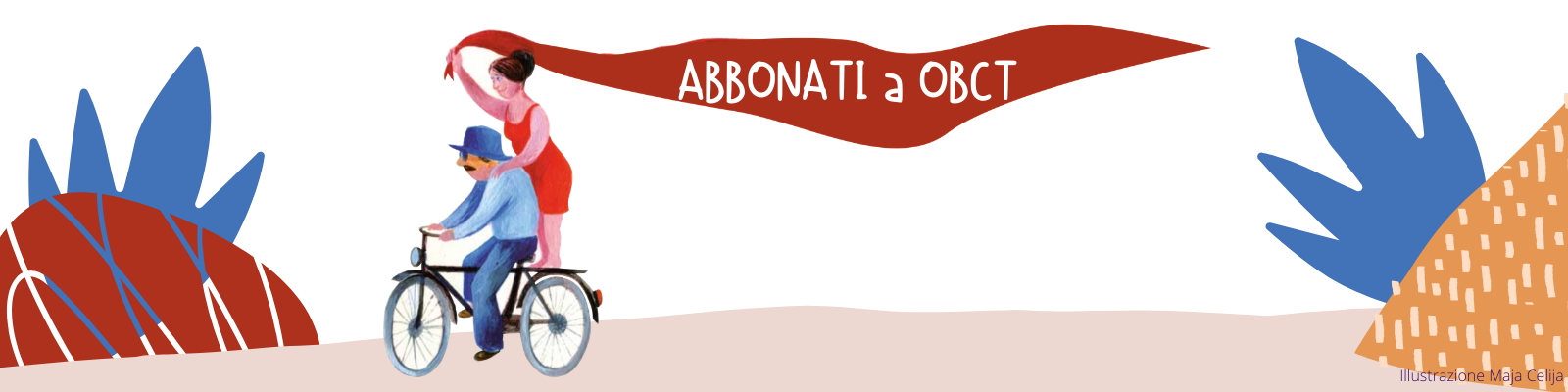Segreti tossici sotto le acque
Costanza, Danzica, Klaipėda, Ejsberg. Sono alcune delle città costiere europee che stanno conoscendo importanti lavori di espansione delle loro strutture portuali, a fronte di gravi danni ambientali

Segreti-tossici-sotto-le-acque
Un vecchio sito di scarico in Danimarca, chiuso a seguito di pressioni politiche. © Jan Henningsen
All’ombra dei progetti di espansioni portuali da miliardi di euro in tutta l’Unione europea, un disastro ambientale si consuma silenziosamente sotto le acque. Negli ultimi giorni del 2024, il porto di Costanza, in Romania, ha indetto una gara d’appalto per l’assegnazione di un importante progetto di dragaggio, per un valore complessivo di 93 milioni di euro, metà dei quali finanziati da fondi UE. Il progetto interesserà un’area di 250 ettari. È però lecito chiedersi dove possano essere smaltite le enormi quantità di sedimenti che si prevede di rimuovere.
Il progetto del porto di Costanza si inscrive in un più ampio contesto caratterizzato da ambiziosi ampliamenti portuali sostenuti dall’UE, destinati a trasformare le coste europee: il Terminal T3 di Danzica, in Polonia, con la sua banchina di 717 metri, recentemente completata; il porto lituano di Klaipėda, interessato da un progetto di ammodernamento per un valore complessivo di 308 milioni di euro, e il porto di Ejsberg, in Danimarca, la cui capacità è stata aumentata anche grazie ai finanziamenti UE per 32,1 milioni di euro.
Tutti i progetti di cui sopra richiedono un dragaggio intensivo, cioè l’estrazione di sedimenti dai fondali marini, indispensabile per l’espansione dei porti europei.
Dietro a questi investimenti, presentati dai funzionari europei come catalizzatori di prosperità economica e sviluppo sostenibile, si nasconde però una realtà molto più complessa.
I sedimenti di dragaggio, spesso saturi di contaminanti, non spariscono nel nulla. Le lacune normative consentono alle aziende di riversare sostanze tossiche direttamente nel Mar Baltico e nel Mar Nero, oppure nelle discariche portuali e nei terminal stessi.
La situazione è però destinata a peggiorare ulteriormente. Gli stati membri, dopo diversi cicli di negoziati, hanno infatti approvato delle deroghe che indeboliscono la Direttiva quadro sulle acque, la norma fondamentale dell’Unione per la tutela della qualità delle acque costiere. Le modifiche provvisoriamente concordate legalizzano il degrado a breve termine della qualità dell’acqua, consentendo pratiche di dragaggio e, più in generale, lo scarico in mare di sedimenti contaminati.
Con una supervisione minima da parte delle ong e una scarsa attenzione scientifica specifica sugli impatti del dragaggio e dello scarico, una delle forme di inquinamento marino più diffuse in Europa continua ad aggravarsi, lontano dagli occhi dell’opinione pubblica.
Un’eredità tossica sotto i nostri porti
I sedimenti portuali sono vere e proprie capsule del tempo, che accumulano inquinanti per anni, creando quelli che oggi gli scienziati marini identificano come hotspot pericolosi lungo le coste continentali.
“Stiamo trovando metalli pesanti e inquinanti organici, tra cui pesticidi agricoli”, spiega Agnieszka Jędruch, chimica ambientale marina specializzata in contaminazione dei sedimenti all’Istituto di oceanologia dell’Accademia polacca delle scienze.
Il quadro della contaminazione è in continua espansione. “Oggi ci sono nuovi tipi di inquinanti, utilizzati per lo sviluppo di nuove tecnologie, comprese batterie solari e auto elettriche”, sottolinea Jędruch. “Quindi, un cocktail non proprio piacevole di diversi tipi di inquinanti”.
Utilizzando attrezzature di dragaggio per ampliare porti e corsie di carenaggio, le autorità portuali stanno riaprendo quelle capsule del tempo. Gli scavi spostano strati di sedimenti che per decenni hanno efficacemente assorbito sostanze nocive, e questo “cocktail” viene poi scaricato in acque non contaminate.
La posta in gioco è alta. “Questi contaminanti non scompaiono semplicemente una volta mossi”, afferma Jędruch. "A volte nei sedimenti si trovano tracce di contaminazione risalenti a centinaia di anni fa. Quindi, quando uno strato viene spostato, un’enorme quantità di inquinanti rientra nell’acqua”.
La conclusione di Jędruch è chiara. “Dovremmo disturbare questi sedimenti il meno possibile e impedire assolutamente la loro dispersione su larga scala negli ecosistemi marini”.
Tuttavia, l’approccio europeo alla gestione di questa crescente minaccia rimane frammentato. La Direttiva UE sugli standard di qualità ambientale del 2008 stabilisce limiti vincolanti volti a mantenere le sostanze nocive al di sotto dei livelli di pericolo. Vi è però un punto critico: i limiti sono obbligatori per i "corpi idrici" (cioè le masse d’acqua), ma facoltativi per i sedimenti. Di conseguenza, non esiste una politica armonizzata a livello UE per i livelli di contaminanti nei materiali dragati.
Gli stati membri sono liberi di stabilire soglie nazionali di contaminazione dei sedimenti destinati allo scarico in mare o sulla terraferma. Gli standard variano molto da un paese all’altro, sia in termini di quali sostanze vengono misurate, sia di valori limite. A peggiorare la situazione, molte soglie nazionali sono state stabilite oltre un decennio fa e non sono mai state aggiornate, nonostante i progressi scientifici. Gli standard della Romania risalgono al 2006, quelli della Danimarca al 2008 e quelli della Polonia al 2015.
Le disparità che ne risultano sono impressionanti. Solo la Danimarca e la Lituania hanno valori soglia per il TBT, una sostanza chimica che altera gli ormoni, un tempo ampiamente usata nelle vernici per navi prima di essere vietata, nonostante fosse diffusa nelle acque europee. La Romania e la Polonia invece non hanno stabilito alcun limite per il TBT. Per il PCB, un altro contaminante sintetico, gli standard variano notevolmente: la Romania e la Lituania ad esempio applicano soglie molto più stringenti rispetto alla Danimarca e alla Polonia.
Questa frammentazione normativa scoraggia gli ambientalisti. Se molte ong a livello europeo e nazionale – tra cui le sedi nazionali romena e polacca di Greenpeace e la Fondazione Mare – non si occupano nemmeno della contaminazione dei sedimenti, quelle che lo fanno lanciano l’allarme.
Codruța Savu, responsabile delle politiche del WWF Europa, spiega che le attuali valutazioni in tutta l’UE si basano ancora in larga misura sul monitoraggio di una gamma ristretta di inquinanti, principalmente metalli pesanti e IPA (idrocarburi policiclici aromatici, inquinanti che si formano durante la combustione incompleta di materiale organico). “Per quanto importanti, tali indicatori non tengono conto delle sempre più numerose evidenze scientifiche su nuove sostanze bioattive individuate dalla scienza”, sottolinea Savu.
Un esempio paradigmatico è quello del porto di Danzica, dove i recenti lavori di dragaggio hanno portato alla luce materiali contaminati da idrocarburi, nichel e rame in quantità superiori agli standard stabiliti dalla legislazione nazionale in materia di acque, che li rende inadatti al reinserimento in mare. Pratiche analoghe, dove le sostanze tossiche in quantità superiori a quelle consentite vengono scaricate in mare, si osservano anche in Lituania e Danimarca.
“Un tempo, vicino al sito di dragaggio, c’erano cantieri navali”, spiega Łukasz Jabłonowski, responsabile dell’Unità idrotecnica del Porto di Danzica. “Il rame era probabilmente un ingrediente per la verniciatura delle navi. È stato depositato lì per decenni e si è accumulato. Ora che è stato individuato, dobbiamo trovare un altro modo per rimuovere o smaltire il materiale dragato contaminato”.
Le autorità portuali di Danzica intendono sottoporre nuovamente a test i campioni dragati, nella speranza che i livelli di contaminazione risultino inferiori a quelli inizialmente misurati, in modo da poter trasportare parte del materiale nel sito di scarico in mare.
Quanto invece allo smaltimento a terra del materiale dragato contaminato, si tratta di una pratica costosa. In Polonia, Jabłonowski stima che lo smaltimento di un metro cubo di sedimenti contaminati costi dai 250 euro in su, a seconda della quantità e del tipo di contaminazione. Una cifra decisamente superiore ai 50-70 euro al metro cubo necessari per lo scarico di materiale dragato conforme agli standard nazionali in aree designate in mare, come confermato da Jabłonowski sulla base dell’attuale contratto del porto.
L’impatto dello scarico in mare
Gli scienziati concordano su un punto: indipendentemente dai livelli di contaminazione, lo scarico in mare non dovrebbe mai avvenire.
L’impatto dello scarico sulla vita marina è devastante, spiega Florin Timofte, direttore generale dell’Istituto romeno per la ricerca e lo sviluppo marino.
“I contaminanti entrano nella catena alimentare, dagli organismi più piccoli a quelli più grandi”, dai batteri ai mammiferi marini e agli esseri umani, sottolinea Timofte. “Per questo ci opponiamo fermamente allo scarico di metalli e sedimenti contaminati in mare”.
Aleksandra Zgrudno dell’Università di Danzica ha dedicato anni allo studio del recupero degli ecosistemi nel Golfo di Danzica. Nel giugno 2023 ha assistito alle conseguenze dello scarico di sedimenti durante i lavori di ampliamento della spiaggia collegata al canale di accesso al porto di Gdynia.
La scienziata paragona lo scarico in mare a “una valanga, seppur più lenta”, poiché i sedimenti si spostano sempre più in profondità nel mare.
Durante le sue immersioni, Zgrudno ha osservato cambiamenti allarmanti. “Non ho visto né filtratori né vongole, solo gusci morti. Tutti i piccoli crostacei filtratori che un tempo prosperavano qui in gran numero sono scomparsi. Anche la popolazione ittica è diminuita drasticamente. Ci sono molti meno pesci di prima. Un tempo c’erano molte specie di piccole dimensioni come gli spinarelli, ma ora ne sopravvivono solo pochi".
La scomparsa di questi habitat è una perdita che Zgrudno considera “irrecuperabile”.
Gli effetti ambientali sono percepiti in prima persona anche da chi dipende dal mare per il sostentamento. Martin Fønsskov, pescatore danese con 45 anni di esperienza nello Stretto di Øresund, racconta i disagi causati dallo scarico di rifiuti.
“L’ultima volta che hanno scaricato i rifiuti, ho dovuto navigare più lontano da dove pesco di solito. Quindi ho consumato più carburante, danneggiando la mia attività”, spiega Fønsskov. “Non posso pescare nei miei punti abituali durante le attività di scarico, perché un fango scuro e viscido si deposita nelle reti e i pesci le evitano”.
Tuttavia, le conseguenze dello scarico possono manifestarsi anche a distanza di decenni, perché questi processi richiedono tempo, afferma Vassilios S. Tselentis, professore di scienze marine presso l’Università del Pireo.
Il dragaggio continua
Nonostante le crescenti prove di danni ambientali, il dragaggio e l’espansione dei porti continuano in tutta Europa, spinti da priorità economiche e di sicurezza che rendono questa pratica quasi impossibile da fermare.
La realtà è semplice: il commercio marittimo moderno richiede porti con fondali più profondi. "Lo sviluppo dei porti marittimi va di pari passo con lo sviluppo economico", spiega Luis C. Blancas, esperto senior di trasporti e logistica presso la Banca Mondiale. Il dragaggio garantisce la navigabilità dei porti, consentendo a navi di tutte le dimensioni di accedervi, sostenendo al contempo il commercio internazionale, la creazione di posti di lavoro e la competitività nazionale.
Anche l’unico porto marittimo della Lituania evidenzia la necessità di espansione. Nonostante contribuisca per oltre il 6% al PIL nazionale, la profondità del porto è limitata a 16 metri, inferiore agli standard di mercato (17 metri).
“Se ampliassimo il porto, perderemmo l’opportunità di caricare tutte le navi con pescaggi maggiori, che dominano sempre di più il mercato marittimo globale”, spiega Algis Latakas, direttore dell’Autorità portuale di Klaipėda.
I porti sono fondamentali anche per la sicurezza energetica. Avendo interrotto le forniture di gas naturale russo a seguito all’invasione dell’Ucraina nel 2022, la Lituania ora dipende interamente dal suo enorme terminale di gas naturale liquefatto (GNL) “Independence”, che serve anche l’Estonia e la Lettonia.
La Polonia ha intrapreso un percorso analogo con il terminale GNL di Świnoujście, inaugurato nel gennaio 2025, che ha consentito al paese di diversificare l’approvvigionamento, riducendo la dipendenza dal gas russo.
La dimensione militare aggiunge un ulteriore livello di complessità. “Il porto di Klaipėda è di fondamentale importanza per garantire la mobilità dell’esercito”, afferma Darius Antanaitis, esperto militare e maggiore in pensione delle Forze armate lituane.
Le strategie militari dipendono dalla capacità dei porti di facilitare il rapido dispiegamento di truppe e attrezzature. Queste capacità richiedono il mantenimento di profondità adeguate attraverso operazioni di dragaggio.
Discariche alternative?
Per quanto importante per l’economia e le esigenze militari, lo scarico in mare dei sedimenti provoca quindi gravi danni ambientali, e alcuni porti europei cominciano a rendersene conto.
In Danimarca, alcuni grandi porti stanno abbandonando la pratica di scaricare in mare il materiale dragato. Nel 2024, a Middelfart il consiglio comunale ha deciso di revocare un permesso di scarico appena approvato per il porto turistico per “proteggere l’ambiente marino nel Parco naturale di Lillebælt”, spiega il politico locale Jacob Bjørnskov Nielsen, che è anche presidente della Commissione per il clima, la natura e il riciclo.
Il comune per ora ha deciso di sospendere le operazioni di dragaggio, stanziando fondi per cercare soluzioni alternative, non appena sarà necessario dragare di nuovo. “Siamo disposti a spendere di più per trovare strade alternative”, afferma Bjørnskov Nielsen.
Resta però una domanda fondamentale: come gestire il materiale dragato che non viene scaricato in mare?
La strada più ovvia, ovvero lo stoccaggio del materiale in siti designati sulla terraferma, presenta sfide notevoli.
Nel porto di Costanza, in Romania, ad esempio, i sedimenti dragati vengono utilizzati per la costruzione di infrastrutture portuali senza alcuna decontaminazione. Il materiale dragato viene mescolato con cemento e altri leganti per formare enormi blocchi di calcestruzzo.
Anna Noren, ricercatrice presso l’Università di Technologia Chalmers, in Svezia, esprime preoccupazione rispetto a questo metodo, avendo partecipato a un progetto analogo nel porto di Göteborg.
“C’è stato un piccolo rilascio iniziale di TBT, che è diminuito nel tempo, suggerendo che gli inquinanti potrebbero essere parzialmente intrappolati nella miscela di cemento, e che poi possano degradarsi gradualmente”.
Queste perdite potrebbero verificarsi anche con altri contaminanti. “Alcuni composti si posso degradare naturalmente, mentre i metalli resistono per un tempo indefinito – sottolinea Niren – e non possiamo sapere come si comporteranno nei prossimi diecimila anni”.
Inoltre, questo approccio utilizza solo una piccola parte del materiale dragato contaminato, sollevando interrogativi sul destino dei sedimenti restanti. “Il mio contatto al porto mi ha detto che il volume che abbiamo trattato proveniva da due sole operazioni di dragaggio”, spiega Noren. “Cosa faremo con il materiale rimanente in futuro? Non possiamo continuare a espandere i terminal portuali all’infinito, e questo materiale non è adatto all’edilizia abitativa”.
Oltre alla separazione dei materiali, Noren sta esplorando anche modi per recuperare risorse preziose dai sedimenti dragati. “Alcuni metalli che troviamo nei sedimenti, come il rame, sono molto importanti”.
Il team di Noren sta studiando metodi come il lavaggio dei sedimenti, in cui vengono utilizzate sostanze chimiche per estrarne i metalli. L’esperta mette però in guardia sul fatto che il recupero non è quasi mai semplice. “Anche quando i livelli di metalli sembrano alti, potrebbero essere saldamente legati ai sedimenti e non essere in realtà dannosi, né facili da rimuovere. A volte, cercare di ‘risolvere’ il problema può peggiorarlo”.
Sporche regole
Pur comportando un impatto ambientale tutt’altro che insignificante, lo scarico di materiale dragato in mare e sulla terraferma rimaneva in gran parte non regolamentato.
I controlli si basavano sulla Direttiva quadro sulle acque (DQA) e sulla Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, che però non stabiliscono limiti vincolanti specifici per il dragaggio e lo scarico in mare. La Direttiva sulle acque prevede che tutte le acque superficiali – fiumi, laghi e coste – raggiungano un “buono” stato entro il 2027.
Non esistevano leggi UE specifiche che affrontassero direttamente la questione.
Almeno fino a quest’anno, quando sono iniziati i negoziati per affrontare per la prima volta il problema dello scarico in mare dei materiali di dragaggio direttamente nella legislazione dell’UE: non come attività da limitare, ma come deroga alle norme sulla protezione dell’ambiente. Una delle proposte puntava a consentire il deterioramento temporaneo della qualità dell’acqua, mentre l’altra a permettere il trasferimento dei sedimenti, a condizione che non vi sia un “aumento netto” dell’inquinamento.
A settembre 2025, dopo diversi cicli di negoziati, le istituzioni UE hanno raggiunto un accordo provvisorio su tali deroghe. Queste misure mettono direttamente in discussione uno dei principi fondamentali alla base della Direttiva quadro sulle acque: il principio di non deterioramento, secondo cui nessuna attività dovrebbe peggiorare lo stato di un corpo idrico.
Secondo Per Clausen, europarlamentare che ha rappresentato la Sinistra nei negoziati, “è un accordo che stiamo stipulando a malincuore”, poiché un ulteriore ritardo nei negoziati avrebbe comportato che passassero “altri sei anni prima di poter modificare nuovamente le norme”.
Mentre il Parlamento europeo e la Commissione facevano pressione per approvare norme più severe, i paesi membri in seno al Consiglio hanno spinto per una maggiore flessibilità. Le proposte del Consiglio miravano a consentire un degrado a breve termine dei corpi idrici e a legalizzare il “trasferimento dei sedimenti”, a patto che se non vi fosse stato un “aumento netto” dell’inquinamento.
Queste deroghe recentemente approvate, di fatto, danno il via libera agli operatori che si occupano di scarico.
Le modifiche proposte si ispirano a un documento presentato da Paesi Bassi, Germania, Danimarca, Finlandia e Lussemburgo, in cui si afferma che le attività di scarico di materiale dragato che “si limitano a spostare l’inquinamento già esistente” non violano la Direttiva quadro sulle acque. Il documento sostiene inoltre che siccome le sostanze PBT nocive (persistenti, bioaccumulabili e tossiche) superano già i limiti legali in molte aree, la direttiva impedisce attività che non aumentano l’inquinante complessivo.
Per Søren Laurentius Nielsen, biologo dell’Istituto di oceanologia di Copenaghen, questa argomentazione non regge, perché “il dragaggio aumenterà la mobilità delle sostanze nocive nei sedimenti e alcune sostanze, una volta scaricate, potrebbero subire reazioni chimiche, diventando più dannose per gli esseri umani e gli animali”.
L’accordo provvisorio deve ora essere formalmente approvato sia dal Consiglio europeo che dal Parlamento europeo. Una volta adottato, gli Stati membri avranno tempo fino a dicembre 2027 per recepire la direttiva aggiornata nella legislazione nazionale.
Accettando tali deroghe, l’UE ha di fatto aperto a un aumento delle attività di dragaggio, in assenza di garanzie più solide. Il rischio è un aumento dell’inquinamento, mascherato da cavilli tecnici. Per chi ha a cuore l’ambiente marino europeo, la vera battaglia inizia ora.
Questa inchiesta è condotta in collaborazione con Delfi.lt, Noir e Ingeniøren ed è finanziata dal progetto CIJI .