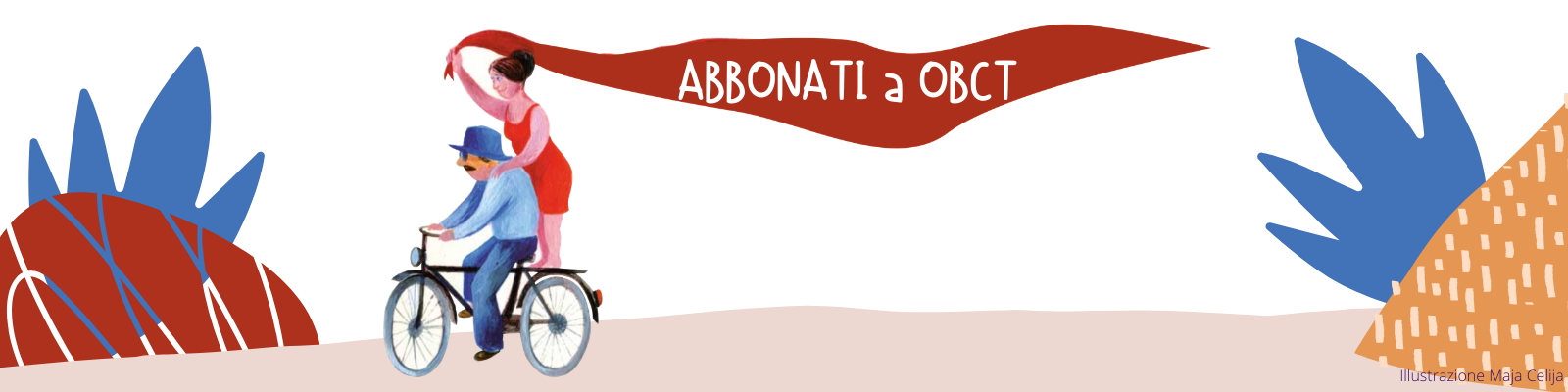Peter Lippman: attivismo dal basso per fare rete e resistere
Giornalista e attivista statunitense, Peter Lippman è un profondo conoscitore della Bosnia Erzegovina. Da anni segue la situazione politica e post bellica di questo paese. Di recente è particolarmente interessato ai movimenti ambientalisti che animano l’intera regione

Peter-Lippman-attivismo-dal-basso-per-fare-rete-e-resistere
Peter Lippman (archivio personale)
Peter Lippman, statunitense, giornalista, scrittore e attivista per la pace, nel suo libro Surviving the Peace: The Struggle for Postwar Recovery in Bosnia-Herzegovina (Vanderbilt University Press, 2019) documenta le infinite sfide del ritorno dei profughi nei luoghi delle stragi di civili durante la guerra in Bosnia Erzegovina. Lippman scrive da una prospettiva personale, con un linguaggio giornalistico preciso e accurato, svelando le cause, i protagonisti e le dinamiche più ampie delle ingiustizie che hanno segnato la tragedia bosniaca.
Senza essersi mai allontanato da questi territori per lunghi periodi di tempo, Lippman torna nel 2024 con un nuovo progetto: una serie di testi sugli attivisti ambientali e le minacce all’ambiente in Bosnia Erzegovina. L’autore si concentra sulle nuove lotte dei cittadini della BiH che si battono per una vita dignitosa nel proprio paese e sulla resistenza alle dinamiche dell’economia globale in un mondo travolto dalle guerre per le risorse. Il reportage è stato pubblicato sul portale LeftEast ed è una storia ancora aperta.
L’impegno pacifista per Lippman è stato una scelta spontanea e incondizionata. Sin da ragazzo, ha osservato con stupore un mondo scosso dai movimenti anticoloniali. A plasmarlo è stata però la guerra del Vietnam. Con i suoi tre fratelli, ha trascorso l’adolescenza nelle strade di Seattle, protestando contro le politiche dei presidenti americani Johnson e Nixon. Da allora, si è sempre interessato di zone di guerra, cercando di occuparsene da una prospettiva intima, consapevole del male che i conflitti portano all’umanità.
Il suo talento per la scrittura si concretizza intrecciandosi spontaneamente con il suo impegno pacifista, che spazia dalla partecipazione alle mobilitazioni degli anni ‘60 negli Stati Uniti all’impulso a seguire i sanguinosi tumulti in Medio Oriente nei primi anni ‘90, passando per il sostegno agli oppositori delle dittature in America Latina.
L’esperienza balcanica di Lippman inizia negli anni ‘80 e quella bosniaca un decennio dopo, quando incontra una famiglia di profughi che, fuggendo dall’inferno della guerra, trova rifugio a Seattle. Questa vicenda spinge Lippman a impegnarsi in attività e iniziative pacifiste, aiutando i profughi a stabilirsi nella loro nuova patria, sostenendo con fervore un intervento più deciso degli Stati Uniti contro la guerra in Bosnia Erzegovina. Ha soggiornato più di venti volte in BiH, raccogliendo storie sulla costruzione della pace e la società civile in un contesto post-conflittuale.
Abbiamo incontrato Peter Lippman per parlare di una lotta tra Davide e Golia, ossia delle sfide che devono affrontare i movimenti civici in BiH contro le multinazionali, l’estrattivismo e la corruzione, ma anche della speranza che questo mondo diventi un posto migliore per le generazioni future.
Sarebbe interessante partire provando a tracciare un legame tra musica e pacifismo. Qual è il filo che lega la sua passione per il folklore e la musica – una passione sviluppata sin dalla tenera età – e il suo impegno pacifista?
Per me, sono due mondi interconnessi. La mia famiglia aveva sempre coltivato un interesse per il folklore ed ero affascinato da ricerche etnografiche. Sin da giovanissimo, proprio grazie alle danze popolari, avevo capito che esistevano altre lingue e musiche meravigliose, soprattutto quelle dell’est Europa orientale, terra di origine dei miei nonni. Avevo promesso a me stesso che avrei studiato le lingue. All’età di dieci anni avevo imparato l’alfabeto cirillico solo perché lo trovavo figo.
I valori coltivati nella mia famiglia (mia madre era un’assistente sociale e mio padre si batteva per i diritti delle persone con disabilità) avevano influenzato le nostre convinzioni politiche. Quando avevo quindici anni protestai contro la guerra in Vietnam insieme ai miei fratelli. Fu però il folklore a togliermi dalla strada.
Successivamente, da membro di un gruppo di danza popolare, visitai la Jugoslavia, la Bulgaria e la Romania. Nel 1981 mi fermai a Novi Sad, rimanendovi un anno per studiare la lingua e la tamburica [piccolo liuto a collo lungo]. Grazie a questo legame iniziale con la Jugoslavia, rimasi emotivamente coinvolto nelle vicende di quei territori, seguendone gli sviluppi a partire dagli anni ‘80. Ben presto la mia vocazione politica prevalse su quella etnografica, anche se continuo a suonare la musica balcanica, turca e klezmer.
Durante i suoi studi in America, ai tempi della guerra in Bosnia Erzegovina, lei conobbe una famiglia di profughi bosniaci, iniziando così il suo impegno umanitario al fianco di chi negli Stati Uniti aveva trovato una nuova casa. Fu questa esperienza a spingerla ad esplorare la Bosnia Erzegovina?
Queste persone stavano vivendo esperienze terribilmente traumatiche e avevo capito che a volte ascoltare era la cosa migliore da fare. Così si era riacceso il mio interesse per la Bosnia. Volevo tornarci. Avevo terminato gli studi e, appena finita la guerra, ero arrivato a Tuzla, iniziando a lavorare per una piccola organizzazione umanitaria “Djeca u krizi” [Bambini a rischio].
In quel periodo, a Tuzla giungevano le persone di Srebrenica. Per me, stare accanto a quelle donne forti, perlopiù vedove di Srebrenica, era stata un’esperienza molto intensa, come scrivo nel mio libro. A Sarajevo poi avevo lavorato come traduttore per l’agenzia di stampa Onasa.
Ero tornato negli Stati Uniti nella primavera del 1999, rimanendo però legato alla Bosnia Erzegovina, anche attraverso un progetto di advocacy lanciato a Washington. In quel periodo, mi ero avvicinato ad alcune iniziative di attivismo dal basso, capendo che il periodo post-bellico in Bosnia Erzegovina sarebbe stato segnato dal ritorno dei profughi. La popolazione ritornava coraggiosamente nei villaggi distrutti nell’area di Zvornik, Prijedor e Kozarac. Durante la grande battaglia di Seattle contro il WTO, invece che nella mia città natale, ero accanto agli sfollati nei campi intorno a Goražde.
Per lei era stata un’esperienza traumatica? Come aveva reagito agli eventi di quel periodo?
Erano tempi turbolenti, ma non come in Kosovo. Il 1999 doveva essere l’anno del ritorno, poi però si erano susseguiti diversi eventi, le decisioni riguardanti Brčko e la rimozione di Nikola Poplašen dall’incarico di presidente della Republika Srpska. A destabilizzare ulteriormente la situazione l’intervento della NATO in Serbia.
Può raccontarci cos’era successo in Kosovo?
Durante le proteste studentesche del 1997, un mio amico, attivista pacifista di San Francisco, che conosceva Albin Kurti, all’epoca un giovane ribelle, attualmente primo ministro del Kosovo, mi aveva invitato a partecipare alle manifestazioni insieme ad un gruppo di giornalisti e attivisti, per seguire e documentare quegli eventi turbolenti. Era appena scoppiata la rivolta dell’Esercito di liberazione del Kosovo (UÇK) contro il regime serbo, che aveva abolito la lingua albanese nelle scuole kosovare. Dopo lo sterminio della famiglia di Adem Jashari [leader dell’UÇK] la situazione era precipitata.
Degli undici interessati, solo noi sei – cinque uomini e una donna – eravamo andati in Kosovo, rimanendovi alcune settimane e parlando con entrambe le parti. Volevo tornare a Sarajevo il 30 marzo e fare una telefonata a mia madre. Tuttavia, mi avevano trasferito a Mitrovica, dove ero stato condannato ad una pena di dieci giorni da scontare nel carcere di Pristina. Ero però riuscito ad evitare la pena, grazie a interventi esterni, quindi tre giorni dopo la sentenza mi avevano portato al confine con la Macedonia a bordo di un’auto della polizia. Per me si era rivelata un’esperienza positiva, un rischio che aveva prodotto una riflessione interessante.
Torniamo in Bosnia Erzegovina. Dopo la guerra, lei ha seguito i movimenti civici attivi in tutto il paese. Cosa ha contraddistinto questi movimenti?
Il dopoguerra è stato caratterizzato da diverse campagne di ritorno dei profughi. A guidare queste iniziative, molto sentite, sono state alcune persone istruite di Tuzla, Goražde, Doboj e altre città, spesso avvocati, aiutando i profughi a tornare nelle proprie case. Esisteva anche una coalizione per il ritorno, a livello nazionale, con sezioni in molte città in entrambe le entità [costitutive della BiH].
Ho visto donne molto attive e forti, donne che bloccavano le strade e sfidavano i rappresentanti della comunità internazionale. Sapevano come utilizzare i media e coinvolgere l’opinione pubblica internazionale. Sapevano anche come sfruttare questi mezzi per evitare che le loro richieste venissero ignorate. In quel periodo, erano attivi anche alcuni movimenti per preservare la memoria degli orrori accaduti a Prijedor, Srebrenica e in altri luoghi.
Stavo riflettendo sul momento in cui questo "dopoguerra" è diventato qualcos’altro. Per molto tempo questo non è stato possibile, perché nel sistema di Dayton c’erano ostacoli che dividevano la popolazione. Una dinamica che andava a vantaggio dei leader militari e dei loro rappresentanti politici. La guerra però era ancora presente nelle menti delle persone, vittime di manipolazioni psicologiche da parte dei leader che volevano dividere la popolazione, pur collaborando molto bene tra loro.
Come si sono esauriti i movimenti civici di quella Bosnia Erzegovina del “dopoguerra”? Come vede gli attuali movimenti in BiH che si oppongono ad alcuni progetti nei Balcani occidentali influenzati dalle nuove dinamiche politiche ed economiche globali? Ha affrontato questi argomenti anche in un suo recente reportage , ancora incompiuto…
Se parliamo di manipolazioni basate sui presupposti di Dayton, il dopoguerra in Bosnia Erzegovina non è ancora finito. Tuttavia, nel periodo immediatamente successivo alla guerra avevo conosciuto persone pronte a impegnarsi per costruire una società più normale, capace di sfuggire alle divisioni etno-nazionali create artificiosamente. Tra queste persone c’erano anche i leader del movimento per il ritorno dei profughi.
Per me, però, il dopoguerra in BiH è finito nel momento in cui ho conosciuto i movimenti locali contro le multinazionali minerarie, iniziando a parlare con gli attivisti su questo fronte. Mi sono reso conto che questi attivisti, oltre a fare rete all’interno delle loro comunità, purtroppo ormai diventate monoetniche, collaborano anche oltre i confini etnici.
Sono andato al Centro visitatori di Pecka, vicino a Mrkonjić Grad, per partecipare ad un incontro di attivisti, o meglio biologi, provenienti da tutto il paese. Oggi, l’attivismo e la ricerca biologica per molti versi si sovrappongono e complementano. Ai presenti – una ventina di giovani, appartenenti a diversi gruppi etnici – non importava nulla di queste differenze, trovavano ridicolo anche solo parlarne. Erano contenti di poter lavorare insieme: le persone giovani, non appesantite dal fardello della guerra, perseguendo altri valori e obiettivi diversi, e quelle meno giovani, che ancora ricordavano la normalità della quotidianità condivisa prima della guerra.
La mia impressione era che tutti volessero distanziarsi dal periodo post-bellico e dalla tendenza ad occuparsi di traumi e processi di vittimizzazione, così da poter difendere il loro paese. Il mio editore mi ha criticato per aver parlato di queste dinamiche – che secondo me rivelano un autentico patriottismo – con troppo sentimentalismo. Da straniero, forse ho romanticizzato troppo la situazione. Bisogna essere cauti nelle proprie valutazioni.
Qui la domanda sorge spontanea: oggi si può ancora parlare di movimenti civici in BiH? A differenza del movimento per il ritorno dei profughi che aveva coinvolto decine di migliaia di persone, all’attuale mobilitazione partecipano alcune decine di individui, e solo in situazioni particolari le proteste riescono a coinvolgere centinaia di persone. Ad esempio, nell’area di Ozren, l’intera comunità locale si oppone alla compagnia mineraria Lykos, come accade anche a Majevica, dove gli abitanti protestano contro l’azienda Arcore. Ci sono alcune iniziative di attivismo locale che possono essere considerate movimenti.
Ad ostacolare una mobilitazione più ampia a livello nazionale sono l’emigrazione, i compromessi e la cooptazione di singoli. La situazione non è certo rosea, però sento l’inizio di un nuovo capitolo della storia dei movimenti civici in Bosnia Erzegovina.
Promuovendo una “transizione verde”, l’UE parla della tutela dei diritti umani e dell’ambiente. Allo stesso tempo, però, assistiamo a situazioni in cui alcuni paesi UE sostengono certi progetti minerari nei Balcani, che hanno già causato gravi danni all’ambiente. Mentre la popolazione si oppone alle pratiche irresponsabili dell’estrattivismo, le autorità della Bosnia Erzegovina sembrano favorevoli a questa nuova forma di colonialismo. Ritiene che i movimenti che si oppongono all’estrattivismo e alle multinazionali possano innescare una svolta?
Sì, credo sia uno scenario realistico. Non posso però prevedere il futuro. Secondo me, la domanda che ci dobbiamo porre è: c’è speranza?
Se i cittadini continuano a mobilitarsi, allora c’è ancora speranza. Vedo speranza nella pressione esercitata sui leader politici locali, che dovrebbero temere di perdere il lavoro. Dopotutto, la Bosnia Erzegovina non è la Corea del Nord né la Bielorussia. Ci sono elezioni più o meno democratiche e vicende come quella che vede protagonista il sindaco di Lopare che, sulla scorta delle pressioni degli attivisti, ha ripensato la sua politica, facendo retromarcia. Staremo a vedere se quella del sindaco si rivelerà una svolta autentica, la popolazione è ancora scettica.
Nel frattempo, alcuni movimenti sono cresciuti in modo significativo, come quello a difesa del monte Ozren. Anche a Tuzla la cosiddetta “Rivoluzione di cartone” è molto influente, poi la mobilitazione di Jezero, alla sorgente del Pliva, dove la popolazione si oppone ad un sindaco che sta facendo un pessimo lavoro. Mobilitazioni analoghe interessano diversi comuni in tutta la Bosnia Erzegovina.
Se è vero che la popolazione talvolta riesce a influenzare le decisioni dei sindaci, è anche vero che le autorità a livelli più alti di governo sostengono apertamente le attività delle compagnie minerarie. Recentemente, il primo ministro della Federazione BiH ha definito le aree boschive di Vareš “una foresta brulla” che, secondo il premier, mette a rischio un investimento allettante. La leadership della Republika Srpska è pronta a svendere le risorse minerarie di questa parte della BiH senza alcuna strategia e consultazione con l’opinione pubblica. La situazione è ancora peggiore in Serbia, dove da anni ormai la popolazione si oppone alla Rio Tinto e al progetto Jadar, recentemente dichiarato di interesse strategico dall’UE. La popolazione locale ha ancora motivo di sperare?
Credo ci sia sempre speranza. In BiH ci sono alcuni movimenti civici ormai consolidati. La cosiddetta “Rivoluzione di cartone” è influente e molto dinamica in tutta la regione di Tuzla, Brčko e Semberija, fino alla Bosnia centrale, ed è un buon esempio di cooperazione oltre il confine tra le due entità, un esempio che suscita speranza. Conosco anche la storia di Rio Tinto e Jadar, così come sono a conoscenza dei compromessi fatti dal premier della Federazione BiH e dagli altri leader politici che svenderebbero ogni pezzo di terra. Molte persone comuni, giustamente, non si fidano più della leadership politica, perché col tempo hanno capito che i politici sono spesso pronti a vendere e distruggere il proprio paese.
Ad ogni modo, la lotta continua. Vareš è probabilmente una delle sconfitte più pesanti, però la mobilitazione non si ferma, anzi sta guadagnando sempre più sostegno.
Non si tratta della quantità di litio [potenzialmente presente in questi territori], peraltro inferiore a quella ritrovata in molti altri paesi in Europa e nel mondo. Il problema sono le compagnie minerarie che, come avvoltoi, vanno là dove la resistenza è più debole. Lo stesso vale per i leader dell’UE che, alle prese con forti resistenze interne, ora parlano di una transizione verde al di fuori dell’Unione
La maggior parte dei paesi nati dalle ceneri della Jugoslavia – uno stato forte e influente, uno dei leader del Movimento dei non allineati in un mondo scosso dalla Guerra fredda – non si è ancora ripresa dalla distruzione degli anni ’90. Come valuta l’attuale posizione dei paesi ex jugoslavi nel contesto globale, considerando la reputazione di cui godeva la Jugoslavia a livello internazionale?
Dal punto di vista economico e politico, quella di uno stato jugoslavo comune era una buona idea, perché la forza sta nei numeri. La Jugoslavia aveva anche un leader carismatico capace di tenere tutto sotto controllo. Questo però era anche un punto debole della Jugoslavia. Mantenere la stabilità a lungo termine di una comunità basata sulla personalità di un solo uomo si è rivelata un’impresa impossibile. Quell’uomo poi aveva anche alcuni grandi difetti: non conosceva la parola “democrazia” e non era immortale. Dopo la sua morte, sono emersi diversi problemi interni al paese e i conflitti etnici, a lungo rimasti latenti, sono sfociati in violenza.
Con la caduta del comunismo, i leader politici si sono trasformati in egemoni, come Slobodan Milošević. La combinazione di instabilità interna e opportunismo internazionale ha determinato la creazione di sei o sette piccoli stati deboli, simili a bassi alberi da frutto, pronti per essere sfruttati.
Tra i paesi ex jugoslavi, solo quelli più organizzati sono riusciti ad entrare nell’UE, gli altri sono i classici stati deboli alla periferia dell’impero. Per secoli questo è stato il destino della Bosnia, una terra sfruttata dalle grandi potenze. Oggi la situazione non è molto diversa.
L’unica soluzione è un’unione dei popoli. La Serbia è il centro economico e politico attorno al quale gravita quel che è rimasto dei Balcani occidentali. Anche la Serbia però è governata da un leader pronto a vendere le risorse pubbliche al miglior offerente, giocando su due fronti. Oggi come oggi, anche una forma di federazione sembra impossibile.
Cosa la spinge
maggiormente a dedicarsi al lavoro umanitario e giornalistico?
Lo faccio perché ne ho la possibilità e perché nessun altro lo fa. Anche altre persone conoscono le lingue e la situazione sul campo, però non hanno tempo per questo tipo di impegno, dovendo portare avanti una carriera. Io non ho una carriera e faccio tutto come volontario. Mi interessano solo i diritti umani e la tutela dell’ambiente, amo scrivere, questa è la mia motivazione.
Quali sono i suoi progetti per il futuro?
Sto tornando ai miei progetti etnografici. Parallelamente al libro, ho scritto anche alcuni saggi su quello che ho visto negli anni ‘80, durante i miei viaggi in Jugoslavia, Anatolia, Grecia… Queste storie aspettano di essere elaborate e spero di includerle nel mio nuovo libro. Ogni volta che torno in Bosnia, mi fermo per almeno sei mesi perché ci sono sempre tante cose da fare. Quest’inverno invece spero di rimanere a casa per lavorare su quel materiale. Mi piacerebbe ritornare in Bosnia, ma vorrei anche dedicarmi agli altri paesi, tornare in Ucraina. Nell’ottobre del 2023, a Kharkiv, ho conosciuto molte brave persone, tra cui alcuni musicisti, con cui sono rimasto in contatto.
Oggi nel mio paese le persone vengono arrestate per strada, deportate, imprigionate, le famiglie vengono separate… Stanno accadendo cose terribili. Per non parlare del sostegno fornito ad un regime che sta affamando la popolazione di Gaza. Mi interesso anche di questi argomenti. Sono stato in Palestina tre volte. Negli ultimi trentacinque anni, il mio attivismo è stato infatti principalmente legato alla causa palestinese.
La nostra priorità sarà quella di combattere il fascismo negli Stati Uniti. Il problema però è che anche tra i liberali non c’è un buon leader. Da tempo ormai il Partito democratico non offre alternative valide al fascismo. Cercano di risolvere i problemi economici senza successo. Non sanno come comunicare con le persone comuni. Non ci mettono il cuore. Non sono onesti nel promuovere i loro valori. Gli esponenti di spicco del partito sono legati a diverse grandi aziende. L’arrivo dei volti nuovi, come Alexandria Ocasio-Cortez [membro della Camera dei rappresentanti dello stato di New York] e Zohran Mamdani, nuovo candidato a sindaco di New York, socialdemocratico e musulmano, fa ben sperare. Molti soldi però sono stati investiti in campagne contro questi individui. Quanto al Partito repubblicano, ha tradito tutti i suoi valori morali molto tempo fa.
Cosa possiamo fare per migliorare la situazione?
Negli Stati Uniti la popolazione si sta mobilitando. Solo a Seattle, poche settimane fa, settantamila persone sono scese in piazza. In tutta l’America si stanno organizzando manifestazioni con lo slogan “No kings!”. Il nostro presidente vuole essere un re, ma noi non lo vogliamo. A dire il vero, gode ancora di un forte sostegno, però almeno cinque milioni di persone sono scese in piazza lo scorso14 giugno per protestare contro le politiche di Donald Trump. Molti giudici del sistema federale, anche quelli nominati dal presidente durante il suo primo mandato, sono contrari alle azioni di Trump. Chiunque abbia un minimo di senso di legalità si rende conto che l’attuale amministrazione Trump non ha nulla a che vedere con lo stato di diritto. L’anno scorso anche la Corte suprema ha perso credibilità, stabilendo che il presidente ha il diritto di violare le leggi nell’esercizio delle proprie funzioni. Una decisione del tutto illogica.
Quando qualcuno mi chiede cosa possiamo ancora fare, la mia risposta è sempre la stessa: trovare persone con cui collaborare e fare rete per opporre resistenza!
Per approfondire gli argomenti affrontati da Peter Lippman, consigliamo il suo libro “Surviving the Peace: The Struggle for Postwar Recovery in Bosnia-Herzegovina” e il sito Balkan Witness , lanciato nel 1999, che raccoglie numerosi articoli scritti per diverse riviste e i diari personali di Peter del periodo trascorso in Kosovo e Bosnia Erzegovina, oltre ad una selezione di testi sul revisionismo storico e la negazione dei crimini. Sul blog Surviving the peace potete invece trovare una selezione di testi di Peter dedicati alla Bosnia Erzegovina. Proponiamo anche il suo reportage (incompiuto) sulla lotta degli attivisti bosniaco-erzegovesi contro lo sfruttamento sfrenato delle risorse.