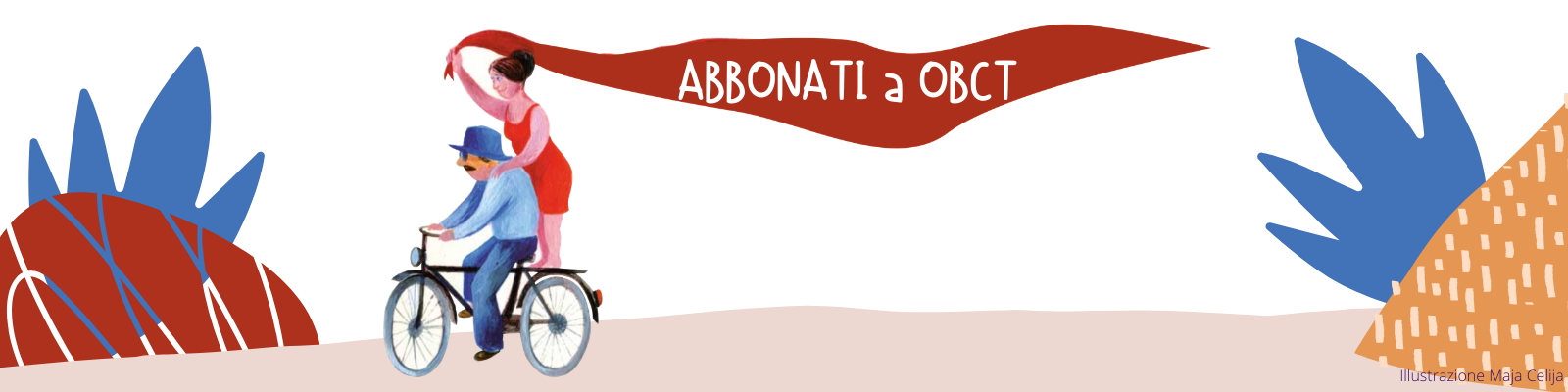Moldova, se la storia allontana le due rive del Nistru
Testimonianze dal basso per ricostruire la complessità della storia moldava del ‘900, segnata da tragedie che continuano a dividere la società e a dare spazio a strumentalizzazioni. Intervista allo storico Sergéj Erlich, animatore del progetto "Tragedia sulle due rive del Nistru"

Moldova-se-la-storia-allontana-le-due-rive-del-Nistru
Il fiume Nistru - © Shutterstock
Le due rive del fiume Nistru, che oggi separano la repubblica di Moldova dai territori de facto indipendenti della Transnistria-Pridnestrove, come metafora di una divisione più ampia che riguarda non solo la geografia ma anche la storia.
È questo il senso del progetto lanciato un anno fa da un gruppo di storici moldavi che si intitola appunto Tragedija na dvuch beregach Dnestra (“tragedia sulle due rive del Nistru”).
L’obiettivo è raccogliere testimonianze di memorie famigliari che riguardano il complicato periodo della Seconda Guerra Mondiale, che nella regione ha visto una prima occupazione sovietica nel 1940 (come conseguenza del patto Molotov-Ribbentrop), poi l’arrivo delle forze naziste e collaborazioniste romene l’anno successivo (nell’ambito dell’Operazione Barbarossa) e, infine, nel 1944 l’Unione Sovietica che riprese nuovamente il controllo del territorio.
In quegli anni un grande numero di persone hanno perso la vita e sofferto per via delle repressioni staliniane così come per il cosiddetto “Olocausto romeno", che ha praticamente eliminato la presenza ebraica nell’area.
Stratificazioni che si sommano alla già “incerta”, o comunque plurale, identità del paese, dove perdurano influenze romene e russe. Ecco allora che – secondo Sergéj Erlich, fra i direttori del progetto – le memorie famigliari diventano fondamentali nella loro complessità, perché mettono in discussione le letture troppo univoche del passato. Erlich, classe 1961, è storico e pubblicista.
Ci può parlare di Tragedija na dvuch beregach Dnestra?
È un progetto che in realtà si compone di due parti. Prima di effettuare la nostra chiamata rivolta a tutti i cittadini moldavi per raccogliere testimonianze e memorie famigliari, assieme ad altri colleghi mi sono occupato di analizzare e pubblicare i documenti d’archivio della Commissione di indagine sui crimini dell’occupazione nazifascista in Bessarabia e Transnistria. Si tratta di una commissione istituita dallo stato sovietico durante la Seconda Guerra Mondiale, che ha indagato quanto successo sul territorio moldavo fra il 1941 e il 1944 e le cui conclusioni sono servite come materiale per il Processo di Norimberga.
Va detto però che i fatti accertati da questi indagini non appaiono del tutto esaustivi. Questo perché un certo numero di persone che hanno commesso crimini sul territorio moldavo durante l’occupazione nazifascista non erano necessariamente romeni o tedeschi, ma locali che avevano dunque tutto l’interesse a non fornire testimonianze e a nascondere alcuni accadimenti. Noi ci proponiamo allora di arricchire la documentazione e aggiungere fonti per ricostruire un’immagine di quel periodo che sia il più possibile fedele alla realtà.
Crede che il valore di questo lavoro vada oltre la testimonianza storica?
Penso che sia un momento importante non solo da una prospettiva storica o di ricostruzione degli eventi passati. La Moldova ha un territorio molto piccolo e un senso di comunità molto fragile. Alcuni non esitano a definirla un failed state, uno “stato fallito”. Perché? Dal mio punto di vista, c’entra anche il fatto che ancora non abbiamo una memoria collettiva. L’antropologo e sociologo britannico Anthony D. Smith nei suoi studi sul nazionalismo aveva elaborato una sorta di sillogismo, per cui senza memoria non si può avere un’identità e senza un’identità non è possibile costruire una nazione.
In Moldova sussiste una situazione di questo tipo. Ma succede perché c’è una lotta fra memorie contrapposte: se alcuni hanno un orientamento “filo-romeno”, per cui l’identità nazionale moldava consiste in questo processo di ritorno alle nostre origini romene (interrotto dall’occupazione sovietica), altri esprimono invece tendenze “filo-russe”, considerando l’amicizia con la Russia un tratto imprescindibile della popolazione moldava (anche a costo di negare o minimizzare dinamiche e crimini del passato).
Con che conseguenze?
Si crea una divisione netta fra tragedie che vengono considerate “nostre” e tragedie che invece apparterrebbero ad altri. O comunque ci sono disparità nella memoria collettiva. In questo momento davanti al palazzo presidenziale ci sono due vagoni di treno in ricordo delle deportazioni sovietiche, ma pochi anni prima di quegli eventi su vagoni molto simili e negli stessi luoghi venivano deportati ebrei e rom verso i campi di sterminio. Eppure, il Museo di storia dedica uno spazio molto piccolo all’Olocausto. C’è spesso questa dinamica: le forze politiche e culturali “filo-romene” tendono a enfatizzare solo i crimini sovietici, dimenticandosi di quelli dell’occupazione fascista, mentre quelle “filo-russe” celebrano la vittoria sul nazifascismo ma minimizzano le tragedie di epoca sovietica.
Invece, andrebbero ricordati correttamente entrambi. Peraltro queste distinzioni spesso si annullano proprio nelle biografie delle persone. Nella storia della mia famiglia, per esempio, si trovano vittime sia delle repressioni staliniane sia dell’Olocausto romeno. E non si tratta di una caso isolato: nelle vicende di tantissime famiglie dell’area si trovano intrecciate entrambe le tragedie. Perciò credo, e spero, che il nostro progetto di raccolta di testimonianze possa essere importante: perché mette in discussione le narrazioni ufficiali.
Vede un interesse della popolazione verso il progetto?
Sì, in tanti si stanno presentando a lasciare la loro testimonianza. Allo stesso tempo, proprio per via del fatto che a livello ufficiale la storia viene spesso strumentalizzata politicamente, noto anche che diverse persone hanno timore a esporsi. C’è chi magari insegna nelle scuole e non vuole rivelare dettagli personali perché teme ripercussioni, chi invece si occupa d’affari e ha paura di rovinarsi la piazza se magari dice qualcosa che può essere letto in senso “antipatriottico”… Questo ti fa capire come non sempre le persone si sentono di vivere in una società libera e sicura.
Il punto è che siamo in un momento storico in cui il passato viene costantemente distorto per i propri scopi. Lo fa il Cremlino, piegando la memoria della vittoria sul nazifascismo per portare avanti una politica imperiale (“possiamo ripeterlo”, è il motto associato a quell’evento, usato dalla Russia per espandere nuovamente i propri confini e aggredire l’Ucraina). Ma lo fanno anche altri. Qui in Moldova, ad esempio, le autorità hanno associato il Giorno della Vittoria alla carestia del 1946 e alle deportazioni del 1949. Lo trovo problematico: occorre tener fermo che, per quanto alla fine della Seconda Guerra Mondiale siano seguite tragedie sotto il regime sovietico, la sconfitta del nazifascismo fu la sconfitta di un “male assoluto”, resa possibile dall’Unione Sovietica assieme agli alleati inglesi e statunitensi.
Però il paradigma dei “due totalitarismi” viene sempre più ribadito anche in sede europea…
Durante gli anni ‘80 nelle società della cosiddetta “vecchia Europa” (Francia, Germania, Inghilterra, etc.) si è affermato una paradigma di lettura della Seconda Guerra Mondiale che metteva al centro la tragedia dell’Olocausto e che dunque sottolineava soprattutto una memoria improntata alla responsabilità comune per lo sterminio della popolazione ebraica. Negli anni ‘90, con l’indipendenza delle nazioni dell’Europa centro-orientale, ha cominciato invece a emergere un approccio opposto che considerava come vittime principali, appunto, di due totalitarismi le popolazioni di quegli stati prima occupati dai nazisti e poi dai sovietici. Il problema è che questo paradigma vittimario lascia poco spazio all’assunzione di responsabilità, e tende a scaricare quest’ultima sempre su qualche forza straniera, che siano i tedeschi o i russi.
Lo trovo un approccio scivoloso, che piano piano sta erodendo quello della “vecchia Europa”. Ma credo ci sia anche un altro fattore che spesso non viene considerato: stiamo assistendo a una svolta politica di destra a livello globale. Trump negli Stati Uniti, ma anche l’AfD in Germania o lo stesso governo italiano… La destra è in crescita dovunque. È questo che rende possibile un maggiore revisionismo sulla Seconda Guerra Mondiale. In Moldova abbiamo appena avuto una grossa diatriba riguardante un manuale di storia scolastico, che conteneva affermazioni distorte sull’Olocausto in Bessarabia e Transnistria tendenti a minimizzare le responsabilità del regime romeno dell’epoca e a giustificare la stessa alleanza fra Hitler e il dittatore romeno Antonescu. Conta che durante gli anni ‘90 non si trovava menzione dello sterminio degli ebrei sui libri di testo moldavi. Poi negli anni 2000, dopo che la Romania ha riconosciuto pubblicamente le proprie responsabilità, ci sono state nuove edizioni che riportavano informazioni (e parlavano del ruolo del collaborazionista romeno Antonescu). Infine, oggi succede questo, che è un salto all’indietro.
Dal mio punto di vista, due o tre anni fa sarebbe stato impossibile. Il principale fattore che ha permesso ciò è la crescente influenza dell’estrema destra negli affari europei. Alcuni dicono che si tratta di “arroccamenti identitari” che si sviluppano nei paesi est-europei come reazione all’invasione russa in Ucraina. Ma secondo me è solo una “copertura”. Certo, la guerra lanciata da Putin ha fatto esplodere tutta una serie di problemi legati anche alla memoria del passato. Ma altrettanti problemi derivano dalla svolta di destra in Europa e nel mondo. Purtroppo, va ammesso, la politica della storia moldava (e di altri paesi della regione) tante volte dà tristemente occasione alla propaganda del Cremlino di attaccarci.