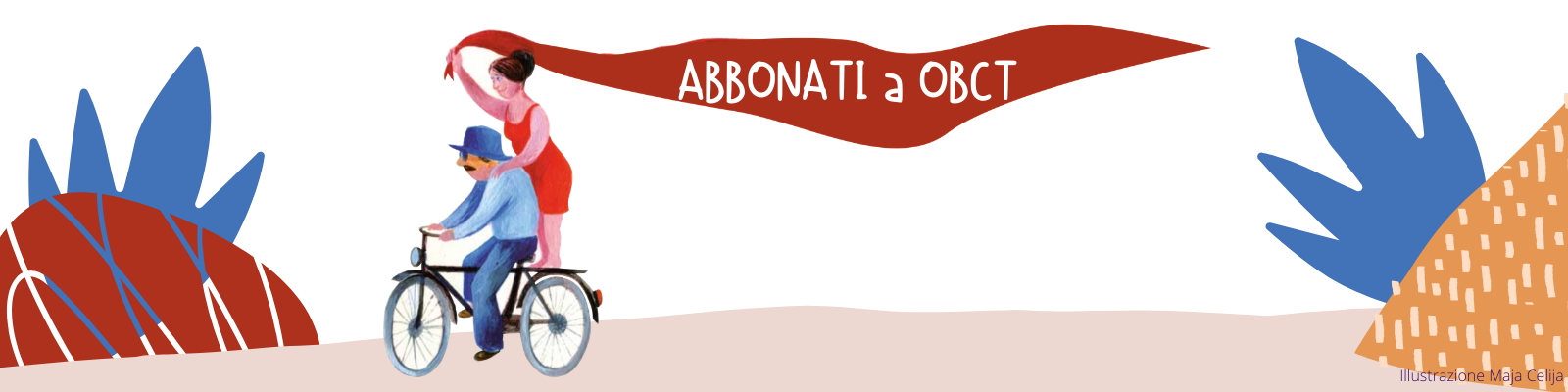La comunità greca di Istanbul, tra promesse e politica
La recente promessa pubblica di Erdoğan di prendere in considerazione la riapertura del leggendario Seminario di Halki ha riacceso le storiche aspirazioni della comunità Rum di Istanbul e, in alcuni casi, il suo sostegno al presidente turco

shutterstock_1352994728
Seminario di Halki, Istanbul - © OVKNHR/Shutterstock
In una famiglia di Istanbul, i segreti si raccontano in cucina.
Era l’estate del 2023, due mesi dopo la rielezione del presidente Erdoğan, quando ho fatto visita ad una delle mie zie, una donna che ha plasmato il mio legame con Istanbul, con la sua comunità greca e con la lingua turca. Nella sua piccola cucina, il cezve (una caffettiera tradizionale tipicamente in rame, ottone o acciaio inossidabile) sul fornello emanava il profumo dolce-amaro del caffè.
Un attimo prima di versarlo, si è chinata verso di me e ha detto, quasi scherzosamente, quasi con senso di colpa: “Ho votato per Erdoğan. Eh, sì”. Poi ha sorriso, quel sorriso pacato e consapevole che hanno gli abitanti di Istanbul quando giustificano qualcosa che non può essere spiegato del tutto. “È stato un bene per noi”, aggiunse. “E chissà cosa potrebbero fare gli altri? Potrebbero fare di peggio.”
Le sue parole sono rimaste nell’aria più a lungo dell’aroma del caffè. Quel singolo scambio, una confessione avvolta nell’affetto, è stato la scintilla che mi portò a chiedermi come votano i greci di Istanbul, cosa plasma i loro istinti politici e perché non sia mai stato scritto quasi nulla al riguardo.
Un’antica comunità
I Rum, o comunità greco-ortodossa di Istanbul, sono i discendenti della popolazione greca di epoca bizantina della città. Storicamente riconosciuti come una minoranza religiosa ed etnica distinta sotto il sistema dei millet ottomani, hanno mantenuto per secoli le proprie chiese, scuole e istituzioni comunitarie, contribuendo in modo significativo al commercio, all’istruzione e alla vita culturale della città.
Mercanti, insegnanti e professionisti della comunità hanno giocato un ruolo visibile nel plasmare il tessuto economico e sociale di Istanbul, preservando al contempo la lingua greca, le pratiche cristiane ortodosse e una distinta identità culturale. Oggi, sebbene il loro numero si sia ridotto a poche migliaia, i Rum continuano a sostenere queste tradizioni, mantenendo una presenza che è al tempo stesso storica e attivamente coinvolta nella vita contemporanea della città.
Il modo in cui si parla (o non si parla) di politica nella comunità Rum rivela un altro tipo di continuità. C’è una scena nell’iconico film di Tassos Boulmetis Politiki Kouzina (Un tocco di spezie) in cui il giovane Fanis siede con il nonno in un hammam e l’uomo più anziano gli insegna a parlare con attenzione, scegliendo parole che trasmettano un significato senza offendere. Attraverso questa lezione silenziosa, il film cattura un modo di comunicare che risuona profondamente nella comunità Rum di Istanbul: l’arte di affrontare argomenti delicati in modo indiretto, di preservare la dignità e di capire cosa può essere detto ad alta voce e cosa deve rimanere inespresso.
Hristo Dafnopatidis, ora trentenne, è uno dei volti più attivi e riconoscibili della comunità Rum di Istanbul. Ex atleta di alto livello, lavora nel settore marittimo, ma mantiene un legame privato con la tradizione: spesso canta durante le liturgie, una pratica personale piuttosto che una vocazione pubblica. La presenza equilibrata di Hristo riflette il modo in cui la comunità affronta la vita moderna, pur sostenendo silenziosamente la propria tradizione, a ricordare che l’identità Rum permane in forme sottili ma durature.
Parla con OBCT del modo unico dei greci di Istanbul di discutere argomenti delicati, principalmente in modo implicito: “C’è una lunga tradizione di discrezione che plasma le nostre conversazioni e che è diventata parte della nostra identità. Questo è qualcosa che ho imparato a casa da bambino; è un’eredità che probabilmente trasmetterò anche alla mia bambina”.
Dafnopatidis attribuisce questa discrezione in parte alle lezioni apprese in periodi di turbolenza e instabilità politica.
“Le relazioni bilaterali greco-turche hanno sempre avuto un impatto sulla nostra comunità. Soprattutto nei decenni precedenti, ogni volta che si verificava un incidente, eravamo i primi a sentirne le ripercussioni. Questo crea inevitabilmente un senso di consapevolezza condiviso e una tendenza a mantenere l’equilibrio”.
Parlare di politica Rum, quindi, significa parlare di resilienza. Questa è una comunità che continua a partecipare alla vita civica pur rimanendo in gran parte invisibile al suo interno.
Sociologi come James C. Scott hanno descritto questo fenomeno come “forme quotidiane di resistenza”, ovvero atti silenziosi che mantengono la dignità senza un confronto diretto. Allo stesso modo, il silenzio politico della comunità Rum funge sia da difesa che da dialogo. Ciò che rimane inespresso è spesso significativo quanto ciò che viene detto. Anche in questo caso si applica l’idea di “intimità culturale” dell’antropologo Michael Herzfeld: una comprensione condivisa di ciò che può essere riconosciuto all’interno della propria cerchia, ma mai dichiarato pubblicamente.
Il risultato è un modo di vivere civile condotto attraverso i simboli: la politica è naturalmente radicata nei gesti, nelle lealtà e nelle abitudini, piuttosto che nel discorso diretto. Le conversazioni nei cortili delle chiese o ai tavoli per gli onomastici possono alludere ad approvazione o scetticismo nei confronti del governo, ma raramente sconfinano in commenti espliciti. Questa discrezione, pur essendo frutto di cautela, è diventata un ritmo culturale a sé stante.
Voti senza voce
Nonostante la lunga storia e la consapevolezza politica dei greci di Istanbul, non esiste quasi nessuna ricerca formale su come votano o su cosa determini le loro preferenze politiche. Studi di Grigoriadis, Taşkın e altri hanno esaminato l’identità e i diritti delle minoranze, ma il comportamento elettorale rimane inesplorato. L’assenza di dati è un’ulteriore prova di un panorama sociale in cui i confini tra espressione pubblica e pensiero privato sono sfumati.
In quel silenzio, circolano le impressioni. Alcuni membri ammettono silenziosamente di provare una pragmatica simpatia per Erdoğan, apprezzando il restauro delle chiese, la protezione delle fondazioni e un senso di stabilità. Altri rimangono profondamente scettici, diffidenti verso quelli che considerano gesti simbolici nell’ambito di un più ampio programma diplomatico. Il caso della Scuola Teologica di Halki è un buon esempio di questa ambiguità.
Per la comunità Rum di Istanbul, in calo, Halki è arrivata a rappresentare più della teologia. Rappresenta un riconoscimento simbolico, una silenziosa speranza che la loro esistenza possa essere nuovamente riconosciuta nella città che non hanno mai lasciato. Eppure, la promessa della sua riapertura è stata rinnovata così spesso da essere diventata quasi generazionale.
Halki: un’eterna promessa
Mezzo secolo dopo la sua chiusura, la Scuola Teologica di Halki rimane un punto di riferimento per la comunità greca. Arroccato sull’isola di Heybeliada, ricoperta di pini, il seminario un tempo ha formato generazioni di clero e studiosi per il Patriarcato Ecumenico. La sua chiusura forzata nel 1971 ha segnato più della fine di una scuola; è diventata l’incarnazione del lento ritiro di una comunità secolare dalla vita pubblica.
Durante un incontro tenutosi nel settembre 2025, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al presidente Erdoğan di riaprire il seminario: una richiesta avanzata dopo l’incontro di Trump a Washington con il Patriarca Ecumenico Bartolomeo. Erdoğan ha risposto che avrebbe “fatto tutto il possibile per quanto ci compete”, promettendo in seguito di sollevare la questione direttamente con Bartolomeo.
L’esperto di relazioni internazionali Nicholas Paounis attribuisce questo sviluppo ad un gesto diplomatico di Erdoğan, volto a rafforzare i legami con gli Stati Uniti con l’obiettivo principale di reintegrare la Turchia nei principali programmi di difesa.
“La mossa fa parte di una strategia più ampia di Erdoğan per affrontare le tensioni con gli Stati Uniti, in particolare per quanto riguarda le sanzioni imposte per l’acquisto da parte della Turchia del sistema russo S-400, che hanno escluso il Paese dal programma F-35”, afferma Paounis, che negli ultimi anni ha analizzato la politica estera turca per i media greci. “Segnalando la sua disponibilità su Halki, Erdoğan si posiziona potenzialmente in modo da garantire la revoca delle sanzioni e il ritorno della Turchia al programma di caccia”. Lo scambio Erdoğan-Trump ha riacceso un cauto ottimismo tra i greci di Istanbul.
“Per noi la vera questione non è se Halki verrà riaperta o meno, ma in quale forma”, afferma un membro della comunità che preferisce rimanere anonimo. “Avremmo bisogno che Halki continuasse a essere una scuola teologica, in modo che la comunità ortodossa possa essere autosufficiente e non dover ‘importare’ ecclesiastici dalla Grecia”.
La preoccupazione che un monumento storico possa essere riproposto al pubblico, ma in un formato diverso, non è infondata. Tra gli esempi recenti a Istanbul figurano la conversione, rispettivamente, di Santa Sofia (Aya Sofya) e della Chiesa di Chora (Museo Kariye) in moschee.
La riconversione di questi monumenti bizantini storici ha suscitato polemiche non solo per motivi religiosi legati al patrimonio cristiano, ma anche per il danno architettonico irreversibile che potrebbe essere causato da centinaia di visitatori che circolano liberamente e senza precauzioni in uno spazio che necessita di essere adeguatamente preservato.