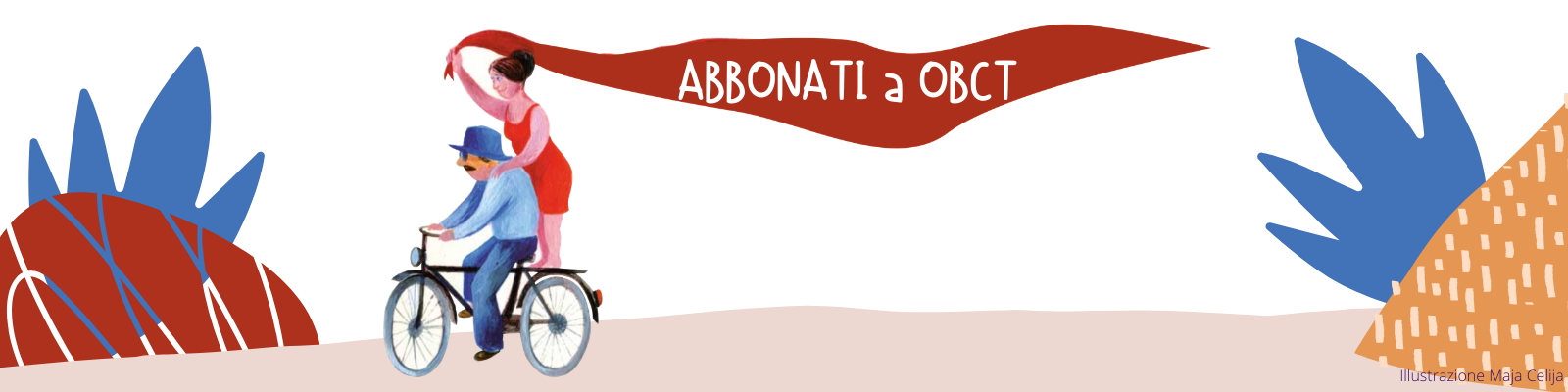|
I villaggi delle montagne nel nord dell’Albania: prospettive per lo sviluppo
Gomsique, Korpul e Fercc.Tre villaggi nel nord dell’Albania. Un viaggio nel luglio del 2007 ed una riflessione su un loro possibile sviluppo sostenibile. Riceviamo e volentieri pubblichiamo
Di Saverio Francesco Massari
Sommario: Introduzione; 1. Primo paragrafo: 1.1 Sulla strada che da Scutari conduce ai villaggi, 1.2 I villaggi: una descrizione; 2. Secondo paragrafo: 2.1 Prospettive di sviluppo sostenibile; 2.2 La semplicità di vita come risorsa; 2.3 La transizione verso il modello del nuovo capitalismo
Introduzione
Questo scritto descrive quanto osservato visitando nel luglio del 2007 i villaggi di Gomsique, Korpul e Fercc.
Posti sulle montagne nel centro – nord dell’Albania, questi piccoli centri sono disseminati sui rilievi dell’irta regione che da Scutari si stende fino al territorio di Pukë.
Non avendo la possibilità di utilizzare dati numerici descrittivi dei fenomeni che si verificano in queste zone, considerando il contesto di studio ristretto e limitato ai tre villaggi sopra citati, si è proceduto ad un approccio qualitativo basandosi su un metodo etnografico che prevede la raccolta dei dati mediante osservazioni e interazioni dirette con gli abitanti dell’ambiente studiato senza tener conto di precostituite teorie generali ma con l’intento, in primo luogo, di esaminare e descrivere ed in seguito discernere e immaginare lo sviluppo possibile della zona.
L’uso di questa metodologia ha comportato altresì un’influenza sulla composizione dello scritto che si è inteso dividere in due parti.
Infatti, si è tentato, nel primo paragrafo, di raccontare con precisione quanto osservato, ricompiendo i percorsi, riportando gli incontri, descrivendo i luoghi e le sensazioni: con questo intento, forse in maniera insolita, si è voluto dare alla prima parte dell’esposizione una forma prettamente narrativa con il preciso scopo di evidenziare, oltre a quelli tipici della descrizione scientifica, altri caratteri presenti e peculiari dell’area esaminata e che, pur essenziali alla comprensione, non sarebbero stati colti in altra maniera.
Certo, questo tipo di approccio risulta, paradossalmente, più impegnativo, primo perché costringe chi scrive a selezionare e ad interpretare ciò che ha visto e, in secondo luogo, perché espone a misurarsi con la difficoltà di una scrittura che deve plasticamente adattarsi al raccontare ciò che non può essere descritto con la precisione e la "semplicità del numero".
Tuttavia, questa prima parte, lungi da essere solo una cronaca, contiene già evidenti i tratti di ciò che verrà poi indicato nelle conclusioni.
Nel secondo paragrafo, dunque, riportando alcune considerazioni di carattere generale, si tenterà di trarre dalle osservazioni riportate alcuni fenomeni socio-economici che interessano l’area di studio, indicandone alcuni caratteri propri probabilmente utili ad immaginare un processo di sviluppo rurale.
Nelle osservazioni, si è cercato di approfondire l’aspetto riguardante i modi di sussistenza alimentare di queste popolazioni, la dotazione di strutture di relazione sociale e di vere e proprie infrastrutture materiali.
1. Primo Paragrafo
1.1 Sulla strada che da Scutari conduce ai villaggi
Appena fuori Scutari l’acre odore della combustione invade l’abitacolo della macchina: la discarica brucia perennemente nel tentativo di smaltire i rifiuti prodotti dalla città.
Guardando fuori è possibile vedere l’ampia distesa dell’alveo di un fiume in secca ricoperto dall’azzurro e dal bianco dei sacchi di plastica in attesa della miccia di fuoco che provvederà a trasformare la loro sgradevole vista in sgradevole presenza olfattiva.
Nel frattempo però, sono molti quelli che si affaccendano sui mucchi di immondizia con l’intento di cavarne ancora qualcosa di utilizzabile.
Greggi di pecore e alcune mucche, spinti fin là dall’arsura e dalla sterilità del suolo, raccolgono con le bocche quanto i loro forti stomaci riescono a digerire; le donne, invece, sono alla ricerca di materiali da rivendere, di stracci con cui coprirsi o con cui coprire i loro figli.
I bambini, numerosissimi tra le cataste di rifiuti, ricercano un modo divertente per passare il tempo.
Se capitasse di scendere dal veicolo e di incamminarsi per questa landa si noterebbe come la terra sia impastata con rifiuti capace ormai di offrire esclusivamente residui di plastica e, quindi, inadatta a qualsiasi tipo seme: i radi cespugli, riarsi per la mancanza di piogge e per la grande calura, non porgono nient’altro che il loro triste aspetto.
Intorno, abitano gli uomini con le loro famiglie; le case basse, il tetto in lamiera e il filo spinato a recintare un stentato praticello su cui pascola un cavallo o una mucca.
Chi possiede la "lopa", può ritenersi fortunato: la mucca dà il latte per il consumo familiare e per qualche piccolo baratto che permette di procurarsi giornalmente qualcosa da mangiare.
Subito dopo questo, la città finisce e la strada comincia faticosamente a salire verso le brulle montagne di Albania.
Si fa fatica a salire: fatica la strada e con lei le macchine e le schiene di quelli che devono raggiungere i villaggi in quota o la città di Pukë o, più in là, il Kosovo.
La striscia d’asfalto che si percorre è fortemente irregolare con numerosi tratti dissestati attraversando i quali i mezzi sono sottoposti ad una dura prova: eppure, con costante caparbietà ed esasperante lentezza si inerpicano su questa strada i veicoli più disparati.
Si tratta per lo più di furgoni adibiti al trasporto di persone che sostituiscono l’assente servizio pubblico, raccogliendo sulla tratta battuta chiunque sul ciglio della strada invochi un passaggio.
Superata l’ampia distesa del vorticoso ed imponente fiume Drin si attraversano, nella pianura in cui scorre l’alveo del corso d’acqua, diversi agglomerati di basse case che sorgono affacciate alla via, e dalle quali si offrono le più disparate mercanzie.
In una confusione di colori, odori, suoni e persone che ricordano a tratti i mercati medio-orientali si vendono frutta, ortaggi, pane, carne, vestiti, materiale edilizio, benzina, pezzi ed accessori meccanici; si aprono sulla strada botteghe di barbieri, elettrauto, bar, rivendite di bibite.
La vendita e le altre attività, tuttavia, non sono sempre condotte separatamente e spesso si confondono nello stesso esercizio: così dal fruttivendolo si può anche comperare un barattolo di buon olio motore esposto appena sopra il ripiano del pane.
Proseguendo, si scopre un altro tratto tipico del paesaggio stradale albanese: sul ciglio della strada fioriscono una miriade di ristoranti e locali perennemente aperti ed affollati di gente che siede ai tavolini sorseggiando il raki, la grappa ottenuta dalla fermentazione delle prugne, e giocando a domino: in prevalenza sono uomini e le donne sono molto rare.
La strada scorre sotto le ormai prossime montagne mentre, nel tratto di pianura sul quale si dipana, divide un’ ampia estensione di terre incolte sulla quale verdeggia una vegetazione spontanea e sorgono senza ordine nuove e vecchie costruzioni.
Solo raramente si incontrano campi coltivati nei quali trovano posto, in file ordinate, piante di mais o tralicci sui quali si attorciglia la vite: sono queste, qui come in quota, le principali colture praticate assieme alla raccolta delle patate e delle cipolle.
La strada prende decisamente a salire quando gli ultimi agglomerati di case si fanno più radi e la vegetazione brulla della montagne lascia intravedere lo spettacolo di grandi distese ricoperte da una patina gialla, punteggiata da isolati arbusti ancora verdi, da pini molto bassi e stentati.
Sul fianco della strada si aprono profondi baratri sul fondo dei quali si stende la valle ordinatamente divisa secondo l’andamento delle colture, verdeggiante quando non attraversata dal fiume "Gomsique", grigia quando il letto in secca del corso d’acqua si allarga prepotentemente ad occupare la piana.
Infatti, ampie pietraie si aprono a valle: l’acqua che scende dalle montagne non sembra essere irreggimentata da argini né avere un preciso alveo ma fluisce liberamente secondo la sua intensità.
D’altronde le opere pubbliche in Albania, e in questa zona periferica a maggior ragione, non sono molto diffuse e ciò e ben visibile considerando la stessa strada che si percorre e che si arrampica pericolosamente: semplicemente l’asfalto è stato versato sul piano ottenuto dall’escavazione della montagna e il ciglio non è rafforzato da nessuna banchina o terrapieno, né è contenuto da cinti di protezione.
Guardando la strada che si proietta sul fianco della montagna davanti e che tra poco si dovrà percorrere, si notano poco rassicuranti tracce di passate frane e smottamenti molto frequenti specie nella stagione più piovosa.
Spesso si parano davanti agli autisti, macigni staccatisi dall’alto creando gravi problemi di manovra specie per i pesanti camion che devono, comunque, percorrere la distanza fino in Kosovo.
Sul ciglio, prestando molta attenzione, si notano partire sentieri di pietrisco e ghiaia che una volta si perdono tra ripe a valle, a volte si inerpicano fino in cima: sono le uniche vie percorribili che collegano alla strada principale i numerosi villaggi collocati nelle più lontane vallate.
Queste mulattiere sono di recente realizzazione poiché recente è l’esigenza di attraversamento di veicoli a motore, in realtà ancora oggi molto rari: d’altronde la stretta e ripida via che si svolge lungo il crinale del monte consente il passaggio di una sola macchina costringendo, imbattendosi in qualcuno proveniente dal senso opposto, a pericolose evoluzioni guidando a marcia indietro.
Tuttavia, i villaggi serviti da questo tipo di strada sono privilegiati perché comunque raggiungibili da mezzi meccanici e, quindi, da rare merci.
Nonostante la precarietà di queste vie che si fanno impraticabili con la neve e con le piogge, la loro costruzione rappresenta un’importante facilitazione rispetto alla situazione in cui versano altri luoghi raggiungibili solo a piedi dopo ore di cammino su acciottolati franosi e impervi.
Questo è il caso del villaggio di Fercc, agglomerato di case disperso sulle montagne del centro-nord dell’Albania sulla strada che porta da Scutari a Pukë.
E’ difficile collocare con maggiore precisione l’ubicazione dei luoghi di cui si parlerà perché su tutte le carte geografiche consultate non se ne trova traccia, ed anche l’onnipresente occhio satellitare che scruta il mondo attraverso la finestra di internet sembra non essersi accorto degli uomini che vivono quassù, delle loro case e dei loro campi.
1.2 I villaggi: una descrizione
Dunque, quando la strada comincia a declinare verso valle vi si incontra sul ciglio una sequenza di edifici composti da un locale di generi alimentari, un bar, un distributore di benzina e dalla scuola: più avanti si trova la Chiesa.
Si tratta della parte visibile del villaggio di Gomsique che divide il proprio nome con un altro villaggio sito molto più a valle e attraversato anch’esso dal fiume da cui entrambi prendono denominazione.
In realtà, non esiste un vero e proprio agglomerato abitativo: le case in cui vive la gente sono sparse sulla montagna incombente e sono spesso molto lontane tra loro, raggruppate due o tre per volta.
Ebbene, da questo punto, nascosto dall’ennesimo campo di mais si dipana uno dei tanti piccoli sentieri di montagna, pietrosi ed infidi, che conducono in quota al villaggio chiamato Fercc.
La pista, ricavata dall’opera di incisione del fianco della montagna si perde a vista d’occhio guardando avanti e, seppur molto stretta, segna il fianco delle montagne che attraversa.
Gli albanesi chiamano "rruga" la strada quasi fosse un solco sul volto della terra che dia a questa una tipica espressione: in questo caso la grinza del sentiero che guizza arrancando sull’altura, spiega la grande asprezza della salita e la fatica che aspetta chi deve percorrerla.
Introducendosi nel cammino, si apre sul fondo una stretta valle che è attraversata da una grande pietraia che è allo stesso tempo camminamento per gli uomini e alveo del torrente che nel periodo primaverile diventa talmente ampio da prendere tutto lo spazio.
Esistono, sospesi tra un fianco e l’altro della catena dei monti, esili ponti di corda e tavole che, quando il ruscello diventa fiume, permettono il guado senza dover attraversare la valle: l’equilibrio di queste passerelle è davvero molto precario e il loro valico rappresenta un’emozionante esperienza.
Si aprono sul cammino, quando le pieghe della terra l’hanno consentito o reso più facile, dei grandi terrazzamenti nei quali si svolgono le attività di coltivazione: le principali colture che appaiono visibili sono quelle del mais e della vite.
Altrettanto diffusa è la coltivazione dei legumi, principalmente fagioli, delle cipolle e delle patate.
Questi ampi spazi di terra sono spesso recintati da divisori in muratura e paletti di legno, conficcati nella terra piuttosto per la difesa dall’invasione degli animali che per ragioni di divisione proprietaria.
Infatti, seppur come tutti i Paesi in via di transizione, anche l’Albania è alle prese con i problemi della restituzione della terra e con l’assegnazione delle proprietà, su questi monti non vi sono grandi conflitti tra vicini sull’attribuzione dei fondi.
Questo succede perché, specie negli ultimi dieci anni, si è verificato un importante fenomeno migratorio che ha portato numerosissime famiglie a trasferirsi a valle, nelle periferie delle più grandi città, nella speranza di migliorare le proprie condizioni.
Si è dunque assistito ad un vero e proprio processo di spopolamento delle montagne e di inurbamento di queste masse contadine che però, certo, non hanno trovato un destino migliore nelle città.
La maggior parte di questi nuclei sopravvive non perché abbia trovato una occupazione più vantaggiosa ma solo grazie alle rimesse che i propri congiunti inviano per il sostentamento delle famiglie: quindi, la migrazione interna spesso non è che il primo passo per tentare di raggiungere i Paesi occidentali perché il benessere e la fortuna e della casa spesso dipende da quella di chi è emigrato all’estero.
Dunque, a causa di questo spostamento di masse, rimangono incolti grandi spazi e l’abbondanza di terreno fa sì che non sorgano dispute sul possesso e la proprietà.
Tuttavia, questo incentivo non persuade a restare: anche chi è rimasto ha comunque come obbiettivo quello di accumulare le risorse necessarie per poi scendere a valle.
Spesso, proprio per la mancanza di gente, è dato imbattersi in terrazzamenti abbandonati e in uno di questi si è ricavato il cimitero: le sepolture, segnalate da massi sparsi senza ordine tra l’erba, sono talmente semplici che se la qualità del luogo non fosse segnalata da qualcuno del posto non ci si accorgerebbe di niente.
Comunque, l’opera di ridistribuzione delle terre che lo Stato ha intrapreso dopo la caduta del regime comunista non sembra essere giunta fin su questa montagne: chiedendo infatti in merito alle procedure di assegnazione si riscontra che, comunemente, i campi e gli animali sono stati presi non secondo le direttive governative ma, quando non spontaneamente, con la forza.
In buona sostanza, ognuno ha occupato lo spazio di terra che più gli piaceva, risolvendo personalmente i possibili dissidi con i vicini: non sono rari i racconti di violente e sanguinose liti che spesso hanno dato origine a vere e proprie faide.
Tuttavia, quegli spazi che sono coltivati appaiono molto ordinati e ben tenuti: i filari dell’uva fanno spesso da corona ai campi di mais affondando le radici nello stesso terreno e si stagliano, verdeggianti, alti e ben dritti.
I grappoli dagli acini neri e dolci, sono piccoli ma compatti e sani: d’altronde, anche nei periodi di secca sono disponibili grandi quantità d’acqua.
La prossimità delle piante non dà luogo a confusi intrichi ma piuttosto ad una serena ed equilibrata convivenza: infatti, vedendo questi campi abbarbicati alla montagna si ha una netta percezione armonica dell’impatto umano sulla natura.
La mano dell’uomo sembra assecondare la terra nel suo sforzo produttivo e non forzarla: l’agricoltura, che in questi luoghi è praticata per l’auto-sostentamento, è lo strumento di chi coltiva solo per trarre nutrimento e non per altri fini.
Pertanto, il rispetto e la soggezione con cui si rendono feconde queste aspre lande ricorda l’ancestrale rapporto di timore tra uomo e natura e mantiene, nelle parole e nei gesti di questi uomini, la traccia del mistero della germinazione che puntualmente ogni anno porta nuova vita.
Tutto ciò conserva un carattere magico-religioso che spesso sconfina nella credenza popolare: durante gli anni del regime, la spietata repressione anti-confessionale ha di fatto privato la popolazione di una educazione religiosa pur lasciando nella memoria dei più anziani alcune tracce che nel tempo e nel passaggio tra generazioni si sono fatte più confuse fino a diventare superstizione.
Infatti, rimane forte in queste genti un sentimento religioso che nella zona del nord si rifà ad un cattolicesimo ancora ingenuo e spontaneo, frammisto a fedi tradizionali legate al potere miracoloso degli uomini consacrati che possono, con i riti, compiere atti taumaturgici: per questo, in alcune case vengono conservate gelosamente le Sacre Scritture le quali, spesso bene in vista in qualche stanza della casa, sono considerate strumento per allontanare i mali portati dalle invidie dei vicini e, ai sacerdoti viene chiesto di recitare formule per scacciare i topi dalle abitazioni o dai campi.
Dunque, la coltivazione dei terrazzamenti viene compiuta da tutta la famiglia che trova in questa attività la principale occupazione: trattandosi delle colture che dovranno sfamare la famiglia per l’intero anno queste sono attentamente curate.
La coltivazione è portata avanti senza l’aiuto di macchinari o ritrovati della tecnica ma tutto è ottenuto con il genuino lavoro dell’uomo: per dissodare viene utilizzato l’armento e il vomere, né la chimica interviene per fertilizzare il terreno.
Vicino a ciascuna delle case ancora abitate è visibile un recinto di legno nel quale trova posto l’orto della famiglia: di solito un pergolato getta ombra sugli ortaggi e sui legumi che vi si coltivano.
Entrando nelle abitazioni sarà poi possibile vedere questi frutti stipati nelle dispense in sacchi colmi di pannocchie pronte per l’uso e immagazzinate per l’inverno, assieme a corone di cipolle appese ordinatamente ai muri.
Una variazione alla dieta viene inoltre fornita dalla raccolta di erbe e frutta che la vegetazione della montagna spontaneamente fornisce: oltre che ai numerosissimi cespugli di more sono presenti molti alberi di prugne e verdure di ogni specie che vengono utilizzate sia come pietanze che come spezie.
Si aggirano attorno alle case alcune mucche: il possesso di questi animali è considerato un segno di prosperità.
Coloro i quali possono utilizzare il latte hanno un importante elemento con cui integrare la dieta oltre ad un prodotto prezioso da barattare con i vicini.
Alcuni tentano di ricavare frutti anche dalla riproduzione degli animali vendendo i vitelli, agnelli, galline: questa attività è la più redditizia tra quelle praticate in questi luoghi ed è spesso l’unica possibilità per racimolare il denaro necessario per trasferirsi a valle.
Infatti, questi commerci forniscono spesso le risorse necessarie per costruire una casa nelle periferie delle città più grandi verso le quali migrare appena ci sono le condizioni.
Lo stesso discorso vale per l’allevamento delle greggi esercitato sopratutto dai più anziani del nucleo familiare: per la loro importanza nell’economia familiare, gli animali sono massimamente considerati e, per quanto possibile, curati.
Tornando sul sentiero, dove il fianco della montagna si apre fino a formare un’ ampia gola attraversata da una grigia spianata sassosa si trovano le prime case di Fercc.
È, tuttavia, subito evidente come la definizione di villaggio non sia del tutto corretta poiché in queste zone le case non sono distribuite secondo l’idea comune di agglomerato umano: piuttosto che cercare la vicinanza con gli altri, sembra che qui si sia costruito seguendo altri criteri che quello della prossimità.
Infatti, non esiste nessun elemento che possa ricondurre ad una condivisione dello spazio poiché, come invece usualmente è dato rinvenire anche nei più piccoli villaggi, non esistono spazi o edifici comuni né, dunque, piazze o luoghi di incontro.
Semplicemente, il sentiero, nel suo correre sul fianco della montagna, costeggia le case che nascono dove la disposizione dei costruttori ha inteso e la natura della terra ha permesso.
Molte abitazioni, a seguito della pesante emigrazione, sono ormai disabitate e gli orti vicini risultano incolti.
Il torrente corre sempre ora più veloce ora lento sul fondo della valle: il costone della montagna invece, in un tratto in cui le pareti dei monti di fronte si fanno più vicine e il letto del fiume si stringe in un gomito, appare spoglio e le rocce si espongono al sole.
Anni fa, in un momento di piena, il torrente divenne talmente temibile e l’acqua fu talmente tanta da colmare l’intera valle e da strappare dal fianco dei colli la vegetazione e il terreno.
Sotto questa ferita oggi invece il Gomisique scorre tranquillo e in quello stesso gomito nel quale l’acqua si accumula a formare un piccolo lago i bambini giocano a tuffarsi e a pescare: quelli che ancora non sanno nuotare creano con bottiglie di plastica legate attorno alla vita efficaci salvagente.
Le case di questo villaggio sono bianche con poche finestre ed un tetto di tegole di un rosso ormai sbiadito dal sole: davanti alla porta principale si trova un piccolo spazio pavimentato da lastre di pietra bianca che le donne tengono pulitissimo.
In questo spazio, quando il tempo lo consente, la famiglia si riunisce e svolge le attività di conservazione e stoccaggio del raccolto: qui anche si consuma la attività sociale della famiglia quando il numero dei componenti e il caldo sconsigliano di restare in casa.
All’esterno, sotto una piccola tettoia v’è la cucina composta da un focolare sul quale trovano posto alcune pentole strette incastrate in un’ apertura sul piano al di sotto del quale brucia il fuoco.
L’interno presenta una volta molto bassa evidentemente così costruito nell’intento di riscaldare più facilmente la casa: allo stesso scopo nella facciata si aprono solo rare e piccole finestre.
Sebbene il pavimento della casa sia costituito da terra battuta all’interno si cammina scalzi.
Nonostante le precarie condizioni, esiste tra questa gente un alto senso dell’ospitalità: chi entra viene fatto accomodare nella stanza migliore che si differenzia dalle altre per il fatto di avere una finestra, una copertura di plastica per il pavimento di terra e un caminetto.
Le famiglie più abbienti volentieri offrono all’ospite un bicchiere di forte raki o delle sigarette: l’uso di offrire sigarette è considerato un gesto di cortesia estrema da parte di chi ospita, tanto che questo si verifica anche nelle occasioni più importanti come matrimoni e funerali.
Qui sono appesi alle pareti i simboli della devozione rappresentati da simulacri religiosi ai quali, spesso, si affiancano quelli più prosaici dei giocatori di calcio, venerati, specie dai più giovani, alla stessa stregua della divinità poiché rappresentano un mondo affascinante che viene idealizzato o attraverso i racconti di coloro che tornano o per mezzo delle immagini delle rare televisioni.
L’apporto idrico è garantito dalla grande abbondanza di acqua che però è prelevata direttamente dalle sorgenti e non dal torrente: vicino a ciascuna casa o ad ogni piccolo agglomerato, infatti, vi è un fiotto continuo che sgorga direttamente dalle rocce e, raccolto in recipienti, viene e trasportato a seconda delle necessità.
La vita sociale in montagna non è certo semplice e le difficoltà sono acuite in questi luoghi perché nelle ore serali, nelle quali si è liberi dal lavoro e più propensi agli scambi, la mancanza di luce e le distanze rendono impraticabili i sentieri che conducono alle altre case.
Non esistono, inoltre, neanche luoghi pubblici come la piazza né locali come bar: in alcuni villaggi più grandi fino ad alcuni anni fa esistevano piccole botteghe di generi alimentari ma oggi, a causa dell’impressionante spopolamento, sono state chiuse.
Neanche la messa domenicale e la condivisione della Chiesa rappresenta una possibilità di incontro perché sono rarissimi gli adulti che vi si recano e questi sono in prevalenza donne anziane: gli uomini cresciuti nel tempo del regime laico ed anti-confessionale sono assolutamente privi di interesse per i riti istituzionalizzati e restano, al massimo, relegati alla loro superstizione.
Tuttavia, alla domenica, si riesce a trovare il tempo per scambiarsi visite anche se questo avviene di solito tra i membri di uno stesso nucleo familiare: inoltre, come di tradizione funerali e matrimoni sono le occasioni per riunire i congiunti e i vicini.
Neanche le condizioni di grande carenza soprattutto di infrastrutture pubbliche a favore della collettività rappresenta l’occasione di cooperazione al fine di superare queste mancanze: i sentieri che tutti percorrono restano in stato di abbandono e nessuno ne cura la manutenzione.
Quando, per esempio, il fuoco aggredì parte di queste montagne in un rogo di vaste proporzioni che minacciò molti villaggi, nessuno degli abitanti dell’area organizzò soccorsi o tentò di arginare le fiamme.
È evidente che, a causa dell’impronta del passato regime che ha annullato la capacità individuale e lo spontaneismo, l’aspetto della collettività, della condivisione e la cura di spazi comuni non trova oggi nessun riscontro.
Inoltre, ogni attività o proposta che passi attraverso la cooperazione con altri soggetti è vista con sospetto e circospezione poiché chi ha conosciuto uno dei regimi più spietati che si presentava attraverso le forme delle cooperative di lavoro e sottraeva attraverso queste i beni materiali e la libertà, considererà sempre questi strumenti, anche se retti nella gestione da principi democratici, come istituzioni dell’oppressione.
Inoltre, vi è un alto grado di diffidenza anche tra le persone più vicine perché il passato regime operava la repressione sulla delazione spontanea o estorta: pertanto, la forma mentis ingenerata in molte generazioni è quella del sospetto e della paura dell’altro.
2. Secondo paragrafo
2.1 Prospettive di sviluppo sostenibile
Da quanto descritto e osservato devono trarsi le necessarie conclusioni che possono mettere in luce aspetti strutturali di dotazione e di deficienza della zona di cui si è scritto e che sarebbero utili spunti per la progettazione del suo sviluppo.
Evidentemente, percorrendo questa area, viene subito alla luce la cronica inefficienza infrastrutturale.
S’intende con questa espressione considerare la qualità delle strade esistenti che, anche quando ricoperte di asfalto, sono infide e insicure, non percorribili senza difficoltà in ogni periodo dell’anno e con qualsiasi condizione meteorologica.
Tuttavia, si è osservato che i centri abitati in questa zona sono serviti da diversi tipi di strade: i villaggi che si affacciano sui percorsi asfaltati di cui si è detto, rappresentano solo pochi casi più fortunati.
La maggior parte del territorio è raggiungibile da sterrati, che pur se percorribili da mezzi meccanici presentano le insidie di cui pure si è parlato precedentemente, e da camminamenti di montagna praticabili solo a piedi.
Questa situazione rappresenta forse il primo elemento da considerare la zona per qualsiasi tipo di intervento immaginabile in loco: il raggiungimento fisico dell’area rappresenta un grave problema che la dotazione infrastrutturale non sembra risolvere.
Lo stesso problema si pone considerando la possibilità di far pervenire sul mercato prodotti della zona: infatti, se diventa difficile immaginare un flusso di risorse materiali in entrata nel sistema rappresentato dai villaggi studiati è altrettanto difficile pensare ad esportare merci e produzioni verso il mercato e il consumatore.
Tuttavia, la situazione è in lento miglioramento: le nuove municipalità stanno faticosamente tentando con i pochi fondi disponibili di creare piste carrozzabili verso ogni agglomerato ma tale processo risulta lungo e insufficiente.
Inoltre, specie per i villaggi più lontani, appare carente la dotazione di energia elettrica o poiché intermittente, come d’altronde succede nei centri più grandi, o perché è addirittura assente.
Occorre a questo punto soffermarsi su una riflessione che avrà grande importanza nello spiegare alcuni fenomeni oggi presenti nell’area e che trae origine dall’esperienza del regime che ha segnato profondamente l’Albania: la linea politica adottata dal governo del dittatore Enver Hoxha perseguì ed ottenne un annientamento pressoché totale di ogni forma di religione.
L’eliminazione del sostrato normativo rappresentato dai precetti religiosi e tradizionalmente diffuso nella popolazione non è stato mai però colmato da nuovi elementi capaci di dettare una struttura valoriale di riferimento e di predisposizione al recepimento di norme socialmente condivise.
Qualsiasi religione, prima ancora che qualsiasi sistema politico o sociale, impone già dalla più tenera età una formazione attorno a valori considerati validi che vengono trasmessi dalla stessa istituzione familiare che risulta il più capillare ed efficace strumento educativo: poi la consapevolezza dell’esistenza di norme comportamentali e di relazione, non solo con il Dio ma anche con gli altri appartenenti alla comunità, diventa un fatto naturalmente accettato sul quale trovano facile appiglio le regole della convivenza civile.
In altre esperienze di repressione, spesso la religione e la famiglia sono stati elementi segreti di continuazione di valori paralleli e alternativi a quelli imposti dal regime: nel caso albanese, la minuzia con la quale si è voluto sradicare le confessioni è giunta a violare pesantemente finanche la sfera familiare nella quale non erano rare, favorendo o estorcendo la delazione, le attività di spionaggio.
Orbene, a causa della capillarità e dell’efficacia dell’iniziativa, per un lungo periodo vi è stata una grave carenza dei principi basilari della formazione personale e sociale poiché, a fronte della sparizione dei modelli tradizionali, lo Stato non ha proposto altri modelli valoriali, ma ha solo represso il dissenso, lasciando quanti sono cresciuti nel periodo comunista nell’assenza di validi riferimenti.
Questa mancanza di formazione, soprattutto nel vigore di un ordinamento democratico basato non più sulla guida endogena esercitata attraverso il terrore e la repressione ma sulla consapevolezza del cittadino e sulla responsabilità personale, rappresenta uno dei maggiori ostacoli alla creazione della società civile e di una ordinata convivenza sociale.
Per tale motivo, oggi, scarsa è la propensione della popolazione a mettere in essere strategie condivise per affrontare le necessità: non vi è dunque disposizione alla creazioni di reti di collaborazione che possono aprire la strada a forme di lavoro cooperativo.
Le ragioni di questa resistenza risiedono certamente anche nell’uso distorto e improprio che il regime precedente ha fatto di questo strumento: le cooperative erano infatti imposte dallo Stato ed erano percepite come strumento di oppressione e di sottrazione della proprietà.
Si deve dunque operare agendo a livello culturale qualora si voglia incentivare l’uso di questa modalità produttiva ai fini di avvantaggiarsi degli effetti benefici che gli sono propri sia a livello economico che ai fini sociali.
Certo, il corretto utilizzo di questo strumento potrebbe incidere positivamente sulla dotazione di capitale sociale nell’area che, essenziale per un completo processo di sviluppo che accolga in sé non solo elementi economici ma anche elementi di socialità e non solo, risulta ad oggi carente: sono poco estese, infatti, le reti di relazione al di fuori dei nuclei familiari.
L’importanza della co