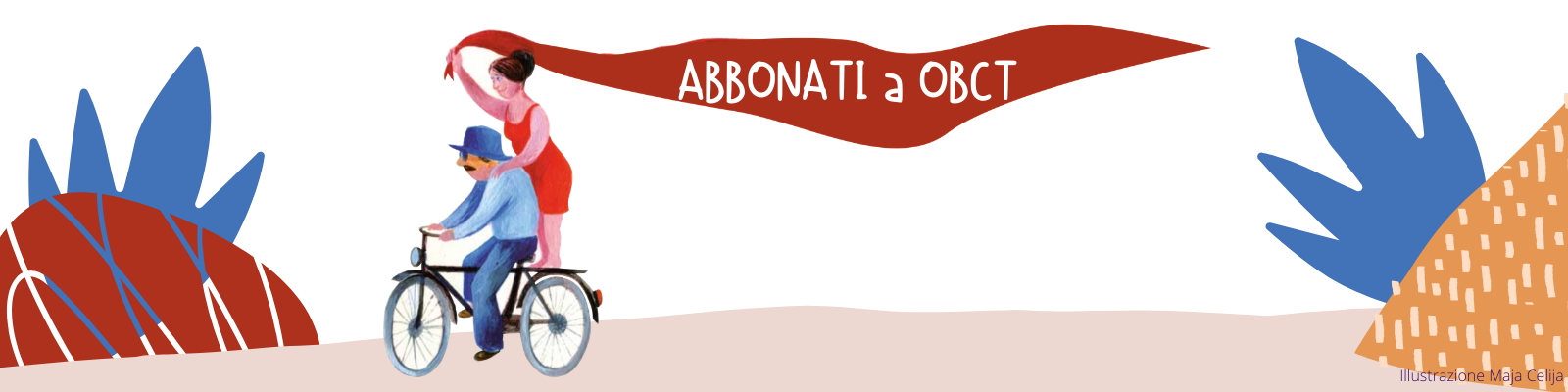I progetti interreg e la transizione energetica
Supportando materialmente le regioni europee da diversi lati del confine per risolvere un problema comune, i progetti Interreg dimostrano come l’impatto nella transizione sia spesso favorito dalla cooperazione transfrontaliera

I-progetti-interreg-e-la-transizione-energetica
© Summit Art Creations/Shutterstock
Il ciclo della politica di coesione 2021-2027 ha stanziato risorse sostanziali per l’obiettivo “Un’Europa più verde”.
Secondo i dati della Commissione Europea, sarà la Polonia a ricevere la quota maggiore dei finanziamenti su questo tema con quasi 22 miliardi di euro messi a disposizione, seguita da Spagna (9.5 miliardi di euro), Italia (8.6 miliardi di euro) e Romania (7.9 miliardi di euro).
Altri paesi come Portogallo, Grecia, Repubblica Ceca e Ungheria avranno a disposizione quantità di fondi importanti per le voci di spesa inerenti ai progetti ambientali, con almeno 5 miliardi di euro messi a disposizione dall’Ue.
A integrazione di queste dotazioni nazionali, vi sono anche i programmi Interreg, che contribuiscono con circa 3.6 miliardi di euro agli obiettivi di transizione energetica e alla lotta al cambiamento climatico dell’Unione.
I progetti Interreg si distinguono dai fondi di coesione tradizionali, in quanto sono specificamente progettati per la cooperazione tra regioni appartenenti a paesi membri diversi e, talvolta, includono anche stati non ancora facenti parte dell’Unione.
Interreg finanzia infatti progetti di collaborazione transfrontalieri, transnazionali e interregionali, che affrontano sfide comuni alle regioni interessate che richiedono soluzioni congiunte per far sì che gli obiettivi siano raggiunti efficacemente. Il mandato ufficiale del programma è quello di “ridurre gli ostacoli alla cooperazione tra regioni e paesi”, consentendo ai partner di mettere in comune competenze, infrastrutture e modelli di governance piuttosto che lavorare in modo isolato.
La Settimana europea dell’energia sostenibile
Questa dimensione transfrontaliera, anche e soprattutto in tematiche ambientali, è stata messa in evidenza durante la Settimana europea dell’energia sostenibile (EUSEW) tenutasi nel luglio del 2025, che ha presentato ben tredici progetti Interreg come esempi virtuosi, evidenziando la diversità degli interventi sostenuti dai finanziamenti di Greener Europe e come la collaborazione fra paesi diversi possa contribuire, con il supporto dell’Ue, a uno sviluppo economico più sostenibile e che avvicini ulteriormente fra loro le regioni interessate.
Fra i progetti presentati alla Settimana europea dell’energia sostenibile, ve ne sono alcuni che interessano regioni dell’Europa sudorientale.
Nella regione adriatico-ionica, nel contesto del programma interreg ADRION, ad esempio, il progetto CO-CLEAN ha dimostrato la sinergia tra gli aggiornamenti pratici delle infrastrutture e il coinvolgimento delle comunità locali. Con una durata che è andata dal 2020 al 2023, e un budget di circa 693 milioni di euro, CO-CLEAN ha efficacemente combinato l’installazione di strutture e impianti rinnovabili all’educazione della cittadinanza nonché la formazione specialistica creando un modello replicabile per la transizione energetica e le comunità energetiche comunali.
Operando nell’area di cooperazione Italia-Albania-Montenegro, questa iniziativa è stata guidata dal Comune di Brindisi che, insieme ai partner delle municipalità di Racale, Valona e Berane, hanno combinato miglioramenti tangibili alla sostenibilità ambientale di edifici pubblici con il lavoro di creazione di comunità energetiche locali.
A Brindisi, ad esempio, un impianto fotovoltaico da 30 kWp installato sul tetto di una scuola elementare è servito a dimostrare come possa funzionare una comunità di energia rinnovabile, integrando con sessioni che vedevano l’informazione versi i cittadini del progetto e delle sue finalità, oltre che la formazione specialistica del personale. Analogamente, a Racale, un impianto fotovoltaico e un sistema di accumulo sono stati integrati nella piscina comunale per testare l’autoconsumo in una struttura pubblica.
Sempre in Europa sudorientale, lungo il confine tra Romania e Ungheria, il progetto ROHU si è invece concentrato sullo sviluppo di una strategia mirata per rendere più ecologico il trasporto pubblico transfrontaliero. Questo sforzo è stato portato avanti attraverso progetti complementari mirati ai collegamenti urbani strategici. Il primo, chiamato “TRANSBORDER”, ha modernizzato i servizi tra i poli urbani di Oradea e Debrecen finanziando nuovi autobus a basse emissioni, aggiornando i sistemi di informazione dei passeggeri, e sviluppando un’app congiunta per la pianificazione dei percorsi.
Sulla falsariga di quanto fatto tra Oradea e Debrecen, il progetto “E-Transport – Green Transport” ha invece investito sul collegamento tra le città gemellate di Jimbolia e Mórahalom, acquistando autobus elettrici e installando infrastrutture di ricarica su entrambi i lati del confine, con il supporto di viaggi di prova transfrontalieri e campagne di sensibilizzazione.
Questo tipo di progettualità, che per quanto abbiano a disposizione fondi sensibilmente meno importanti di altri progetti nazionali, dimostrano come un investimento mirato, pensato, e che cerchi di far fronte in maniera cooperativa a un problema comune tra regioni di paesi diversi, abbinate a pianificazione strategica, allo sviluppo di capacità, e al coinvolgimento della cittadinanza, possano portare a grandi successi sia in termini materiali nell’immediato, con l’acquisto o l’installazione di impianti o veicoli, che con la sensibilizzazione del pubblico e il cambiamento culturale e delle abitudini.
Questo materiale è pubblicato nel contesto del progetto Cohesion4Climate, cofinanziato dall’Unione Europea. L’UE non è in alcun modo responsabile delle informazioni o dei punti di vista espressi nel quadro del progetto; la responsabilità sui contenuti è unicamente di OBCT.
Tag: Cohesion for Climate