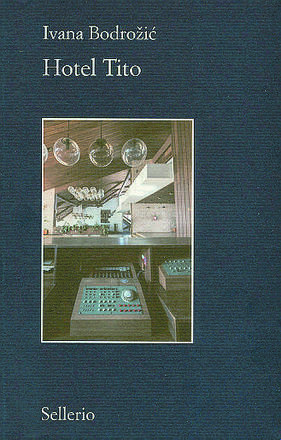Hotel Tito
L’assedio di Vukovar, la fuga dalla città, la difficile convivenza coi parenti e infine l’Hotel Tito a Kumrovec, villaggio natale di Josip Broz Tito. Una recensione del romanzo di Ivana Bodrožić

Hotel-Tito
(Foto © Aleshyn_Andrei/Shutterstock)
“Hotel Tito” è il titolo del romanzo autobiografico della scrittrice croata Ivana Bodrožić pubblicato in Italia da Sellerio, nella traduzione della brava Estera Miočić. Ma è anche il nome che, sarcasticamente, venne dato alla sede della ex scuola del Partito Comunista posta in Kumrovec, la città natale di Tito, nello Zagorje, dove venivano fatti alloggiare gli sfollati da Vukovar nel corso dei lunghi mesi di assedio della città sul Danubio da parte dell’esercito serbo.
Qui, con ogni probabilità, finì la scrittrice Ivana Bodrožić, allora adolescente, sfollata anche lei da Vukovar con madre e fratello, mentre il padre, rimasto in città per opporre resistenza ai serbi, fu poi dato per disperso. Se non lei personalmente, comunque, ci finisce la ragazzina io narrante della storia che, con una scrittura che ben riproduce l’incedere del racconto che potrebbe essere di una tredicenne, di cui pare quasi di sentire la voce, racconta l’odissea di una famiglia, ma potrebbe essere, anzi è, quella di tante famiglie che da Vukovar, e non solo, sono state costrette a fuggire dai bombardamenti, dagli attacchi, dalla guerra che infuriava negli anni che portarono alla dissoluzione della Jugoslavia.
Certamente, comunque, l’autrice ha saputo esprimere con grande verità gli aspetti subliminali che esperienze del genere attraversano le persone che sono costrette a viverle. Il primo approccio negativo che avvertono è intanto il rendersi conto, a un certo momento, di essere mal tollerati. All’inizio può forse non essere così, ma poi, col tempo, le cose cambiano. Così accade che, quando cominciano i bombardamenti e l’occupazione di Vukovar, parenti e amici di altre città si affrettano a offrirti la loro ospitalità, con una inattesa generosità. E così accade, infatti, alla ragazza, al fratello e alla madre, accolti dai parenti a braccia aperte, in una convivenza che all’inizio pare serena, ma poi, con il passare dei giorni diventa pesante e umiliante, per cui da un momento in poi si avverte un cambiamento. “A casa si stava sempre più stretti. Una volta che dovevo andare in bagno, la più grande delle mie cugine si è piazzata davanti a me e mi ha detto: ‘Questa casa è mia, ci vado io per prima’. Il mattino seguente, invece, a colazione la più piccola ha detto a mia mamma: ‘Ci finisci tutto il pane’. All’inizio facevano sempre dolci, ma poi c’è stato meno di tutto, dolci compresi, e noi non ci permettevamo più di aprire il loro frigorifero”.
Diventa urgente la necessità di un nuovo ricovero. Qualcuno parla di un appartamento affittato in nero a una serba che non ci sta mai, ma che ha lasciato lì tutte le sue cose, e propone l’occupazione abusiva. Così fanno e si trovano in un mare di guai, tra polizia e un processo, la cui cronaca andrà sui giornali, per essere stata la loro famigliola difesa gratuitamente da una famosa avvocatessa. E il libro ripropone l’articolo che ne uscì, con il grido disperato della madre che implora: “Non vogliamo beni altrui, vogliamo tornare a casa nostra anche se distrutta. Vi chiediamo solo un tetto e un po’ di comprensione. Siamo costretti a vivere qui; se potessimo ce ne andremmo via anche domani”.
Per cibo e vestiario si appoggiano alla Caritas, mentre la madre trova un lavoro in un negozio di scarpe.
Non possono, al contrario di altri, neppure avere un sussidio, perché il padre risulta disperso, non morto (e devono sopportare anche la malalingua di un nazionalista – che poi si scoprirà essere un vigliacco – che allude a una fuga del padre). Intanto, hanno pure notizia del nonno paterno sgozzato.
Ci sono anche prove di convivenza tra i nonni – la nonna rimasta vedova e i genitori della madre – ma non si sopportano, al punto di venire alle mani. La nonna paterna, esasperata, colpisce il nonno materno con colpi di ciabatte alla testa e urla con le quali gli rinfaccia di essere stato un partigiano “che aveva fatto saltare in aria dei ponti con le bombe”. La necessità di una sistemazione abitativa non così precaria e avvelenata si fa sempre più necessaria, con la madre che, soffrendo d’insonnia, si trova costretta a prendere i sonniferi che le ha dato la dottoressa.
Finiscono nello Zagorje, nei pressi di Zagabria, a Kumrovec, il villaggio natale di Tito, “uno schifoso presidente comunista responsabile di tutto quel casino”, dove avranno una cameretta nella quale vivere tutti e tre. Ci resteranno cinque anni, nonostante le continue lettere scritte a vari rappresentanti della burocrazia proposta agli alloggi. “L’espressione ‘la Commissione alloggi’ aveva per me il suono di qualcosa che viene pronunciato in chiesa o all’università”.
Unico momento di serenità per la ragazza quando una famiglia la ospiterà in Italia, alla periferia di Mantova, per quindici giorni, durante i quali, pur nella nostalgia di casa, della mamma e del fratello, si vedrà vivere in una bella casa, ricevere regali, anche se assai poco gradirà essere presentata come “bambina jugoslava”. Tant’è che ci terrà a precisare: “Croatia, no Jugoslavia, bambina Croatia”.
Intanto gli anni passano. E l’autrice ben descrive i cambiamenti che, pur nelle sempre ristrette condizioni in cui vivono, intervengono nell’adolescente, con i primi innamoramenti, i primi baci, il gusto per essere alla moda. “Sono rimasta a lungo sveglia a letto immaginando di passeggiare con Damir mano nella mano lungo il corridoio della scuola. Non mi sfuggiva nessun dettaglio. Addosso avevo il mio paio di Levi’s, le Converse che avevo portato dall’Italia e un lupetto color bordeaux”.
Per il resto, gli echi della guerra continuano ad arrivare, accendendo speranze e delusioni. La vicinanza della casa di Tito diventa oggetto di maledizioni. “Anche noi ragazze ci vendicavamo dei serbi e dei comunisti scrivendo di tutto e di più nel libro dei ricordi della Casa di Tito, una volta ne hanno persino parlato in tv denunciando la devastazione del patrimonio culturale croato. Io avevo annotato: ‘Compagno Tito, ti ringrazio per la bellissima cameretta che hai riservato a me, a mia madre e a mio fratello, marcisci nell’inferno’”.
Verso la fine del libro verranno a sapere della morte del padre. Una pagina drammatica, di prigionieri fatti ammazzare uno sull’altro come a un macello. Una sequenza lunga e agghiacciante. “L’ultimo prigioniero se la sarebbe vista più brutta di tutti, avrebbe dovuto assistere ad ancora nove ore di sterminio.”
Doveva convincersi che quanto era accaduto a suo padre non fosse una fiction americana “non potendo credere, come tuttora, che le cose fossero andate davvero in quel modo”.
Come purtroppo, invece, sono andate.
È utile sottolineare che “Hotel Tito” è uno dei rari romanzi di croati che parlino apertamente della guerra nella ex Jugoslavia, essendo stata questa per lo più materia degli scrittori bosniaci. Nella narrativa croata questa era sempre rimasta un po’ sfumata, vista da lontano, come un’eco che si riverberava di passaggio su storie che avevano altre priorità. Forse questo libro di Ivana Bodrožić può essere il segnale che qualcosa in questo senso, per una riflessione su se stessi, su una guerra che ha sancito la nascita della loro nazione nel solco di una storia, con le sue luci e le sue ombre, più lontana nel tempo, si stia muovendo.
Tag:
I più letti
 Transizione energetica
Transizione energetica