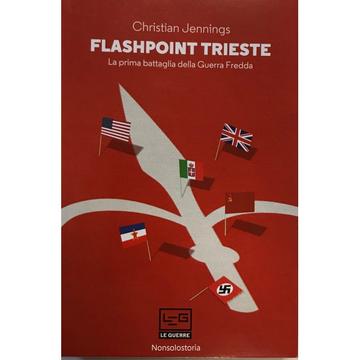Flashpoint Trieste
Lo scrittore Diego Zandel ci offre una recensione e un commento sul libro “Flashpoint Trieste” di Christian Jennings
Leggendo “Flashpoint Trieste”, edito dalla Leg di Gorizia, di Christian Jennings, ho avuto la conferma che gli angloamericani avevano capito ben poco della situazione a Trieste, in Istria e a Fiume quando si trattò di spartire quei territori, dandone gran parte alla Jugoslavia, col dubbio pure di dare al vorace Maresciallo Tito anche Trieste, città che avrebbe dovuto, per altro, attendere quasi dieci anni prima di essere restituita all’Italia. Il peggio è che anche Christian Jennings, quarantacinquenne giornalista inglese, non ci ha capito molto. Tanto più che il sottotitolo del suo libro è “La prima battaglia della Guerra Fredda”.
Sì, perché un lettore che sia almeno un po’ al corrente dei fatti avrebbe potuto pensare che l’autore facesse giustizia, con le sue ricerche, degli eventi che hanno caratterizzato gli anni dell’immediato dopo guerra nella Venezia Giulia e che, davvero, se visti alla luce di quanto stava accadendo sul confine orientale, potevano scatenare la terza guerra mondiale. Jennings ne parla. Parla delle migliaia di persone che, a guerra finita, i partigiani di Tito fecero scomparire nei quaranta giorni in cui occuparono Trieste, accenna agli scomparsi a Fiume dopo l’ingresso dei partigiani in città il 3 maggio 1945 e degli efferati omicidi dei tre capi autonomisti che si opponevano alla Fiume Jugoslava da parte del capo dell’UBDA Oskar Piskulic. Ben racconta inoltre di come segnate le zone A e B del territorio, i partigiani di Tito si prodigavano, nottetempo, per spostare i confini in loro favore. Così come non tace sulle foibe (racconta quella di Basovizza, l’unica in territorio libero), né tace delle migliaia di profughi istriani e fiumani che scappavano dalle loro terre occupate dagli jugoslavi, lasciando case, terreni, lavoro, avi, per essere ricoverati in un primo momento nella famigerata Risiera di San sabba e nel Silos del porto di Trieste e così via. Eventi che da soli, per i crimini commessi in tempo ormai di pace e per il tipo di provocazioni – figli di una impunità che, in quanto tale, non facevano altro che aumentare l’arroganza jugoslava – sarebbero stati più che sufficienti, nel contesto di guerra fredda che si stava profilando, a provocare, appunto, un nuovo conflitto mondiale.
Il rovescio di tutto ciò è che, secondo Jennings, le migliaia di scomparsi a Trieste come a Fiume e in Istria, i morti assassinati, i profughi, non fossero cittadini italiani e partigiani che avevano combattuto per liberare la regione dai nazifascisti e non per regalarla a Tito, bensì per lo più fascisti o ex rappresentanti delle autorità italiane del regime fascista come finanzieri e carabinieri. Pertanto, tutte vittime in qualche modo giustificate, mentre casi come quello dello spostamento dei confini nottetempo derubricati a marachella. Un’adesione, la sua, alle stereotipate tesi propagandistiche titine che non tengono in nessun conto tutta la documentazione oggi ormai accessibile che ha fatto giustizia anche dei tanti eventi sottaciuti per motivi di ragione politica internazionale come le foibe, l’esodo o per ragioni di politica interna come, ad esempio, la strage di Porzus, in cui i partigiani filotitini della brigata Garibaldi uccisero in un agguato 19 partigiani della Brigata Osoppo o come la decapitazione del vertice del PCI triestino che, in opposizione a quello nazionale, voleva la città italiana.
Ma, allora, se la tesi di Jennings è così scontata, dove sta il senso di quel sottotitolo del suo libro, cioè “La prima battaglia della Guerra Fredda”?
Bene, il casus belli è riferito a un episodio minore, che in termini umani nulla rappresenta rispetto alle atrocità titine, e cioè alla reazione da parte di un gurkha indiano al servizio degli inglesi il quale, offeso da un partigiano ubriaco che aveva cercato di sfilargli con la forza il coltello kukri, sacro per i gurkha, aveva finito per decapitarlo. La notizia, sparsasi tra i partigiani (“Uno dei nostri coraggiosi combattenti per la libertà è stato sgozzato barbaramente da un lacché coloniale delle forze alleate filo-italiane” era la voce), aveva sollevato propositi di vendetta tali da mettere in allarme gli angloamericani che per difendere il loro commilitone mossero i loro cingolati contro i partigiani. A riguardo, racconta Jennings: “Tutto era chiaro agli occhi di Norton (l’ufficiale che si fa mediatore tra i contendenti nel caso specifico n.d.r). Era la Terza Guerra Mondiale.”
Il che sottolinea una cosa sola: che gli angloamericani erano tanto insensibili alle sorti delle genti giuliane quanto invece lo erano per quella di un solo loro commilitone. Probabilmente, credo, anche per ignoranza della realtà del territorio. Sarà un caso che Alfred Connor Bowman, comandante della zona A si sia trovato a scrivere anni dopo nelle sue memorie: “La nostra incapacità di agire concretamente e di produrre risultati tangibili deluse profondamente la popolazione locale e per noi si tradusse in una costosa perdita di credibilità”?
Il peggio è però non tanto che non lo capisse allora Bowman e i suoi, ma anche chi, come Christian Jennings, ha oggi tutti gli strumenti per capirlo.
A MARGINE DI FLASHPOINT TRIESTE
A margine della recensione aggiungo un ricordo personale relativo a mio padre che a 18 anni andò “in bosco”, come si usava dire, cioè uscì di casa, a Fiume, per andare con i partigiani. Lo fece non per motivi ideologici bensì, come mi disse, perché lo facevano tutti (l’alternativa per i giovani era la Todt, l’organizzazione di lavoro forzato tedesca che operava in sinergia con i comandi militari, com’era accaduto con il fratello di mia madre, ritrovatosi poi nel campo di concentramento di Müldorf in Germania). Mio padre si trovò così arruolato nella 20° Divisione della IV Armata, comandata dal generale Petar Drapšin, un criminale di guerra: a riguardo, come ricorda lo stesso Jennings, “le stragi compiute dagli uomini di Drapšin sono raccontate da Sava Soko nel suo libro Krkavo Kolo Hercegovacko, Podgorica, Montenegro, 1995” dove lo descrive come "una persona psicologicamente instabile il cui stato era al limite della vera e propria pazzia".
Mio padre, in quanto italiano non era neppure armato e adibito ai lavori più bassi, una condizione che anche Rosario Bentivegna, l’autore della strage di via Rasella, ricorda nella sua biografia, quando si trovò a combattere su quel fronte. Quanto a mio padre si vantava: “Non ho mai sparato un colpo”. E finché ero ragazzo non mi ha mai voluto raccontare altro, tenendomi all’oscuro di quella sua stagione della quale, conoscendo il suo anticomunismo, pensavo si vergognasse. Poi un giorno, ero già adulto, marito e padre, mi ha parlato. Mi disse che era diventato anticomunista stando con i partigiani di Drapšin, per le violenze a cui aveva assistito, alle tante persone che aveva visto impiccare ai lampioni delle strade, ai colpi alla nuca a cui aveva assistito con ribrezzo. Si fece, in quelle condizioni, la campagna della Lika per poi ripiegare con l’armata verso Trieste, nella corsa che doveva servire a occupare la città prima delle forze angloamericane. Seguirono i famosi 40 giorni di occupazione titina contrassegnati da omicidi e sparizioni di quanti non accettavano l’occupazione. Fu per mio padre, stanco di tutte quelle violenze, il momento di prendere una decisione, e fu quella di disertare. Fuggì da Trieste per tornare a casa, a Fiume, dove, non appena mise piedi, i partigiani lo arrestarono. A nulla valsero le sue spiegazioni. Lo fecero uscire in occasione di una tragedia famigliare: la morte della sorella Lidia, investita da una jeep guidata da un partigiano ubriaco. Fu il prezzo della sua liberazione.
Quanto a Trieste, dove continuavano le sparizioni, scrive Jennings nel suo libro che Wilkinson (uno dei capi dell’intelligence inglese n.d.r) sapendo “che era lui (il generale Drapšin) che aveva appena preso sotto il suo controllo la costa dalmata, la regione slovena dell’Istria e la stessa Trieste” e “sapendo come aveva trattato i suoi avversari, fossero essi fascisti o d’altra ideologia, la popolazione di Trieste che si trovava sotto il suo controllo non poteva che avere cattivi presentimenti”, diede deciso l’ordine di procedere direttamente verso il centro di Trieste, consentendo così ai carriarmati Sherman del 20° Reggimento dei Royal Tank di abbattere un posto di blocco che si trovava un chilometro e mezzo oltre al castello di Miramare e di entrare in città. “Gli italiani” scrive Jennings “li accolsero con rumoroso entusiasmo”, guardati in silenzio dai partigiani sloveni.
Mi chiedo ancora come gli angloamericani, date le condizioni a cui andava sottomettendosi la popolazione istriana si accontentarono di battersi solo per la liberazione di Trieste e non, almeno, di tutta la costa, a prevalenza italiana, fino a Pola che nello stesso periodo stava vivendo un’altra non minore tragedia che si sarebbe consumata con l’esilio di quasi tutti i suoi abitanti.
Tag:
I più letti
 Transizione energetica
Transizione energetica