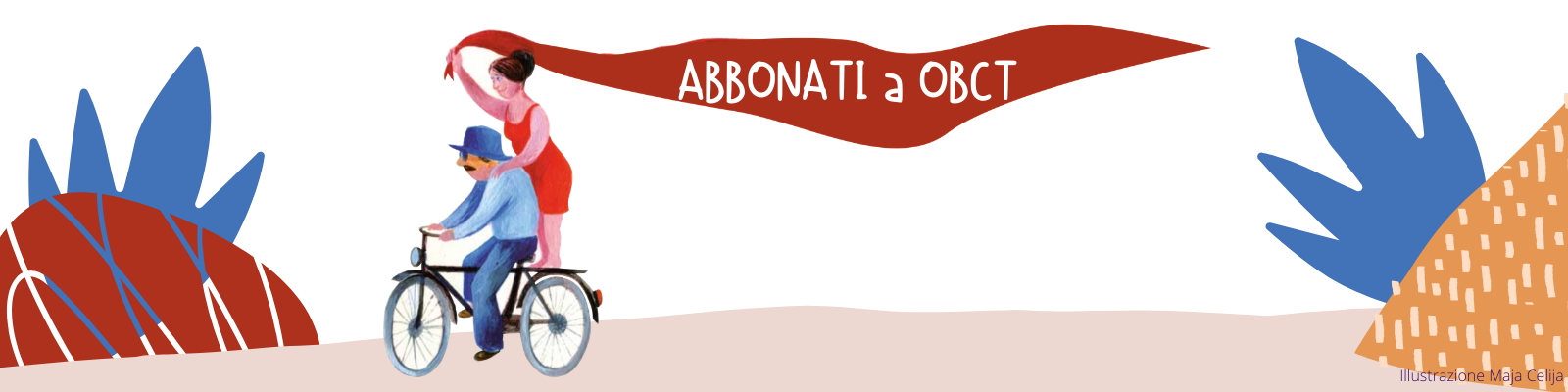Delta del Danubio: tra sfide ambientali, turismo in crescita e comunità in bilico
La foce del grande fiume europeo è in continua trasformazione ed attraversa multiple crisi ambientali e fragilità sociali. Fondi europei e nuovi progetti cercano di coniugare tutela delle risorse ambientali e sviluppo locale

Delta-del-Danubio-tra-sfide-ambientali-turismo-in-crescita-e-comunita-in-bilico
Tramonto sul lago Gorgova, Delta del Danubio - foto di Marco Ranocchiari
Nel suo labirinto di canali, laghi e lagune in continua trasformazione, il Delta del Danubio ospita habitat unici, rifugio di innumerevoli specie di uccelli e pesci simbolo come lo storione. Ma queste terre remote hanno anche accolto, da sempre, pescatori, commercianti e fuggiaschi di diverse lingue ed etnie.
Oggi questo microcosmo – Patrimonio Unesco dal 1991 – affronta sfide intrecciate. A quelle ambientali, come il cambiamento climatico, l’inquinamento proveniente dai tratti a monte del fiume e dall’agricoltura, l’erosione costiera e l’insabbiamento dei canali, si sommano quelle sociali.
Attività tradizionali come la pesca sono condizionate non solo dalla salute degli ecosistemi, ma anche dalle restrizioni del parco, in assenza di adeguate alternative o compensazioni. Il turismo, in rapida crescita, apre nuove prospettive ma rischia di alterare ulteriormente equilibri già fragili. Per affrontare queste trasformazioni, l’amministrazione dell’area protetta si affida anche a progetti europei sostenuti dalle politiche di Coesione.
Sfide complesse, poca autonomia
“L’autorità della Riserva della Biosfera del Delta del Danubio è stata istituita da una legge parlamentare nel 1990”, spiega Georgeta Ivanov, ispettrice ecologica e consigliera dell’ente, nel suo ufficio affacciato sul Danubio, a Tulcea. “Oggi affrontiamo sfide complesse, dove fattori ambientali e sociali si intrecciano”.
Tra le questioni più delicate c’è il rapporto con le attività locali, in particolare la pesca, che resta non solo una tradizione, ma una fonte essenziale di reddito per molti villaggi. “I pescatori chiedono compensazioni, ad esempio perché non possono catturare specie più redditizie come lo storione”, continua Ivanov. Ma le misure, stabilite dal governo, sono spesso insufficienti. Sul ramo di Chilia, al confine con l’Ucraina, la guerra ha aggravato la situazione, tra controlli di frontiera e restrizioni agli spostamenti.
Il cambiamento climatico complica ulteriormente il quadro. “Le variazioni del livello dell’acqua sono sempre più repentine. L’anno scorso, dopo l’estate, il fiume è calato bruscamente, rendendo difficile ai pescatori raggiungere le quote previste”. In queste condizioni, pesca illegale e bracconaggio continuano a prosperare.
Anche l’agricoltura, introdotta su larga scala durante il comunismo, crea tensioni: spesso poco redditizia, contribuisce all’inquinamento. Ma non mancano esperienze positive: in alcune zone, al posto dei campi sono tornate le aree umide, grazie a interventi di ripristino sostenuti anche dalla popolazione. Qui sono tornati gli uccelli acquatici, seguiti da turismo naturalistico e birdwatching.
Il turismo, fino a poco tempo fa marginale, oggi è in pieno boom. Ma non sempre in modo sostenibile. “Manca consapevolezza”, osserva. “Molti vogliono tutto, subito, senza pensare alla biodiversità”.
Le trasformazioni naturali del delta sono rese più critiche dagli interventi umani. Le canalizzazioni costruite nel secolo scorso per la navigazione hanno alterato la distribuzione dei sedimenti, che si accumulano in alcune zone. Diversi laghi si sono abbassati, favorendo l’eutrofizzazione. Sulla costa impoverita di sedimenti a causa delle dighe, invece, imperversa l’erosione.
“Per affrontare tutto questo servirebbero più risorse”, continua Ivanov. “Abbiamo un certo margine di autonomia: un comitato scientifico approva il piano di gestione e un consiglio consultivo include i rappresentanti locali. Ma il nostro bilancio dipende dal Ministero, e i fondi statali non bastano”. Il sostegno europeo diventa quindi essenziale. “Molti dei nostri progetti si basano su finanziamenti UE, soprattutto dal programma LIFE, ma anche dal PNRR e dai fondi di coesione”.
Questi ultimi, inclusi nel Programma di sviluppo sostenibile 2021–2027, finanziano interventi per oltre 18 milioni di euro.
Proteggere, controllare, ripristinare
Il progetto più sostanzioso (9,16 milioni) riguarda il controllo del territorio. Soprannominato “Balize” (boe segnaletiche), mira a proteggere habitat e specie nelle aree più sensibili. “Lo scopo è creare limiti inequivocabili per queste aree, fermando sia le barche dei turisti che dei locali. È fondamentale”, dice Ivanov. “Con meno di 50 ranger su 580.000 ettari è difficile controllare il territorio”.
Altri progetti importanti riguardano la conservazione di specie vulnerabili. Uno, del valore di 4,8 milioni di euro, si concentra sui pesci migratori, in particolare lo storione e l’alosa del Danubio. Partito nel 2020 e attivo fino alla fine del 2025, il progetto si coordina con altri relativi alla conservazione del pesce che può raggiungere svariati metri di lunghezza e che, con il suo caviale, ha fatto la fortuna di non pochi pescatori. Dalla stazione galleggiante di Tulcea, oggi, sono allevati oltre 15.000 avannotti che andranno a rimpolpare la popolazione in fragile ripresa.
Un altro progetto, da 1,9 milioni, mira a salvare il visone europeo, sulla lista rossa IUCN delle specie in pericolo critico. Questo mammifero, un tempo diffuso in tutto il continente, oggi è confinato ad alcune aree isolate tra la Spagna e la Russia e, il Danubio è uno dei suoi ultimi rifugi. L’idea del progetto è consolidarne la popolazione creando ambienti favorevoli nei canali del braccio meridionale del fiume, quello di San Giorgio.
I progetti idrologici
Per contrastare l’accumulo di sedimenti, sono stati avviati tre progetti volti a migliorare il regime idrologico in diversi complessi lagunari e lacustri, tramite interventi di dragaggio e disostruzione, per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro. Le aree coinvolte includono i laghi interni di Gorgova, Roșu e Puiu, oltre alla grande laguna d’acqua dolce di Razim .
Affinché questi interventi siano davvero efficaci nel lungo periodo, è però necessario comprendere meglio le dinamiche idriche del delta. Su questo fronte sono attivi progetti di ricerca come Delta-Hub , ancora nelle fasi iniziali.
Il nuovo piano punta sul turismo lento
Garantire un futuro alle comunità del Delta non è solo una questione di giustizia sociale, ma una condizione necessaria per la sopravvivenza stessa della Riserva. Gli abitanti hanno conservato stili di vita e pratiche tradizionali – dalla pesca all’allevamento in condizioni semi-selvagge – che esistono solo qui, in un equilibrio fragile con l’ambiente.
A questa ricchezza si aggiunge il patrimonio culturale e antropologico, con la presenza di minoranze etnico-religiose come i lipovani, discendenti dei Vecchi credenti fuggiti dalla Russia nel Seicento, le cui case colorate e chiese dalle cupole dorate punteggiano l’orizzonte piatto del Delta.
Con un progetto da 8,7 milioni di euro – finanziato in parte con fondi europei – la Riserva sta elaborando un nuovo piano di gestione, che aggiornerà quello in vigore da dieci anni. L’obiettivo, spiega Ivanov, è integrare meglio tutela ambientale e attività umane, mettendo al centro i bisogni delle popolazioni locali.
“Il turismo rappresenta un’opportunità sempre più importante”, afferma, “ma servono soluzioni che lo rendano davvero sostenibile”. Per questo, la Riserva punta su formule che permettano agli abitanti di trarne benefici economici senza rinunciare alle attività tradizionali.
Tra le iniziative previste ci sono i “punti gastronomici”: luoghi dove i pescatori potranno cucinare e servire direttamente piatti a base di pesce locale, aumentando i propri guadagni e riducendo la pressione sulla pesca intensiva. È previsto anche lo sviluppo del “pescaturismo”, che consentirà ai visitatori di affiancare i pescatori nelle loro attività quotidiane.
Il tutto – aggiunge – senza dimenticare forme già radicate di turismo lento: dal naturalistico all’itinerante, sia lungo i corsi d’acqua che lungo i sentieri, fino al turismo rurale, che prevede il soggiorno nelle case degli abitanti del Delta.
Partecipazione: un nodo ancora aperto
Non tutti guardano con fiducia al nuovo piano di gestione, per il quale, nella primavera 2025, si è aperta la fase delle consultazioni pubbliche. Le critiche riguardano non solo il contenuto, ma anche il processo. In una lunga lettera inviata al Ministero dell’Ambiente, la fondazione “La Porțile Deltei” e l’associazione dei pescatori del delta hanno denunciato la difficoltà, per la società civile, di partecipare attivamente, anche a causa dell’enorme mole della bozza – oltre settemila pagine.
Secondo i pescatori, le misure previste per contrastare il bracconaggio sarebbero insufficienti, mentre la pesca ricreativa, praticata anche da residenti, verrebbe penalizzata in modo eccessivo. Le vere minacce, scrivono, sarebbero altrove: “nell’inquinamento causato dal turismo mordi e fuggi, con centinaia di motoscafi, e nella presenza di strutture ricettive alimentate da pesce bracconato”.
Chiunque abbia ragione, il futuro del Delta non può prescindere dal coinvolgimento attivo delle sue comunità. Oltre a piani e fondi, serve una reale partecipazione. L’Europa potrebbe – e forse già in parte lo fa – incentivarla.
Questo materiale è pubblicato nel contesto del progetto Cohesion4Climate, cofinanziato dall’Unione Europea. L’UE non è in alcun modo responsabile delle informazioni o dei punti di vista espressi nel quadro del progetto; la responsabilità sui contenuti è unicamente di OBCT.
Tag: Cohesion for Climate