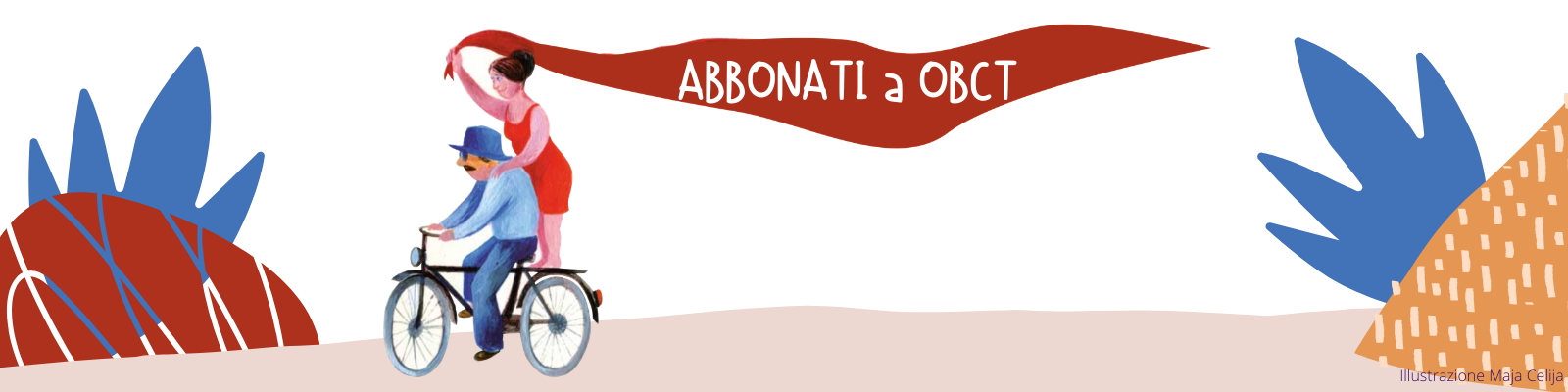Da Srebrenica a Gaza, di genocidio in genocidio
A trent’anni dal genocidio di Srebrenica assistiamo in diretta streaming ad un altro genocidio. Ciò per cui ci siamo spesi e le istituzioni che sono scaturite dalla tragedia di allora non sono riuscite ad impedire la cancellazione di Gaza. Una riflessione di Luisa Chiodi, direttrice di OBCT, e un invito a cuore aperto a non arrendersi alla rassegnazione

Da-Srebrenica-a-Gaza-di-genocidio-in-genocidio
Magliette in solidarietà alle vittime palestinesi: "8372 dal silenzio di Srebrenica alle urla di Gaza 56000" © foto Barbara Pasquariello
Paralizzata dall’angoscia, nelle settimane scorse, non ho trovato la forza di scrivere delle commemorazioni per i trenta anni dal genocidio di Srebrenica. Non sono riuscita a lasciarmi andare alla retorica sulla complicità europea mentre assistiamo in diretta streaming ad un altro genocidio con l’evidente sostegno materiale e politico anche del nostro paese.
Anni fa, quando ad OBCT producevamo le prime riflessioni sul tema dell’elaborazione del passato, era già chiaro che la retorica del “mai più” serviva ad un rituale sempre più vuoto. Ma chi di noi si immaginava di assistere impotenti alla cancellazione di Gaza?
Negli anni ‘90 avevamo a disposizione fin dalle prime fasi della guerra di dissoluzione jugoslava il Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia, l’ICTY, che ha consentito di processare ideologi ed esecutori materiali dei crimini contro l’umanità ai più alti livelli politici e militari. C’erano aspetti del suo impianto giuridico che ci mettevano in difficoltà allora, tra cui i patteggiamenti per il crimine di genocidio. Ma senza dubbio l’ICTY ha compiuto un lavoro fondamentale anche di ricostruzione della verità storica di quanto avvenuto nelle guerre di dissoluzione jugoslava.
Inoltre, l’esperienza dell’ICTY aveva dato nuovo slancio al diritto penale internazionale e come coda di quella esperienza nasceva proprio a Roma quella Corte Penale Internazionale che oggi dovrebbe processare Putin, Netanyahu oltre a personaggi come Almasri e tutti coloro che commettono gravi violazioni dei diritti umani nel mondo.
Il diritto internazionale, storicamente strumento dei forti, ed in particolare utile alla colonizzazione occidentale del mondo, cercava di diventare uno strumento a disposizione dei più deboli sul piano internazionale, come avviene, almeno parzialmente, con i diritti fondamentali a livello statuale e di Unione europea .
A tenere vive le convinzioni del passato oggi c’è lo straordinario lavoro di Francesca Albanese , Relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, che scandalosamente gli Stati Uniti di Trump hanno deciso di colpire con sanzioni ad personam.
Anche gli sviluppi della giurisdizione universale , seppure estemporaneamente, ci consentono di aggrapparci alla speranza che non sia tutto finito. Come è successo anche qualche settimana fa quando due soldati israeliani sono stati arrestati in Belgio con l’accusa di crimini contro l’umanità per la loro condotta a Gaza.
Ma è davvero difficile oggi non restare schiacciati di fronte al fatto che sono gli stessi paesi occidentali a svuotare di senso l’ordine internazionale faticosamente costruito negli ottanta anni che ci separano dalla fine della Seconda guerra mondiale.
Indubbiamente commemorare il genocidio di Srebrenica ha il grande valore di aiutare i sopravvissuti ad elaborare il lutto ma oltre alla speranza del “mai più” e del diritto internazionale come deterrente, anche la politica della riconciliazione post-bellica attraversa una crisi profonda.
L’esperienza di Srebrenica porta a pensare che ottenere il riconoscimento giuridico del genocidio e commemorare le vittime non sia servito alla trasformazione della Bosnia Erzegovina dove la situazione politica resta alquanto tesa, il rischio di secessione dell’entità del paese nata proprio dal genocidio – la Republika Srpska – è pressante e il paese resta bloccato dalle conseguenze di lungo periodo di quella tragedia. In Bosnia Erzegovina non si riesce a far emergere una visione del futuro, che prenda atto di quale sia l’ideologia che ha portato alla catastrofe: ovvero il nazionalismo etnico.
Francesca Melandri nel suo toccante “Piedi freddi ”, quando ragiona sulla differenza tra la colpa e la responsabilità collettiva, aggiunge un punto importante prendendo spunto dalla ritirata dell’esercito italiano dall’URSS – che in realtà era per lo più la ritirata dall’Ucraina dove oggi si combatte per difendersi dall’aggressione russa, come l’autrice reitera nel volume. La colpa per il diritto penale è individuale mentre la responsabilità collettiva dovrebbe riguardare tanto l’onere della memoria del passato da tramandare tra generazioni quanto l’impegno verso il futuro. Questo dovremmo poter fare a Kyiv come a Gaza.
Ottenere che i responsabili siano processati, commemorare le vittime per lenire il dolore dei sopravvissuti e, consapevoli delle responsabilità passate e presenti della propria parte politica, etnica o statuale, assumersi la responsabilità sul futuro.
Sì ma quale futuro? E qui purtroppo il pensiero corre al desolante contesto politico del paese rinato sulle ceneri della Shoah: la Germania che avevamo guardato con ammirazione per avere fatto i conti con il passato. È semplicemente sconcertante rendersi conto che in realtà la redenzione tedesca si sia concretizzata nell’ottuso e incrollabile sostegno ad Israele. Come se la colpa per lo sterminio di un popolo si potesse superare con la difesa ad oltranza del diritto ad uno stato etnico per i sopravvissuti, fino alla distruzione di un altro popolo.
Dove si fatica a pensare al futuro, non possiamo permetterci di disperare, serve superare l’orrore verso quanto sta accadendo. Abbiamo l’onere di combattere contro la rassegnazione di fronte al mondo distopico che si sta delineando davanti a nostri occhi.
Per il futuro dell’Ucraina, in risposta all’aggressione russa su larga scala dal 2022, l’UE ha avviato il processo di integrazione europea, pur con difficoltà e contraddizioni.
Per la Palestina, invece, è necessaria una larga mobilitazione dal basso per ottenere che il nostro paese e l’Unione Europea smettano di essere complici del genocidio . Dobbiamo unirci alle iniziative di boicottaggio di Israele e di chi lo sostiene e, naturalmente, dobbiamo sostenere chi lotta per realizzare il sogno di far nascere in Palestina un paese per tutti coloro che lo abitano dal fiume al mare, senza discriminazioni.
La solidarietà con gli oppressi, come ricorda Ahmed Eldin , non è un sentimento, è una scelta, un obbligo morale e politico che va assunto senza paura di avere un prezzo da pagare.
Negli anni ’90 la spinta internazionalista era forte e incontrava meno ostacoli di oggi. Dominava la convinzione che la società civile potesse ovviare agli errori dei nostri governi. Con meno mezzi tecnologici a disposizione c’era una copertura mediatica migliore e non si viveva la repressione poliziesca che oggi incontra chi manifesta a sostegno dei palestinesi. Ma non dimentichiamo che prestando aiuto ai civili durante la guerra in Bosnia Erzegovina anche 4 attivisti italiani vennero uccisi in diverse circostanze.
La brutalità, la crudeltà assurda, la violenza cieca a cui abbiamo assistito trent’anni fa e che stiamo vivendo ancora una volta è la storia dell’umanità a cui non possiamo arrenderci. Con l’esperienza storica che ci schiaccia e sapendo che potremo fallire di nuovo, non possiamo esimerci dal batterci per la giustizia e la tutela universale dei diritti umani perché dobbiamo essere coscienti che oggi più che mai, nel mondo interconnesso in cui viviamo, la disumanizzazione di alcuni prelude alla distruzione dell’umanità intera.