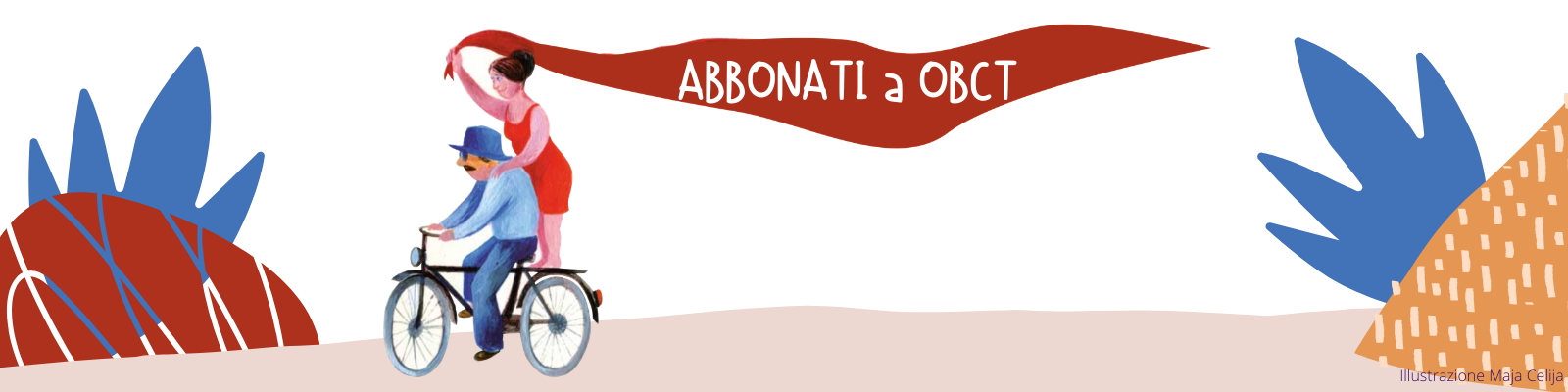Cronache danubiane: la foresta ungherese
Quarto anno di Danubio. I camminatori di Fuorivia ripartono dalla Croazia per risalire il grande fiume fino a Budapest. Tema ricorrente di questa stagione, le grandi riserve di caccia adiacenti al Danubio, simbolo di status per clero, nobiltà e capi di partito durante la guerra fredda

Cronache-danubiane-la-foresta-ungherese
Piattaforme sul Danubio - Foto © Vincenzo Cammarata
Sembra un déjà-vu. Mentre ci inoltriamo nella fitta vegetazione della foresta di Gemenc, in Ungheria, qualcosa ci riporta a qualcos’altro. Qualcosa di già visto. Non camminiamo all’asciutto di terrapieni arsi dal sole. Le betulle, i pioppi, i sambuchi, la vegetazione acquatica, i canneti, i salici, le ninfee, la canopea che sovrasta i sentieri… Tutto rimanda, con i dovuti distinguo, a un paesaggio che avevamo già visto. Certo, non è il Delta del Danubio. Ma i meandri del fiume, la miriade di sentieri e corsi d’acqua che si snodano tra la vegetazione, ci riportano a luoghi di mille chilometri fa. “Le corse del trenino sono state limitate alla fermata di Malomtelelő. Qualche tempo fa, il Danubio ha danneggiato un tratto della ferrovia. Da Malomtelelő mancano oltre dieci km al limite nord del parco. Dovrete farli a piedi. Seguite la pista blu”, spiega Tamas Barabas, guardiaparco della foresta.
Camminiamo nella pianura alluvionale più grande d’Europa. Eppure, nonostante sia oggi riconosciuta come area selvaggia protetta, la Foresta di Gemenc è stata in passato tutt’altro.
Iniziamo subito col dire che fa parte del Parco Nazionale del Duna-Drava, e l’attenzione è oggi tutta rivolta alla conservazione della sua natura alluvionale, alla gestione degli ecosistemi, al ripristino dell’idrosistema.
Ma un tempo, questa riserva era un bacino di legname e selvaggina da sfruttare senza mezzi termini. Il trenino diesel a scartamento ridotto sul quale viaggiamo, è stato ideato nel 1920 proprio per il trasporto del legname ricavato dalla riserva. Ora è dedicato per lo più ai visitatori, ma la sua funzione originaria non è stata del tutto eliminata.
Bisogna partire da lontano e risalire alla fondazione di Kalocsa, intorno all’anno mille. Circa 30 km a nord est, la città è sede di un antichissimo arcivescovato che per secoli ha posseduto la riserva di Gemenc. Si narra di cacce leggendarie in queste zone, dove l’attività venatoria era privilegio esclusivo di nobili e clero.
Il XIX secolo è, un po’ in tutta Europa, un periodo di imponenti opere di ingegneria fluviale per irreggimentare le acque. Alterazioni che hanno un impatto indiretto ma innegabile sulla foresta e sul sistema idrologico del fiume: taglio dei meandri del Danubio, argini per impedire le inondazioni naturali delle piane; creazione di canali di drenaggio per un maggiore controllo delle acque.
Dopo la Seconda guerra mondiale e la riforma agraria, i diritti di caccia in Ungheria passano sotto il controllo dello Stato. Gemenc, con la sua eccezionale popolazione di cervi rossi, è una delle riserve più prestigiose e viene interessata dalla dottrina economica di produzione centralizzata, con scarso interesse per la protezione ambientale. Il regime socialista, pur abolendo le grandi proprietà private e nazionalizzando le riserve di caccia, di fatto reinterpreta l’antica tradizione venatoria di privilegio. Un privilegio di cui si appropria la nomenklatura comunista come simbolo di status, riadattandolo a beneficio delle élites al potere durante il periodo sovietico. Capi di stato di altri paesi del blocco arrivano a frotte per le battute di caccia, utilizzate come strumento diplomatico e leva di potere per stringere legami politici.
In un sistema che predica l’uguaglianza, queste consuetudini sono la proverbiale eccezione alla regola: la nomenklatura pratica la caccia esclusiva nelle riserve dell’ex aristocrazia.
Caccia come metafora di uno stile di vita elitario che, dal dopoguerra alla caduta del muro di Berlino, è segnato dai nuovi elementi che si scontrano con i vecchi, rimodellando antichi schemi: anche durante l’epoca del socialismo di Stato, la distinzione di classe si trasmette attraverso la funzione sociale dei comportamenti, dei gusti, delle interazioni.
Avevamo già incrociato, camminando in Croazia, il casino di caccia di Tikves, nazionalizzato dal Maresciallo Tito – formidabile doppietta – che ne fece una delle sue residenze venatorie. E anche qui, in Ungheria, il presidente dell’ex repubblica di Jugoslavia era illustre ospite alle battute di caccia organizzate dai suoi omologhi del blocco orientale, inclusa Gemenc.
Esemplare è, ad esempio, l’incontro segreto che si svolse nella riserva di caccia di Šilovo nel 1968, quando i leader del Patto di Varsavia, compreso Leonid Brežnev, si incontrarono per discutere la situazione in Cecoslovacchia. Un incontro che è parte di una narrazione storica confermata da numerose fonti secondarie. Per queste riunioni "segrete" si utilizzavano appunto luoghi appartati come le riserve di caccia. Un modo per mantenere la segretezza e la discrezione, evitando che le attività fossero rese pubbliche e soggette allo scrutinio di osservatori occidentali.
Il tema venatorio ci insegue fin dalla Croazia: cervi, caprioli e intere famiglie di cinghiali attraversano il nostro cammino praticamente ovunque. Anche la scenografia dei nostri alloggi e delle nostre pause è segnata dal tema della caccia: siamo ospitati in “hunting lodge” e pranziamo in padiglioni pubblici destinati ai cacciatori.
È dunque difficile ignorarla, con buona pace dei detrattori. Motivo per cui scegliamo, per la consueta lettura mattutina nei pressi di Szekszárd, un vecchio articolo de L’Unità, che parla proprio della riserva di Gemenc. L’articolo è in terza pagina: 8 luglio 1969. Appare accanto al bollettino sulle condizioni degli astronauti Neil Armstrong e Michael Collins, a bordo della navicella Apollo 11 attesa sulla Luna per il 20 dello stesso mese.
Siamo in piena guerra fredda. Dopo i sanguinosi fatti d’Ungheria di tredici anni prima, adesso a capo del governo c’è János Kádár. Lui e il suo partito, sostenuti dall’Unione Sovietica, istituiscono la politica economica del "Goulash Communism", un approccio che, pur mantenendo il controllo autoritario, cerca di bilanciare la pianificazione centrale con elementi di libero mercato per migliorare il tenore di vita, soprattutto nel quadro della riforma agraria.
E, in effetti, la nostra lettura mattutina fa trapelare alcuni elementi di questo passaggio. Si parla già in termini più inclusivi delle battute di caccia, organizzate dall’Associazione Nazionale dei Cacciatori e dalla Mavad, l’impresa statale per il commercio della selvaggina. “Oramai non c’è angolo del paese che non sia interessato alle carovane di cacciatori e pescatori provenienti da ogni parte d’Europa”, si legge nell’articolo. Non più solo privilegio delle élites, dunque. E anzi appare anche una parola destinata a segnare le vite di milioni di europei, e che oggi riempie le pagine social dei nostri tempi: turismo.