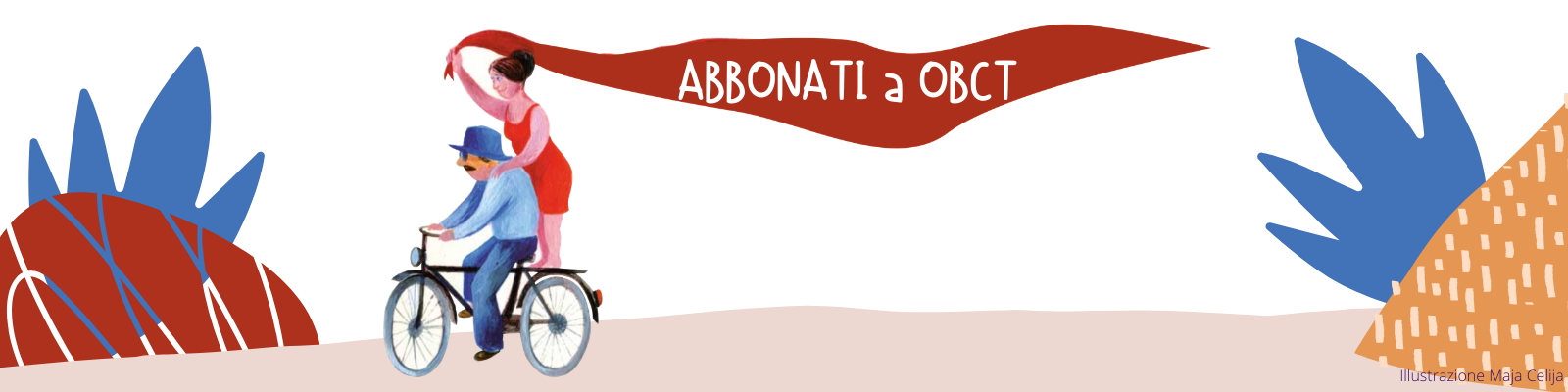Croazia: memoria e oblio, nell’ex campo di concentramento di Arbe
Un’isola croata, apprezzata per il turismo ma con un passato poco conosciuto legato a crimini di guerra: è Arbe (Rab), fino al settembre 1943 campo di concentramento fascista con quasi quindicimila internati, tra cui molti sloveni, ma anche croati ed ebrei

Kampor,Memorial,World,War,Ii,Prisoners,Concentration,Camp,,Island,Of
Il memoriale di Kampor, Rab, Croazia © xbrchx/Shutterstock
(Originariamente pubblicato da Le Courrier des Balkans, il 19 ottobre 2025)
Sotto il limpido cielo di ottobre, nel pieno di un’estate prolungata, è difficile immaginare l’orrore che ha segnato la storia dell’isola di Arbe (Rab). Una targa commemorativa, eretta dalla Repubblica di Slovenia per rendere omaggio alle vittime, testimonia la devastante crudeltà del campo fascista italiano allestito nei pressi del villaggio di Kampor e attivo dal 27 luglio 1942 all’11 settembre 1943. Quasi quindicimila internati, tra cui molti sloveni, ma anche croati ed ebrei, vi sopportarono sofferenze indicibili in condizioni disumane segnate da carestia, disidratazione, malattie infettive e violenza.
Molti persero la vita nel campo, mentre altri, sopraffatti dalle conseguenze dell’internamento, morirono poco dopo il trasferimento in altri campi, in particolare in quello di Gonars, in Friuli, oppure al ritorno a casa. Le cifre ufficiali non raccontano tutta la storia: sono ufficialmente registrati 1488 morti, tra cui 163 bambini sotto i quindici anni, vittime innocenti di una barbarie indicibile.
Una storia poco conosciuta
All’ingresso di questo luogo commemorativo, un’altra targa racconta una storia silenziosa, ma agghiacciante. Mostra bambini affamati sull’orlo della morte, case bruciate, una vista panoramica del campo con tende e baracche, le sezioni separate per uomini e donne. Altre immagini catturano la distribuzione del cibo, poi la partenza degli italiani dopo la capitolazione dell’8 settembre 1943 e la nascita della famosa brigata partigiana di Arbe, formata da cinque battaglioni con 1.700 combattenti, tra cui una formazione composta da ebrei.
Nel settembre del 1943, i combattenti di questa brigata disarmarono i soldati italiani e misero in sicurezza gli edifici principali. Una mappa rivela la disposizione del campo: l’ex cimitero, un bunker, un posto di comando… È sufficiente osservare una di queste immagini per essere sommersi da una sensazione di orrore.
Entrando in quest’area monumentale, circondata da un muro a secco e immersa nella bellezza autunnale del paesaggio insulare, ci si sente travolti da una profonda emozione. Progettato nel 1953 dal famoso architetto sloveno Edvard Ravnikar, il monumento incorpora con delicatezza alcuni simboli sloveni e croati. Qui, il passato viene rievocato in maniera ancora più intensa.
Le tombe, disposte in file, recano 1.056 piccole targhe metalliche con nomi e cognomi, alcuni ormai sbiaditi, offrendo ancora un barlume di speranza che la memoria dell’umanità possa restare viva.
Ci si imbatte anche in una targa commemorativa con incisi i 1.488 nomi delle vittime del campo di concentramento. Una testimonianza che invita intimamente il visitatore a chiedersi se, tra queste vittime, ci sia forse uno dei suoi antenati. Tra gli altri monumenti, c’è un tumulo ellittico dedicato ai primi diciannove internati morti, poi una colonna di pietra che commemora gli ebrei e una targa in memoria del battaglione ebraico della brigata di Arbe. Ogni dettaglio di questo luogo, così come il mosaico del pittore sloveno Marij Pregelj, rievoca il dolore di una tragedia umana. Alcune tombe sfidano l’oblio e il tempo: nel luogo di un sepolcro i parenti della vittima hanno deposto una targa di marmo, vicino ad un’altra sepoltura un visitatore ha acceso una candela, lasciando un fiore, come ultimo gesto di ricordo.
La classe politica italiana ancora tace
L’11 settembre del 1943, gli internati, con il sostegno degli abitanti dell’isola, liberarono il campo di concentramento. Lo stesso giorno, scortarono le guardie italiane alle navi dirette in Italia, come testimonia una fotografia esposta all’ingresso del memoriale. Ufficialmente, il campo fu chiuso il 19 settembre 1943, quando l’ultimo internato fu evacuato.
Oggi, questo luogo di sofferenza sembra pian piano scomparire dalla memoria collettiva degli sloveni, che però amano l’isola come meta turistica. Le giovani generazioni imparano poco su questo capitolo della storia a scuola, quindi è soprattutto all’interno delle famiglie che si decide se mantenere viva la memoria o lasciarla svanire.
Eppure, ogni anno, le autorità slovene e croate, in collaborazione con il comune di Arbe e le organizzazioni dei veterani, commemorano l’anniversario della chiusura del campo di concentramento. Il sito è stato recentemente ricostruito grazie all’impegno dei due governi.
Anche quest’anno, durante la cerimonia organizzata in occasione dell’ottantaduesimo anniversario della chiusura del campo, sono risuonate parole potenti, rivolte soprattutto ai giovani: “Siate custodi della memoria. Solo conoscendo il passato potete costruire un futuro diverso”. E, per citare Primo Levi: “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”.
E la parte italiana? Alla cerimonia dello scorso 6 ottobre era presente solo Fabrizio de Sanctis, rappresentante dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI). La classe politica italiana invece è rimasta in silenzio. Un silenzio assordante. Forse però è meglio tacere che sostenere, come ha fatto Berlusconi, che i fascisti italiani non avrebbero mandato gli oppositori del regime nei campi di concentramento, ma semplicemente in “ferie obbligatorie”.
Un altro aspetto tragico riguarda il fatto che il memoriale di Kampor fu costruito negli anni Cinquanta dai prigionieri del lager sulla vicina isola di Goli Otok. Il regime jugoslavo di Tito inviò molti prigionieri a Goli Otok, principalmente oppositori politici sospettati di stalinismo, ma non solo: tra gli internati a Goli Otok c’erano anche alcuni Testimoni di Geova, perseguitati per aver esercitato il diritto all’obiezione di coscienza.
Questo articolo è stato ripubblicato nell’ambito di uno scambio di contenuti promosso da MOST – Media Organisations for Stronger Transnational Journalism, un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea, che sostiene media indipendenti specializzati nella copertura di tematiche internazionali. Qui la sezione dedicata al progetto su OBCT
Tag: Crimini di guerra