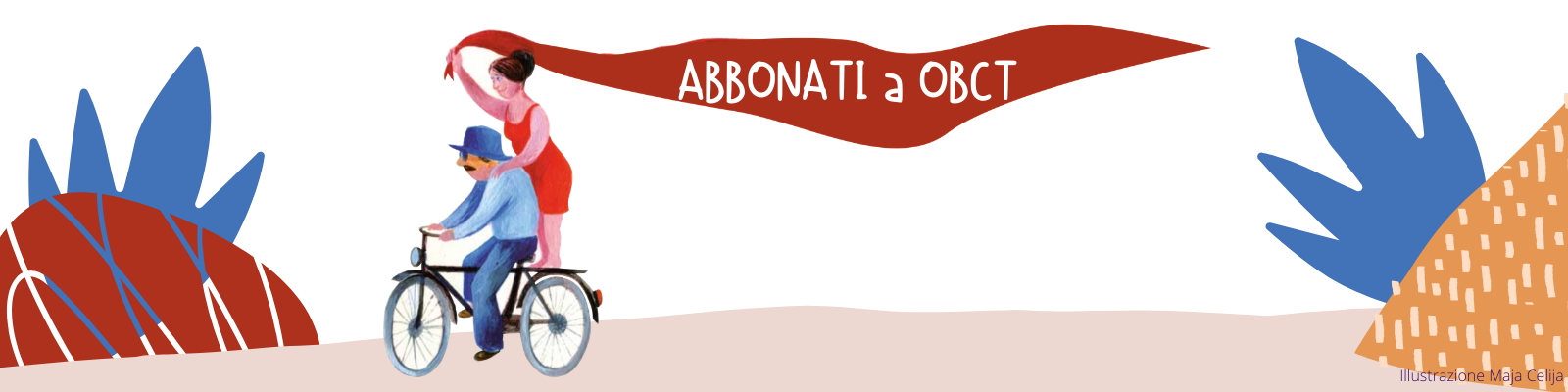|
Raccontare il confine
Studenti delle scuole di Monfalcone, Gorizia e Nova Gorica raccontano il confine. Un progetto promosso nel 2004, all’indomani dell’ingresso della Slovenia nell’Ue. Un’analisi dei testi a cura di Melita Richter
di Melita Richter
Nel Vocabolario della lingua italiana 1, il confine significa "limite, termine, pietra, sbarra, steccato che delimita una proprietà. Linea costruita naturalmente o artificialmente a delimitare di un territorio, di una proprietà o la sovranità di uno stato." Nelle lingue slave l’espressione per confine è granica 2, la parola il cui significato, oltre a quelli già elencati, significa orlo, la fine (kraj; di cui la krajina, il territorio confinario), il limite fino al quale si estende la proprietà e il dominio di una persona, di un gruppo di persone, di uno stato. Un limite nello spazio.
Il confine presume la diversità che sta al di là dell’area che esso delimita. Si tratta di una diversità reale o artificiale, cui vicinanza a fior di pelle con l’identità che il confine racchiude, spesso provoca attriti, incomprensioni e, a volte, una vera ostilità reciproca. Il confine si pone come violenza in ogni tessuto che esso attraversa. E’ come se il continuum di forme geografiche, culturali, linguistiche non esistesse ed in ogni punto la realtà potesse essere spezzata e separata in almeno due gruppi opposti. Ciascuno dei corpi separati conserva in sé ciò che gli è proprio e lo fa in opposizione all’altro. Trovandoci da un lato del confine, riconosciamo tutto ciò che esso delimita come "nostro", "proprio", "identitario", mentre quello che è proprio per l’Altro, per noi diventa estraneo, alieno. In base al compiacimento e alla volontà politica di chi detiene il potere è facile tramutare ciò che è straniero, estraneo, alieno in nemico. Il passo successivo è: attribuire al nemico qualità "disumane", o meglio, privarlo di ogni qualità. Il confine concepito in questo modo porta alla facile attribuzione a ciò che sta "oltre" di essere una minaccia alla nostra stessa identità. Vorrei distanziarmi da una simile interpretazione del confine e avvicinarmi a un concetto diverso, alla soglia.
"La soglia", come dice Johann Drumbl 3 "è il confine visto nella prospettiva dinamica del suo superamento, è il luogo della creatività". Lo stesso autore cita un’intervista che Peter Handke, lo scrittore austriaco, aveva dato al germanista svizzero Herbert Gamper, nella quale egli elabora il concetto di soglia. Il discorso si riferisce a un’opera letteraria, ma è tale il concetto che più si avvicina a quanto cerca di esprimere il nostro titolo:
"Questo vuoto, questo vuoto ondoso, celestiale, fruttuoso e accattivante non mi è mai apparso nella natura deserta bensì sempre vicino agli uomini. Ed era sempre ai margini che è successo, per esempio, ai margini di una città, oppure ai confini tra foresta e steppa, è proprio strano: sempre presso i confini o, meglio, sulle soglie. Sempre là." 4
La soglia quindi, come luogo di passaggi, come uno spazio intermedio dove la densità identitaria si fa più leggera e dove il tempo rallenta e permette di soffermarci e di riflettere sul nostro stesso essere, su quanto custodiamo e quanto ci dona la prossimità dell’altro. "La soglia", dirà ancora l’autore "come luogo della sospensione, lo spazio nel quale attendere" 5.
Sono le soglie, non i confini a permetterci di vivere le terre di mezzo, sono esse il luogo e lo spazio dove si facilitano l’incontro, il contatto, la contaminazione. Sono luoghi di ricerca non di sconvolgimento; sono esse il primo presagio dell’annullamento dei confini.
In queste terre la parola confine ha sempre serbato in sé conflitti e tragedie, vincitori e vinti, sopraffazioni e umiliazioni, resistenze e ribellioni, e capovolgimenti… Ma, sono state queste le terre che hanno dimostrato una tenace volontà di superare la maledizione di "eterne contrapposizioni"; è stato su questo confine che è avvenuto il primo scostarsi della cortina di ferro tra i due mondi contrapposti. Il gelo ideologico si stemperava nelle acque dell’Adriatico; qui, alle porte di Trieste, i due mondi non furono mai del tutto separati. Già nel lontano estate del 1950, con l’apertura del valico confinario della Casa rossa di Gorizia, si volle promuovere il primo significativo incontro tra le popolazioni confinarie. L’incontro, come scrive lo storico sloveno Bozo Repe, "fu promosso allo scopo di rinnovare i legami di amicizia e parentela compromessi dal confine. (…) Il confine fu letteralmente abbattuto da un’inarrestabile moltitudine proveniente dalla parte jugoslava che, sbandatasi per i negozi di Gorizia continuò indefessamente a comprare…" 6
Da allora, il passaggio del confine divenne un fenomeno di massa. Negli anni ’60 la Jugoslavia si aprì al mondo, il tenore di vita si fece notevolmente più elevato di qualsiasi altro paese socialista, la maggior parte dei cittadini possedeva il passaporto e si muoveva all’estero senza ostacoli di tipo burocratico o politico. In occasione della festa della Repubblica, il 29 novembre, Trieste, "la prima finestra dell’occidente" soleva diventare meta di 250.000 acquirenti jugoslavi 7. Quanti ricordi legati all’epoca, quanti aneddoti sulla mitica piazza Ponte rosso, e poi, tutta quell’arte di occultare la merce ai passaggi della frontiera e l’indicibile sollievo dopo aver superato l’ultimo esame doganale… Ricordi sbiaditi, lontani, ricordi che hanno fatto storia nei rapporti tra i due paesi.
Come ricorda nel suo studio il già nominato storico Repe, questi spostamenti di massa di cittadini jugoslavi e, contemporaneamente, degli italiani che oltrepassavano il confine per "fare la spesa" e per le vacanze frequentavano la costa dalmata, le isole e la terra istriana, ebbe una conseguenza diretta nel Trattato di Osimo firmato dall’Italia e la Jugoslavia nel 1975. In molta parte il Trattato avvalorò la realtà già esistente: decretò la nascita del confine più aperto mai esistito fino ad allora tra un paese capitalista e uno socialista. Solo nel 1976 nella provincia di Trieste a transitare il confine furono più di 40 milioni di persone di cui 21 milioni con il passaporto e il 19 milioni con il lasciapassare.8
Innumerevoli contatti tuttora non potevano rappresentare ciò che noi consideriamo "condizione di soglia": spesso non si trattava d’altro che vivere gli uni accanto agli altri con una garbata non-compenetrazione, in un convalidato non-contatto. Si potrebbe dire: vivere la diversità non comunicante, lontano da ogni contaminazione e da una fusione culturale creativa, palpabile.9
Con l’entrata della Slovenia nell’EU, avvenuta nel 1 maggio di quest’anno – il destino di questo confine è di perdere gradualmente il proprio ruolo di separazione tra le due realtà statali. L’Italia e la Slovenia sono diventati paesi membri della stessa entità europea sovranazionale, membri di pari diritto e di condivise responsabilità. Il primo trapasso storico tra i due mondi è già avvenuto, quello successivo, il varco tra i due modi di essere, ha ancora da avverarsi. I muri divisori dell’Europa dei due blocchi hanno cessato di esistere. Non ci sono più ragioni ideologiche di coltivare antagonismi e timori reciproci: tutto questo sono elementi di enorme rilevanza politica e culturale.
Nell’area del "confine orientale" (visto dall’Italia) e "confine occidentale" (visto dalla Slovenia), sono molti i fattori che annunciano un nuovo clima di relazioni. Ciononostante, mentre molti confini della vecchia Europa si affievoliscono e cessano di esercitare il loro micidiale potere di separazione, vi sono altri che emergono, che vengono imposti con vigore delle armi o con le nuove ideologie d’esclusione; sono queste le nuove ferite sul corpo provato dell’Europa, affranta nell’osservare interminabili smembramenti dei suoi luminosi paesaggi multiformi. Le nuove divisioni sono d’obbligo anche in Istria. I nuovi steccati conficcati nella terra della penisola soffocano il suo essere sociale, storico, culturale.
Nelle nostre immediate vicinanze, il cordone sanitario che segna il lembo dell’UE , una nuova estrapolata terra di nessuno cinge la ferita profonda inflitta da nuove frontiere ai cui bordi crescono sbarre e barriere, caselli e cancelli di dimensioni impressionanti sotto cui tettoie si danno cambio zelanti funzionari di vari corpi di polizie in uniformi nuove di zecca… Ogni confronto/scontro con questa realtà, con i nuovi rallentatori dei liberi spostamenti umani, ci infligge un dolore lacerante che invade il corpo, nonostante la mente rimanga lucida e ribelle. Di questi nuovi confini’autrice istriana Nelida Milani scrive:
"La ferita si è riaperta nel corpo stesso della terra. E’ un taglio nella collina alle spalle di Castelvenere, o meglio, due tagli fra Slovenia e Croazia, sul fiume Dragogna e a Siciole. Un lungo e inutile confine impastato di nuovi afrori coloniali, che corre tra i cespugli di timo e gli spini di grattaculo, oltre il quale si vede altra campagna, la stessa: la stessa trama di pini, il cielo che non vuol fingere altro cielo. Ogni volta che devo attraversarlo, fra i camion e la squadera di una gru rossa sulla strada sterrata, mi sento imbrattata di rabbia e di impotenza. Una irritazione sorda, una ripugnanza rancorosa, cattiva".10
Ciò che resta da fare è: non soggiacere alle nuove spartizioni, non cedere al senso d’impotenza e ancora meno a un comportamento di auto-censura che induce all’auto-limitatazione del proprio spostarsi nello spazio, sia fisico che mentale. Non stancarci di sfidare i confini di vecchia e di nova data. Osare la strada verso l’Altro, per lui e per sé stessi. Perché i confini sono imposti dagli uomini e da essi potranno essere cancellati. I veri attori di annullamento dei confini sono le donne e gli uomini che attraversano i diversi contesti geografici e culturali. In queste terre di confine abitate da popoli di confine, popoli meticci, bastardi, contaminati vicendevolmente, è l’unica via da seguire.
L’incontro che è stato promosso dal Progetto "Raccontare il confine" è la testimonianza della voglia di incamminarsi su questa via di generazioni giovani portatrici di identità diverse, ma desiderose di tracciare i connotati di un’Europa, dove sentirsi "a casa propria", dove condividere i valori e responsabilità. Il Progetto è anche una dimostrazione di quanto la scuola possa diventare il volano di promozione di questo cammino, l’ambito di stimolo e di incoraggiamento della ricerca di spazi di scambio e di conoscenza reciproca.
Prima di dedicare il resto della mia riflessione ai testi che gli alunni hanno scritto sul tema proposto, vorrei ricordare la sentita voglia di approfondire le conoscenze reciproche, che si è avverata tra gli alunni provenienti da istituti scolastici diversi e situati in due stati distinti, i quali, dopo le relazioni introduttive, tardavano di rientrare nell’aula e, godendosi la soleggiata giornata primaverile si avventuravano in quello che dovrà diventare la palestra di esercizi europei: dialogare e confrontarsi.
La maggior parte degli alunni ricorda che il confine che separa Gorizia da Nova Gorica 11 è il retaggio della Seconda Guerra Mondiale, una realtà non tanto lontana, ma imposta più da ideologie contrapposte ed interessi politici che dalle genti che abitano queste terre. E, se i drammi della separazione hanno investito le generazioni precedenti, hanno radicato sul territorio "rancori e ferite non ancora rinchiuse" (Andrea Femia), invadendo il mondo dei nonni e dei genitori, la maggior parte dei ragazzi, non sente e non ha mai sentito il confine come un "problema". Lo testimoniano in tanti: "Io non ho mai vissuto la realtà del confine" (Andrea Femia), "il confine per me non esisteva" (Stefania Martelli), "gli abitanti di questa e quella parte del confine si conoscevano e si incontravano già prima" (Ivana Černic), per cui si sente una forte distinzione generazionale nella concezione del confine. "Noi giovani vediamo il confine in una luce diversa" dice Aljosa Jarc e per Borna Vudrag: "Negli anni in cui siamo cresciuti questo confine era già molto debole, non c’era traccia di una qualche cortina di ferro, nessun muro di Berlino, o traumi come quelli che sono stati vissuti in altre zone d’Europa".
"Fortunatamente, questo è un problema che riguarda le generazioni che più da vicino hanno vissuto gli eventi, mentre quelle future sono chiamate a creare una convivenza pacifica eliminando quelle barriere nocive e stupide che sono i pregiudizi. (…) Siamo noi che veniamo chiamati per cominciare un dialogo" afferma Ricardo Feudale, mentre Francesca Sirk continua: "Noi giovani siamo protagonisti di questa nuova Europa unita che si va creando". Lo pensa anche Francesco Babich: "Probabilmente molti ragazzi lo hanno già abbattuto nella loro mente cercando di conoscere ciò che di bello può esserci fuori di casa". Allo stesso tempo, c’è una diffusa consapevolezza che l’abbattimento simbolico delle frontiere è soltanto un primo passo dell’avvicinamento all’Altro. Riflette Stefania Martelli: "Nulla è scontato: l’ultimo muro d’Europa che cade e che ci procura oggi tanta emozione, non è un punto d’arrivo, ma una tappa fondamentale di un percorso che dovrà continuare ", e riprende Francesca Sirk: "… non bisogna dimenticare che il valico di confine è solo un simbolo: c’è ancora molta strada da fare per superare realmente nella nostra mente le lacerazioni che hanno reso ostili due popoli". E Wally Radina introduce l’ottica del tempo: "Ci vorrà tanto, qualcuno dice troppo tempo. E’ un fenomeno di lunga durata e qualcuno pensa che proprio perché la durata sia troppo lunga, non sia realizzabile…"
Sulla strada della realizzazione, "una strada in salita", come verrà ricordato, rimangono molti ostacoli, primi dei quali pregiudizi, stereotipi, ostilità, diffidenze, dubbi, "dubbi ingiustificati perché le culture, oltre che a esprimere caratteri diversi, esprimono altresì tratti comuni." (Ricardo Feudale).
I pregiudizi sono seminati da ambo le parti del confine, constateranno gli autori dei testi. "Ho imparato anche che significato ha avuto ed ha quel confine per parte della mia gente: odio nei confronti del "diverso", diffidenza, alle volte paura, voglia di essere e continuare ad essere italiani, senza intrusioni, senza estranei in casa propria" scrive Wally Radina mentre aggiunge Andrea Femia: "Da ciò che ho potuto capire qua a Gorizia, c’è una sorta di disprezzo non troppo diffuso, eppure percettibile, verso i vicini d’oltreconfine. Un disprezzo, molta indifferenza la cui origine dev’essere cercata a più di mezzo secolo fa. Vecchi rancori, ferite non ancora richiuse che tuttavia, anche perché non ho mai ‘vissuto’ il confine, io non sento per nulla". Secondo Enrico Magrin "la travagliata storia di queste terre ci ha fatto guardare chi abita di là del confine con aria di superiorità, dall’alto al basso, da chi guarda gli sconfitti anche se poi siamo sconfitti dalla storia un po’ tutti." E Stefania Martelli avvisa: "Mi accorgo (..) che una sorta di estraneità e di lontananza da ciò che si vive oltre il ‘confine’, ha determinato nella mia generazione una certa indifferenza".
Al seno dell’ignoranza, della non-conoscenza, della poca curiosità per quello che rappresenta la cultura e la storia dell’altro, la maggior parte degli alunni situa le paure che serbiamo dell’incontro col diverso. La stessa Martelli continua: "Alla parola "diverso" spesso diamo un’accezione negativa che viene dal pregiudizio. Alla base di tutto ciò c’è l’ignorare, il non-conoscere e da qui deriva la paura che ‘il diverso’ sia un nemico, che voglia invadere il nostro spazio e contaminare il nostro mondo con il suo".
Le paure sono tante. I giovani le avvertono. Esse crescono da ambo le parti – le paure nuove dei paesi che entrano nell’UE, come ricorderà Andrea Ambrosino: "una parte delle popolazioni dei nuovi paesi guarda con diffidenza a quest’evento, poiché non è per niente rassicurata della propria situazione: si interrogano sulle condizioni sociali ed economiche che riguarderanno la loro vita nei prossimi anni", come le paure che nutrono coloro che il posto nella casa europea se la sono guadagnati già, per esempio i cittadini italiani da questa parte del confine: "Molti, razionalmente, pensano e hanno paura che queste persone diverse tolgano loro spazi, risorse, lavoro" (Andrea Femia). E, c’è sempre intatta la paura insita nell’essenza stessa del confine che ci separa dall’ignoto: "Ancora oggi persiste quella chiusura mentale generata dal confine, che causa dapprima disinformazione riguardo al paese limitrofo, e quindi diffidenza, paura per l’ignoto e per il diverso, e successivamente odio e chiusura di rapporti" (Mattia Altran).
Vi è un’altra paura che insidia tutti i piccoli paesi che sono entrati nell’UE: è quella di perdere la propria identità nazionale, culturale, linguistica, in un mare di identità europee storicamente affermate e dominanti; è la paura di diventare una nuova periferia all’interno del contesto europeo che consolida le sue vecchie centralità. Questo aspetto attanaglia anche la società slovena. Julie Fackeure lo esprime così: "La Slovenia ha impiegato molto tempo ad ottenere l’indipendenza e la stabilità interna, e teme che l’ingresso della Slovenia in Europa potesse significare una sottomissione da parte di paesi europei più forti." Sullo stesso tema si interroga Ivana Černic: "…quando arriveremo a quel punto (all’entrata della Slovenia in UE, nota m.r.), mi domando se rimarrà ancora qualcosa delle peculiarità e delle abitudini slovene. Saranno in grado gli Sloveni di mantenere vive le tradizioni? Spero che la piccola e giovane nazione slovena saprà valorizzare se stessa e il suo patrimonio culturale nella comunità degli stati europei". C’è chi risponde subito al quesito: "Non si parla, non abbiamo mai parlato di unire queste due identità culturali, si rischierebbero di perdere le proprie tradizioni, ma di conoscere, di scambiare le proprie consuetudini e aprire reciprocamente le nostre culture." (Andrea Femia). Come del resto lo aveva affermato a Gorizia il presidente (di allora) della Commissione Europea, Romano Prodi: "Siamo tutti piccoli e tutti i paesi che entrano nell’Unione Europea devono portare la loro storia, la loro cultura, le loro tradizioni". Alessia Sdrigotti aggiungerebbe: "Ognuno di noi deve (…) riuscire anche a mantenere e a salvaguardare la propria cultura insegnandola all’altro, senza imporla. Credo difatti che tutto ciò debba avvenire senza forzature e disparità".
C’è invece chi pone la questione su un altro livello, non meramente culturale, e si inserisce in un discorso ampiamente politico, denunciando le visibili assimetrie tra i paesi confinanti come lo fa Teja Pahor: "Posso dire che la Slovenia, in quanto stato piccolo, sarà in un certo senso più sottomessa e si troverà peggio rispetto all’Italia, che è notevolmente più grande e più conosciuta." Il giudizio di Jacob Dimič è ancora più severo e si rivolge ai vertici politici del paese: "Vorrei esprimere il mio stupore nei confronti del governo sloveno, dato che la Slovenia è l’unico stato tra i nuovi membri della Nato che ha concesso il controllo del proprio spazio aereo ad uno stato dal quale era stato attaccato, nella seconda guerra mondiale. Beh, è certo un segno di amicizia. Ma voi siete pronti ad essere uomini come noi, siete pronti a rinunciare a qualche piccola cosa?"
La richiesta di rinunce e di delega dei poteri sono importantissime questioni del dibattito europeo.
Negli scritti degli alunni affiora anche un’altra paura e questa è legata al carattere stesso dell’allargamento, traducibile in parole espresse da Andrea Ambrosino: "Quest’avvenimento, così decantato e atteso dai capi di Stato europei, rischia di divenire solo un affare per industriali e commercianti, e non un evento che permetta alle varie etnie di incontrarsi e conoscersi".
All’identità e all’importanza dell’esistenza dei confini per delineare lo spazio dove l’identità si forgia e persiste sono dedicate alcune riflessioni. Riprendiamo il pensiero della Fackeur: "La parola confine possiede diverse connotazioni, sia spirituali e astratte, sia fisiche e concrete. Il confine ci circonda nella nostra quotidianità, delimita il nostro modo di pensare e di agire. Conoscere i confini significa conoscere chi siamo, possedere un’identità, caratterizzata da modi di comportarsi nella vita di ogni giorno a volte diversi, a volte simili, a volte incomprensibili, rispetto a chi sta aldilà della frontiera. Pertanto, l’identità è impossibile da concepire senza il confine e senza ‘l’altro’, ma a volte nel passato lontano e recente, la ricerca dell’identità ha portato le persone su una strada diversa da quella della ricerca interiore dell’identità. Il richiamo all’identità ha alimentato le guerre, i nazionalismi, l’emarginazione di etnie considerate inferiori; ne è la testimonianza il 20° secolo appena passato."
Nel mantenimento dell’identità culturale e nazionale la lingua gioca il suo ruolo regale, ma la lingua viene vista anche come mezzo necessario di comunicazione e di scambio. Nella maggior parte degli scritti si sottolinea l’importanza del fattore linguistico, riferendosi ad ambedue degli aspetti: lingua come simbolo identitario e come mezzo di comunicazione. Nel futuro assetto della regione "ci sarà bisogno di un modo per comunicare, e questo problema si può risolvere con l’insegnamento nelle scuole italiane dello sloveno e in quelle slovene dell’italiano", propone Ambrosino, mentre Sdrigotti trova che "la lingua sia l’unico strumento necessario per padroneggiare e capire veramente una cultura lontana dalla nostra. Dobbiamo quindi accostarci alle lingue di tutto il mondo, in particolare a quelle minoritarie, oggi sostenute dall’UE, con grande curiosità e interesse, affinché queste non vengano dimenticate ed emarginate sempre più". C’è chi avverte le assimetrie nella conoscenza linguistica tra giovani italiani e sloveni, e lo esprime così: "Gli studenti sloveni si destreggiano abilmente con entrambe le lingue e credo sarebbe bello anche per noi avere nelle nostre scuole la possibilità di scegliere lo sloveno come seconda lingua straniera, vista la grande importanza e utilità che riveste proprio nella nostra zona" (Stefania Martelli).
Uno scambio vero e l’avvicinamento proficuo tra culture diverse non può omettere la conoscenza delle lingue, lo pensa anche Francesca Sirk che si unisce alla proposta: "Sviluppare la lingua slovena nella nostra regione e l’italiana in Slovenia permetterebbe un avvicinamento concreto e anche mentale tra le due culture. In Slovenia, per motivi per lo più economici, l’italiano è già ben conosciuto. Ma è qui in Italia che si tende a sottovalutare l’importanza dello sloveno. Lo sloveno è una lingua minoritaria ma come tale, non va dimenticata". Della stessa opinione è anche Enrico Magrin: "Forse questo è il grosso limite di noi italiani che viviamo a pochi passi da un altro paese, il non sapere nulla della stessa lingua slovena che pure sarebbe utilissimo conoscere, spesso i pregiudizi verso chi non è italiano che anche se si fermano alla battuta scherzosa ci impediscono di comprendere e, prima di tutto, di conoscere gli sloveni e tutti gli stranieri in genere."
Questo pensiero non è distante da quanto espresso dal sindaco di Nova Gorica, Mirko Brulc che nella conversazione con il suo collega, il sindaco di Gorizia Vittorio Brancati, aveva detto: "Mi capita spesso di incontrare degli italiani che pur vivendo vicino al confine non sono a conoscenza del livello di cultura e di democrazia sviluppato nel nostro paese e ne sono dispiaciuto."12
Nelle zone di confine, la cultura è spesso stata usata come roccaforte dell’identità nazionale. Quello di cui oggi c’è bisogno sono le nuove strategie di avvicinamento di due o più culture per abilitarci ad oltrepassare la diffidenza con cui i "piccoli" (stati, nazioni, gruppi minoritari non soltanto etnici) affrontano e temono una possibile nuova dominazione culturale emanata dai centri di potere, siano essi vicini o lontani, siano situati all’interno, oppure oltre le frontiere nazionali.
Per un futuro dei rapporti paritari tra i due paesi che convergono nell’area, rapporti che sicuramente avranno risonanze in un raggio più vasto di quello regionale, si dovrà riflettere anche sulla questione linguistica e sull’importanza della conoscenza dell’altro, della sua lingua e della sua cultura e come queste vengono trasmesse nell’ambito scolastico.
C’è una consapevolezza particolare di alcuni alunni che ritengono che vivere vicino al confine permette di capirlo meglio, di confrontarsi con le tematiche che per coloro che sono distanti, sono del tutto sconosciute. Si riconosce quindi, la particolarità delle aree di confine e una coscienza nazionale diversificata sui problemi confinari. Lo osserva Ivana Černic: "Ho notato che ci sono molte differenze tra le persone che abitano vicino al confine, come noi, e quelli invece che sono più lontani. Penso che, a causa della distanza, questi ultimi abbiano meno contatti con il paese confinario, e la maggior parte di essi non avverte minimamente il confine, sa della sua esistenza soltanto per cultura generale". Lo affermerà anche Borna Vudrag: "La percezione del confine dipende anche dal luogo in cui si vive. Noi che viviamo accanto ad esso lo percepiamo senz’altro diversamente rispetto a coloro le cui altisonanti parole abbiamo avuto modo di ascoltare negli ultimi tempi, e che provengono da altre parti, lontane dal confine".
Quasi tutti ritengono che il confine fisico, istituzionale, imposto, sia una cosa, mentre quello interiorizzato e impresso nella nostra mente sia un’altra, spesso molto più radicato e resistente del primo. "Secondo me," sostiene Altran, "esistano due confini: uno materiale, come ad esempio una dogana, un muro, un reticolo di filo spinato, ed uno mentale, che si viene a creare nelle psiche delle persone che vivono in prossimità o comunque nelle vicinanze di un confine tra due paesi."
"Il problema non consiste nel fatto che esistano degli ostacoli fisici, ma più che altro nel confine che sta in testa; è quello che alcuni non sono disposti a superare", riporta con il tono critico Borna Vudrag, mentre prosegue Julie Fackeure: "Il confine rimane ancora nello spirito della gente: da ambo le parti ci sono pregiudizi e una certa diffidenza nei confronti dello straniero". Alessia Sdrigotti suggerisce che "demolire un confine non significa solamente abbattere le barriere, i muri o le reti che dividono fisicamente due diversi Stati, ma significa soprattutto riuscire ad annientare i confini che risiedono nei cuori di molte persone." Diana Temporin lo esprime con parole particolarmente incisive: "Per quanti confini esistano sulla terra, fra uno stato e l’altro, non c è barriera più invalicabile e indistruttibile del confine interiore, il limite interiore".
La convinzione che l’abbattimento dei confini richiederà tempi lunghi e che è cosparso di difficoltà, ma anche di resistenze volute e di ostruzionismi, li segnalano prevalentemente gli alunni sloveni, sia quelli che vivono a Nova Gorica, che i membri della minoranza slovena che frequentano le scuole a Gorizia. Ecco cosa ne pensa a proposito Teja Pahor: "Purtroppo, ci sono anche persone che per principio non vogliono andare oltre confine. Quelli che nel passato non hanno mai pensato di andare in Slovenia, di sicuro non passeranno ora da una Gorizia all’altra come se niente fosse. Per loro il confine rimarrà sempre e sarà inviolabile ed eterno. Oltre agli ostinati ci sono però anche quelli che non oltrepasseranno mai il confine, perché semplicemente non sanno che esiste la Slovenia e i suoi abitanti. Questo non per testardaggine o per principio, ma per pura ignoranza, il che è ugualmente terribile, se non ancora peggio. Questo fenomeno è diffuso in Italia, ma c’è qualcosa di simile anche in Slovenia." Lo conferma Tanja Zorzut: "L’unificazione di differenti nazioni e popoli è soltanto un invito a percepire una certa uguaglianza, profondamente nascosta nei nostri cuori, che non vuole in nessun modo venire a galla". Secondo Jacob Dimic, tuttora "non ci sono le condizioni. Ma guardatevi, nella Gorizia italiana c’è una minoranza slovena, eppure dove sono le scritte bilingui? Non ci sono neanche nei supermercati, dove fa la spesa un consistente numero di nostri cittadini. Tutto sembra far pensare che ci vogliate solo per guadagnarci su. Se continuerà un tale tipo di rapporto, non aspettatevi un’accoglienza cordiale, quando verrete a trovarci: il popolo in fondo non è così cieco come potrebbe sembrare al primo sguardo."
Una denuncia dura, precisa che richiede delle risposte altrettanto precise.
Sulla reale, sentita unificazione europea in queste terre pesa la memoria storica, e il peso risulta significativo anche tra i giovani, nonostante sono in molti che vogliono scrollarsi di dosso le memorie non loro, memorie ereditate, ingombranti. Riportiamo solo alcuni pensieri espressi dagli alunni:
"Ho ascoltato il colloquio che abbiamo avuto con gli studenti di scuole italiane, slovene e bilingui e ho constatato che la visione più negativa era proprio quella degli sloveni, dato che i giovani in Italia non si rendono precisamente conto delle possibili difficoltà, e al tempo stesso non hanno alle spalle un così importante e sofferto periodo storico. Essi, infatti, non sanno esattamente cosa ci è successo, dato che la storia che hanno imparato è mutilata e incompleta, il che non è certo colpa loro, ma proprio su di loro si vedono le conseguenze di queste mezze verità". (Teja Pahor).
"Gli Sloveni e gli Italiani hanno un tale storia in comune che la nostra unificazione in
Tag: AestOvest