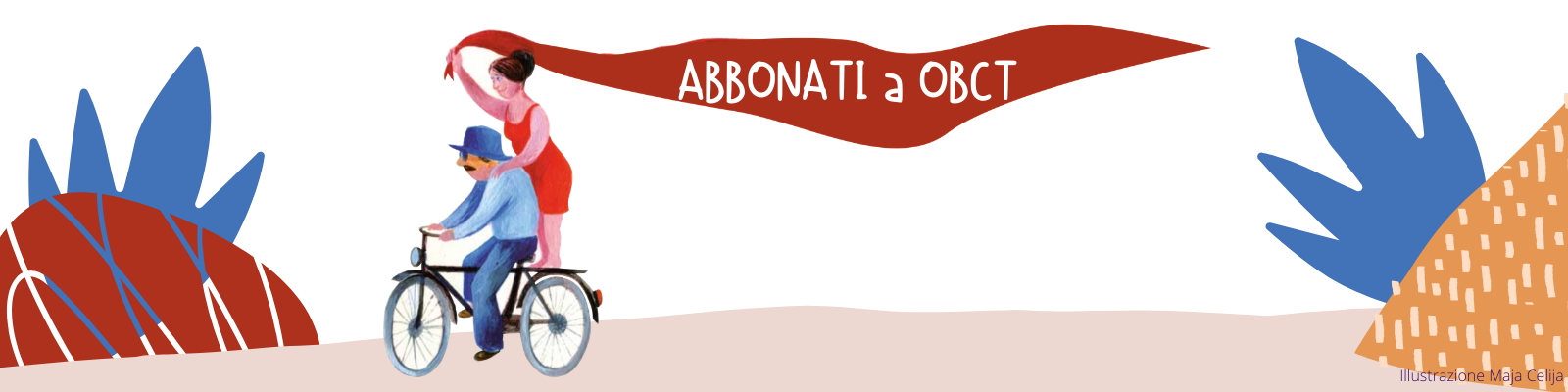Da Sarajevo a Kyiv: fact-checking e influenza russa
In Bosnia Erzegovina, dove la politica spesso assomiglia ad una campagna elettorale infinita, si è creata una piccola comunità di fact-checker, ormai abituata a lavorare sotto pressione. Un’analogia con la situazione in Ucraina

Kakanj,,Bosnia,And,Herzegovina,,10.3.2025.:,Person,Holding,Smartphone,With,Shutterstock
© RKY Photo/Shutterstock
“Quando abbiamo iniziato quindici anni fa, il nostro lavoro non ha attirato molta attenzione”, spiega Amina Izmirlić Ćatović, ricercatrice e fact-checker di Istinomjer [misuratore della verità], la prima piattaforma di fact-checking politico in Bosnia Erzegovina.
“Oggi, invece, quando pubblichiamo un’analisi, i politici rispondono immediatamente”, afferma Amina. “Un editore ci ha persino minacciati. Abbiamo chiamato la polizia, ma nessuno è intervenuto”.
L’organizzazione Zašto ne [perché no], responsabile della piattaforma Istinomjer, è una delle più importanti realtà dell’area ex jugoslava impegnate ad individuare e smascherare la disinformazione. Il suo team analizza tutte le possibili fonti di informazioni false, dalle dichiarazioni politiche alle distorsioni storiografiche, passando per la propaganda straniera. Un’attività che assomiglia sempre più a quella svolta dalle organizzazioni watchdog ucraine dall’inizio dell’invasione russa nel 2022.
La Bosnia Erzegovina e l’Ucraina si trovano ad affrontare lo stesso problema: come preservare il principio di responsabilità democratica in un ambiente saturo di informazioni manipolate e di sfiducia pubblica.
Echi di guerra
Al pari di quella ucraina, anche la società bosniaco-erzegovese è lacerata da conflitti, con istituzioni fragili, e deve ancora fare i conti con l’eredità della guerra. Gli Accordi di pace di Dayton del 1995 hanno posto fine alla guerra, creando però un paese diviso lungo linee etniche, con narrazioni contrastanti sulla storia e l’identità. Questa struttura frammentata ha reso la società vulnerabile alla disinformazione, interna ed esterna.
“La guerra è finita molti anni fa, eppure non c’è ancora alcuna responsabilità politica”, spiega Amina Izmirlić Ćatović. “Ogni anno attraversiamo nuove crisi. Continuiamo a parlare di guerre e conflitti. In realtà, però, i cittadini della Bosnia Erzegovina vivono e lavorano, collaborano e la vita continua. I politici creano tensioni durante i periodi elettorali pur di peggiorare i rapporti tra le comunità etniche. L’uso della disinformazione è un problema destinato a perdurare”.
In Ucraina si è assistito a dinamiche analoghe su scala più ampia e l’opinione pubblica è diventata bersaglio di campagne di disinformazione russe ben prima dell’invasione del 2022.
Per gli analisti di Sarajevo, l’esperienza della Bosnia Erzegovina riguardo alla frammentazione dei media e la manipolazione basata sull’identità rappresenta allo stesso tempo un caso di studio e un monito. Il panorama dei media bosniaco-erzegovesi rispecchia le divisioni politiche nel pease. Ci sono alcune testate indipendenti, però a dominare la scena sono ancora i media legati a determinati partiti politici e gruppi etnici.
“Le emittenti televisive private solitamente si allineano alle posizioni delle rispettive comunità etniche”, afferma Minel Abaz, giornalista e analista bosniaco. “Ad esempio, Hayat TV, i cui proprietari sono bosgnacchi, ha assunto una posizione esplicitamente filo-palestinese nei suoi reportage su Gaza. Non hanno mai dato spazio ai discorsi d’odio, ma il loro modo di parlare dell’argomento ha rispecchiato il messaggio più adatto al loro pubblico. Le emittenti televisive private di solito funzionano così”.
Le emittenti pubbliche affrontano altre sfide.
“A livello statale, a volte vediamo trasmissioni con ospiti serbi negazionisti del genocidio e omofobi”, spiega Abaz. “Questi interventi vengono presentati come un modo per mantenere l’equilibrio, come se entrambe le parti meritassero pari visibilità. Così però si continua a legittimare il negazionismo”.
Il risultato è un ecosistema dell’informazione frammentato, dove la fiducia è bassa e il pubblico spesso sceglie di informarsi attraverso i media che riproducono i pregiudizi esistenti. I social non fanno che esacerbare il problema.
“I notiziari televisivi sono ancora la principale fonte di informazione”, afferma Amina Izmirlić Ćatović. “Anche Facebook è popolare, soprattutto tra gli anziani, mentre i giovani preferiscono Instagram e TikTok. Utilizziamo molto Facebook proprio per raggiungere quelli che ancora attingono principalmente a questa piattaforma per informarsi sugli eventi politici”.
Un altro aspetto che accomuna il panorama dei media in Bosnia Erzegovina a quello ucraino è la diffusione della disinformazione russa.
“C’è stata molta disinformazione sulla guerra scatenata dalla Russia: c’era chi dava la colpa all’Ucraina, diffondendo narrazioni sui regimi neonazisti e laboratori biomilitari”, spiega Izmirlić Ćatović. “Una parte della popolazione sostiene le rivendicazioni russe. In Republika Srpska si possono sentire discorsi molto simili a quelli diffusi dai media russi. Queste narrazioni trovano sempre un pubblico proprio perché rispecchiano le animosità politiche locali”.
I parallelismi non sono casuali. I media serbo-bosniaci spesso riprendono le notizie diffuse dalle agenzie di stampa di stato russe, come Sputnik e RT.
“Non si tratta solo della Russia”, sottolinea Minel Abaz. “Assistiamo ad una politica identitaria. I messaggi vengono concepiti in modo da acuire le divisioni esistenti”.
Il fact-checking
I ricercatori di Istinomjer svolgono un lavoro di verifica metodico.
“Quando individuiamo false dichiarazioni, pubblicate dai media o pronunciate dai politici, ne rintracciamo la fonte e la confrontiamo con dati affidabili”, spiega Amina Izmirlić Ćatović. “Citiamo tutte le nostre fonti. Cerchiamo di essere trasparenti affinché i lettori possano capire chiaramente come siamo giunti alle nostre conclusioni”.
La squadra di Istinomjer segue diversi argomenti, dalla politica interna – compresi i dibattiti sulla legge elettorale e la riforma costituzionale – alla disinformazione sociale e culturale.
“Ci occupiamo di temi legati al processo di adesione all’UE e alla NATO, ma anche di questioni sociali ed economiche e di manipolazioni di fatti storici”, afferma Izmirlić Ćatović. “Monitoriamo anche la disinformazione sulle donne e sui gruppi LGBT e l’influenza che Mosca e Belgrado esercitano sui media”.
Con il passare del tempo, anche il pubblico è cambiato.
“Quando abbiamo iniziato, regnava il silenzio”, spiega la ricercatrice. “Negli ultimi cinque anni abbiamo invece ricevuto molti feedback, sia positivi che negativi. Perlomeno i cittadini si sono attivati. È un passo avanti”.
A distanza di tre decenni dalla fine della guerra in Bosnia Erzegovina, la vita quotidiana, come anche il dibattito politico, è ancora impregnata di ricordi di quel periodo.
“Non si tratta solo dell’anniversario di Srebrenica o degli Accordi di Dayton”, afferma Minel Abaz. “La guerra è ancora presente nel discorso pubblico. I media e i politici la utilizzano come un punto fermo, anche per giustificare le divisioni attuali”.
Il costante ritorno al passato ha portato a quella che alcuni studiosi definiscono “politica di crisi permanente”.
“La Bosnia Erzegovina è sempre sull’orlo della guerra, se non effettivamente, almeno a livello retorico”, afferma Lejla Salihagić Batrićević, ricercatrice e redattrice di WesrBalkanNet. “Questa sensazione di instabilità rende i cittadini ansiosi, relegandoli ad una condizione di dipendenza dai leader politici che promettono di proteggere i rispettivi gruppi etnici”.
Questo meccanismo – che fa leva sulle paure e sulla nostalgia – alimenta anche la disinformazione.
“È il modo più semplice per manipolare le persone”, aggiunge Salihagić Batrićević. “Quando tutto viene presentato come una minaccia esistenziale, i fatti diventano secondari”.
L’alfabetizzazione mediatica come difesa
Di fronte alla sfida della disinformazione, Zašto ne e altre organizzazioni civiche hanno esteso la loro attività oltre la verifica dei fatti, dedicandosi anche alla formazione.
“Vogliamo contribuire a sviluppare la capacità dei cittadini di pensare in modo critico”, afferma Amina Izmirlić Ćatović. “Il fact-checking da solo non basta. Le persone devono imparare a verificare le informazioni autonomamente”.
Zašto ne collabora regolarmente con scuole e altre ong, ed e attualmente impegnata nell’organizzazione di eventi, in collaborazione con l’UNESCO, in occasione della Settimana mondiale dell’alfabetizzazione mediatica e informativa. L’obiettivo, come spiega Amina, è promuovere la cultura del dibattito.
“Non possiamo pretendere il rispetto del principio di responsabilità democratica se non lo chiediamo esplicitamente”, sostiene la ricercatrice.
La strada verso l’alfabetizzazione mediatica resta però tortuosa. L’impasse politica e il calo dell’impegno giovanile contribuiscono al diffondersi dell’apatia.
“Gli stessi politici sono al potere ormai da venticinque anni”, spiega Amina Izmirlić Ćatović. “I giovani non si interessano alla politica. Non credono che la situazione politica possa cambiare”.
Anche Minel Abaz è dello stesso parere.
“Ci sono opinioni diverse sulla possibilità di un nuovo conflitto”, afferma Abaz. “Si parla sempre di guerra, ma nella vita quotidiana le persone collaborano. La vera divisione è tra chi crede ancora che la politica conti e chi si è ormai arreso”.
Per gli osservatori interessati alla sicurezza europea, la Bosnia Erzegovina rappresenta un caso paradigmatico: un paese piccolo, con risorse limitate, esposto però alle stesse minacce legate all’informazione, e spesso con maggiore intensità, rispetto a paesi più grandi.
Gli strumenti sviluppati in Bosnia Erzegovina per monitorare la disinformazione, promuovere l’alfabetizzazione mediatica e coinvolgere il pubblico scettico potrebbero fungere da modello per altri paesi.
Allo stesso tempo, l’esperienza dell’Ucraina dimostra come la disinformazione può evolvere in un’aggressione diretta. Gli analisti in Bosnia Erzegovina spesso indicano questa traiettoria come un monito.
“Abbiamo visto cosa è accaduto in Ucraina”, afferma Amina Izmirlić Ćatović. “La disinformazione ha preparato il terreno per la guerra. Qui, si tratta ancora solo di parole. Ma anche le parole possono essere pericolose”.
Per ora, le battaglie in Bosnia Erzegovina si combattono online e nel dibattito pubblico: una forma di guerra più silenziosa, ma con conseguenze a lungo termine.
“Quanto sta accadendo in Bosnia Erzegovina non è un caso isolato”, sottolinea Lejla Salihagić Batrićević. “È un banco di prova per valutare la capacità delle democrazie fragili di resistere in un mondo dove l’informazione stessa è un campo di battaglia”.