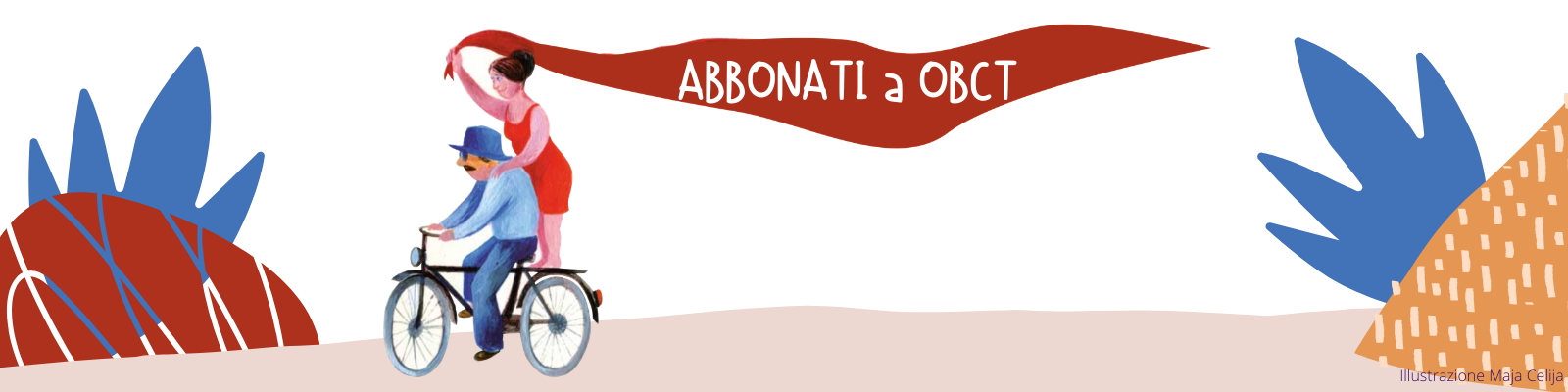Pesca in Adriatico: un esempio virtuoso di cooperazione transfrontaliera
Per proteggere gli ecosistemi marini dell’Adriatico sono necessarie politiche concrete, condivise da tutti i Paesi che si affacciano su questo mare. Spesso, questi risultati si ottengono grazie a iniziative di cooperazione transnazionale nate dal basso. Un’intervista

Pesca-in-Adriatico-un-esempio-virtuoso-di-cooperazione-transfrontaliera
Pesci nel Mare Adriatico © BSG_1974/ Shutterstock
Il Mare Adriatico ospita un patrimonio naturale di immenso valore che oggi si trova sempre più sotto pressione: oltre agli effetti dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento, la pesca intensiva, in particolare quella illegale e a strascico, compromette gravemente gli ecosistemi marini, portando a un rapido declino della biodiversità.
Per contrastare questa situazione, nel 2016 l’organizzazione MedReAct che si occupa di tutela della biodiversità marina, ha avviato il progetto Adriatic Recovery Project , e promosso la creazione di una coalizione transnazionale che ha riunito organizzazioni ambientaliste e centri di ricerca, con lo scopo di favorire l’istituzione di una Fisheries Restricted Area (FRA), ovvero una zona in cui la pesca viene vietata o fortemente limitata, in prima battuta nella Fossa di Pomo tra Italia e Croazia.
Per approfondire questa iniziativa e quanto ne è seguito nell’area dell’Adriatico meridionale, ovvero nel Canale di Otranto, abbiamo raccolto la testimonianza di Domitilla Senni di MedReAct come esempio di collaborazione transnazionale che contribuisce all’adozione di pratiche virtuose di tutela ambientale.
Come nasce il vostro lavoro a tutela della pesca nel mare Adriatico?
Per iniziare va detto che la pesca è spesso fonte di conflitto tra stati che condividono lo stesso bacino. In Adriatico gli italiani hanno fatto da padroni per tanti anni, finché la Slovenia e la Croazia sono entrate nell’Unione Europea e hanno iniziato a far sentire il peso delle loro flotte, soprattutto la Croazia. Da qualche anno, anche l’Albania, che è ancora in fase di adesione, ha cominciato ad investire nella pesca ed è gradualmente diventata competitiva.
Dal 2016 la Commissione Europea ha promosso misure di gestione della pesca in tutto il Mediterraneo, dove c’è un grosso problema di sovrasfruttamento delle risorse ittiche e di pesca illegale. La Commissione ha iniziato ad intervenire in maniera puntuale, e devo dire che è anche grazie a questo impegno se si sono ottenuti dei risultati importanti.
In tutto questo noi ci siamo inseriti nel 2016 come organizzazione ambientalista che si occupa di mare con l’obiettivo di tutelare gli ecosistemi più vulnerabili.
Com’è iniziato il vostro lavoro sulla Fossa di Pomo?
Nel 2015 Italia e Croazia raggiunsero un accordo bilaterale che prevedeva la chiusura di un’area centrale della Fossa di Pomo alla pesca a strascico da parte di entrambi i paesi, inizialmente per un anno. Alla fine di quell’anno l’Italia decise di riaprire alla pesca a strascico nell’area protetta senza il consenso della Croazia, perdendo di fatto i benefici che cominciavano a materializzarsi dal punto di vista delle risorse biologiche. La Croazia reagì male a quell’iniziativa unilaterale italiana e i rapporti si congelarono.
A quel punto siamo intervenuti noi, rivolgendoci alla Commissione Generale per la Pesca del Mediterraneo (CGPM), l’organismo della FAO che gestisce le risorse ittiche in tutto il bacino, quindi sia quelle europee che quelle non europee.
Decidemmo di sottoporre una proposta di tutela sovranazionale perché questo avrebbe consentito di allargare la discussione a tutti i paesi che operavano nel bacino Adriatico.
La nostra proposta di creare una zona di pesca soggetta a restrizioni fu fortemente sostenuta dalla Croazia e in tempi piuttosto rapidi si arrivò a un nuovo accordo che sbloccò l’impasse tra i due paesi: Italia e Croazia adottarono un decreto gemello in cui definirono l’area di protezione e le misure di restrizione alla pesca.
Anche la Commissione Europea si convinse della bontà di questa proposta e nel 2017 l’Unione europea propose alla CGPM una decisione che ricalcava e rafforzava i decreti dell’Italia e della Croazia. La proposta venne adottata dalla CGPM che istituì la prima FRA dell’Adriatico, inizialmente per tre anni. Nel maggio del 2021, visti i risultati straordinari che quest’area cominciò a produrre – era la prima area di questo tipo che godeva di un monitoraggio scientifico – decisero di renderla permanente. La decisione fu considerata storica.
Questo migliorò molto anche i rapporti fra i due paesi per quanto riguarda l’aspetto della cooperazione bilaterale, soprattutto grazie al programma di monitoraggio condotto da ricercatori di entrambe le sponde.
Chi ha contribuito a questa iniziativa?
Abbiamo lavorato insieme all’Università Politecnica delle Marche, ad alcune ONG italiane e al WWF Adria per la parte croata. Nel 2018, sempre nell’ambito dello stesso progetto, l’Adriatic Recovery Project, abbiamo presentato una proposta simile per la tutela del Canale di Otranto. In quel caso però abbiamo incontrato molte resistenze, prevalentemente da parte italiana ma anche da quella albanese, per cui ci sono voluti sei anni per ottenere un risultato. Finalmente nel 2024, la proposta è stata accolta dalla CGPM che ha istituito la FRA di Otranto, grazie anche all’impegno della Commissione Europea.
Avete collaborazioni con ONG o ricercatori locali nei Balcani?
In Albania abbiamo lavorato con l’Università di Tirana, che ha svolto per noi un’indagine sulla pesca nei principali porti del paese. Il problema è che mancano ONG specializzate sulla pesca, soprattutto quella d’altura. Inoltre, la ricerca in mare è costosa e gli strumenti in Albania scarseggiano.
Vi relazionate anche con le istituzioni regionali come EUSAIR?
Non direttamente. Il nostro lavoro punta a convincere i governi nazionali e la Commissione Europea. Le macroregioni possono servire per creare consenso e condividere dati, ma le decisioni reali si prendono altrove e il nostro obiettivo è quello di arrivare a delle decisioni vincolanti la cui applicazione determini un cambiamento verso una gestione più sostenibile del mare.
Il fatto che l’Albania non sia un paese membro dell’UE rappresenta un ostacolo a questo tipo di iniziative transfrontaliere?
Può essere un elemento di debolezza, perché in quanto paese non membro è meno soggetta ai regolamenti europei sulla pesca. C’è stato però un grosso sforzo da parte albanese nell’adeguare la propria normativa a quelle regole che dovranno implementare quando entreranno nell’Unione europea, se mai succederà.
È corretto affermare che anche voi state dando un contributo al loro percorso di integrazione europea, sostenendoli in questo percorso di armonizzazione normativa?
Indirettamente, sì. Attraverso questa proposta loro sono venuti in contatto con organizzazioni che li hanno supportati dal punto di vista tecnico, nella raccolta dati e più complessivamente nella gestione della propria flotta.
Qual è oggi il vostro ruolo?
Dopo l’istituzione della FRA, il nostro compito è monitorare affinché vengano davvero messe in atto le misure di tutela previste e far conoscere i risultati ottenuti.
Sulla Fossa di Pomo, ad esempio, cerchiamo di divulgare il più possibile il successo di questa iniziativa: abbiamo realizzato documentari e campagne per mostrare i benefici della tutela. Se invece rileviamo violazioni, segnaliamo i casi alla Commissione Europea o alla CGPM.
State lavorando a nuove proposte?
Sì, ora stiamo lavorando sul Nord Adriatico, tra Chioggia e l’Istria. Se con l’Italia continuiamo a fare fatica, la Croazia sostiene pienamente queste misure, ha capito che funzionano e che hanno un impatto positivo per il mare e il futuro della pesca.
Questo articolo è stato scritto nell’ambito del progetto "Il contributo delle Comunità di Pratica per l’integrazione europea dei Balcani”, realizzato con il contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Le opinioni contenute nella presente pubblicazione sono espressione degli autori e non rappresentano necessariamente le posizioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Tag: CoP-CET