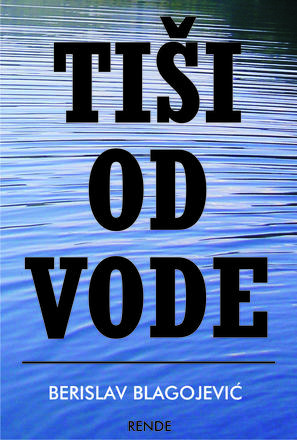Più calmo dell’acqua
Berislav Blagojević, classe 1979, è una delle voci più brillanti e poliedriche della nuova letteratura bosniaco erzegovese. E’ l’autore di Tiši od vode [Più calmo dell’acqua, 2013], un requiem sulla guerra privo di ogni schermo ideologico sulle perduranti contraddizioni del dopoguerra. Intervista
Danilo Mišić è un tranquillo geografo che si ritrova improvvisamente gettato nel fango di una guerra fratricida. Durante un’operazione militare commette un banale quanto tragico []e di lettura delle mappe, che dà origine a un sanguinoso fuoco amico e lo segna per sempre. Vittima di un paralizzante disturbo allucinatorio da stress post-traumatico, viene trasferito dai campi di battaglia alla non meno assurda dimensione di un ospedale psichiatrico, prigioniero della propria mente e abbandonato a se stesso da medici negligenti e in certi casi corrotti. Si chiude in una coltre impenetrabile di silenzio e l’unica forma di comunicazione con il resto del mondo è un carteggio immaginario con un suo omonimo compagno di destini, lo scrittore russo Daniil Charms. A lui affida pensieri e meditazioni, in un inarrestabile flusso dialogico dove la realtà quotidiana è intrisa di paradosso, ogni sistema di valori viene sovvertito e l’uomo comune è ridotto a inconsapevole esecutore del male, niente più che muta e indistinta carne da cannone. Un ritratto allo specchio di un lucido e sofferente visionario, scandito dal drumming dei Pearl Jam e accompagnato dalle sinfonie oniriche dei Pink Floyd, cui fanno da contrappunto le ballate di Bob Dylan e Leonard Cohen.
Danilo Mišić è l’antieroe di Tiši od vode [Più calmo dell’acqua, 2013], un romanzo intenso e spiazzante, una rigorosa riflessione sulla fiducia nel prossimo, sulla libertà di scelta, sul degrado morale e su quel persistente disagio collettivo chiamato “transizione”. Un requiem sulla guerra, in cui tutti sono indiscriminatamente vittime, e insieme un affresco amaro, a tratti grottesco e privo di ogni schermo ideologico delle perduranti contraddizioni del dopoguerra.
L’autore, Berislav Blagojević, classe 1979, è una delle voci più brillanti e poliedriche della nuova letteratura bosniaca. Nato a Slavonski Brod da una famiglia serba, ha dovuto fare i conti con la guerra poco meno che adolescente. Con il deflagrare del conflitto in Slavonia la madre lo affidò a un vicino di casa, musulmano, il quale se lo caricò in macchina e spacciandolo per suo figlio, riuscì a eludere i posti di blocco e a metterlo in salvo presso alcuni parenti a Doboj. Erano i primi mesi del 1992. Oggi Berislav vive a Banja Luka. Una storia, la sua, autenticamente e tristemente bosniaca…
Nel romanzo ritroviamo le stesse atmosfere rarefatte, la stessa sospensione su un abisso di attese silenti e ordinaria rassegnazione di cui sono compenetrati i versi della raccolta Trebao sam biti riječ [Sarei dovuto essere una parola, 2005] e i racconti di Ja, revolucionar [Io, rivoluzionario, 2010-2012]. Uno di questi ultimi è stato selezionato come migliore short story della narrativa bosniaca contemporanea e inserito da uno dei curatori, l’artista Mladen Miljanović, nel catalogo-antologia The Sea is my Land (Feltrinelli 2013, pp. 178-180), ed è disponibile in italiano con il titolo La fuga
Non sappiamo e non sapremo mai da quale parte ha combattuto, quale causa o vessillo si è trovato forzatamente a sostenere, nessun dettaglio ce lo svela. Possiamo soltanto affermare che Danilo Mišić è la compiuta metafora dell’odierna Bosnia Erzegovina. Rinchiuso all’interno di frastagliati confini tracciati da altri, laddove il compasso ha seguito pedissequamente le scie di sangue e riprodotto le geometrie dei carnefici, e imbrigliato in un’astrusa impalcatura costituzionale e in una struttura amministrativa frutto di una logica manicomiale, il Paese vive un’inscalfibile, permanente immobilità.
Una classe politica negligente e per lo più corrotta, una gigantesca e diabolica macchina burocratica e uno sviluppo economico affidato all’opacità e talvolta alla provenienza illecita di investimenti esteri, si prendono cura di un paziente silenzioso e remissivo, preda degli incubi del passato e della statica agonia del presente, che al compiaciuto e ironico fatalismo riesce a opporre soltanto un immaginifico istinto di fuga. Un paziente cronico rintronato dalla damnatio memoriae e da una sempreverde retorica identitaria, che sulle macerie di sé consuma la propria sofferenza e da quelle macerie attende invano una rinascita come il volo di un’Araba Fenice. Se l’inclinazione alla fuga di Danilo individuerà uno sbocco concreto grazie a un improvviso soprassalto di etica professionale di uno degli psichiatri che lo hanno in cura, e porterà alla riscoperta di una serenità perduta, ci chiediamo quale medico sarà mai in grado di guarire la Bosnia Erzegovina e indicarle un futuro di stabilità e prosperità.
Approfittiamo della recente tornata elettorale per porre alcune domande a Blagojević, a cavallo tra politica, società e letteratura.
In che misura la tua storia personale si nasconde dietro quella di Danilo Mišić? Che ruolo gioca la guerra nella tua opera letteraria?
Danilo Mišić ha nove anni più di me e ovviamente dispone di un bagaglio di esperienze e ricordi che per ragioni anagrafiche non può essere anche mio. Oltre a non aver studiato letteratura, e a non aver tradotto una sola riga di Charms, io non ho mai partecipato ad azioni di guerra. È un personaggio di assoluta finzione, che però esprime un diffuso modo di pensare e di vivere ‑ o per meglio dire sopravvivere ‑ impostosi nel dopoguerra. È un uomo che incarna le problematiche legate alla transizione e si interroga sulle più dirimenti questioni sociali, sul significato di nozioni quali amore e amicizia, e sulla funzione salvifica di musica e letteratura, da una prospettiva del tutto intima.
Non c’è dubbio che la guerra abbia cambiato nel profondo ciascuno di noi, a prescindere dalla nazionalità, dall’età e dallo status sociale. Ho l’impressione che ancora oggi, a diciannove anni di distanza, la gente continui a misurare il tempo con un metro specifico: “prima” e “dopo” il conflitto. La guerra non è la mia principale preoccupazione quando scrivo, ma talvolta è impossibile non farne un tema letterario. Tiši od vode non è un romanzo centrato sulla guerra, ma su ciò che accade “dopo”. E in un certo senso, alcuni dei miei racconti che affrontano delicati argomenti sociali non possono fare a meno di confrontarsi con la guerra, perché se non avessimo vissuto questa terribile esperienza, non saremmo quello che siamo. E questo vale anche per chi è nato “dopo”. Diciamo che la guerra gioca un ruolo evidente nel mio lavoro letterario, ma non ne faccio un’ossessione. Mi interessano molto di più le trasformazioni, le incongruenze e le assurdità che sono intervenute “dopo”.
In attesa dello spoglio definitivo e dei risultati ufficiali, possiamo affermare di trovarci di fronte a un Paese condannato all’instabilità, alla permanente crisi economica e sociale, alle divisioni interne?
Non mi sento a mio agio quando sono chiamato a dare un commento su questioni di politica interna, poiché essa, soprattutto nei suoi riflessi sulla vita quotidiana, rimane per me un qualcosa di strano e incomprensibile, che sfugge spesso alle più elementari categorie logiche. Di solito mi difendo dicendo che non sono un esperto… E tuttavia, da cittadino, temo di non poter smentire l’affermazione secondo la quale rispetto all’instabilità, alla crisi economica e alle divisioni interne, non ci sarà alcun cambiamento a breve termine, a prescindere da chi vincerà le elezioni. Inoltre è tragico se non addirittura ridicolo il fatto che a dieci giorni di distanza non disponiamo ancora dei dati definitivi. Questo dato è abbastanza eloquente.
Le cause di ciò che si profila sempre più come un perpetuo dopoguerra sono da ritrovare nelle separazioni intestine – che provocano a loro volta un interminabile processo di transizione – o nel complesso scheletro istituzionale disegnato a Dayton? Sono la crisi profonda e la mancanza di prospettive future che spingono l’elettorato bosniaco ad affidarsi a posizioni politiche consolidate o a scegliere l’astensionismo? Oppure è il trattato di ingegneria costituzionale uscito da Dayton a impedire di per sé qualsiasi uscita dallo stallo politico-istituzionale?
Bisogna prima di tutto capire che da queste parti il principio dell’“interesse nazionale” è sacro; è un soverchiante mantra politico intonato da tutte le componenti in gioco. Dove l’aggettivo “nazionale” è beffardamente opposto al suo significato naturale: in Bosnia non esiste ancora un concetto di “nazione”, solo di “nazionalità”. Ogni proposta di cambiamento che viene dall’interno del sistema politico o dalle organizzazioni civiche è vista puntualmente come un attacco a tale principio. Si tratta di una carta che viene giocata spesso e che vince sempre. È ovvio che le élite politiche puntino alla preservazione dello status quo, a un perenne stato di crisi e di paura, perché è più facile governare in un clima simile. Si può dare la colpa agli “ingegneri” di Dayton, ai burocrati dell’UE, ai politici locali o agli affaristi internazionali che trovano in Bosnia un terreno fertile: ciascuna di queste accuse è di per sé corretta e giustificata. Tuttavia, se esiste una democrazia anche in questa parte d’Europa (e voglio credere che sia così), allora siamo noi, gente comune, i primi responsabili del disastro attuale. Nonostante la situazione nel Paese impedisca a molti una vita normale – una vita almeno coerente con gli standard del XXI secolo ‑ noi, gente comune, non abbiamo ancora toccato il fondo. Quando accadrà, il cambiamento avverrà di conseguenza, perché la fame non riconosce alcuna identità etnica.
Pensi che l’ordine geopolitico stabilito a Dayton rimarrà invariato nei prossimi anni o gli attuali confini, interni ed esterni, verranno ridisegnati? E in questo caso, in modo pacifico o attraverso nuovi conflitti?
Intendi il disordine geopolitico? Non so, al momento ogni congettura in tal senso è plausibile. L’unica cosa che posso dire è che nelle condizioni attuali lo Stato non risponde ad alcun criterio di funzionalità, e il complicato e confuso assetto amministrativo, insieme all’imponente apparato che produce, consumano la maggior parte di energie e di denaro, senza che i cittadini ne abbiano alcun beneficio. Qualsiasi cosa accada in futuro, posso solo pregare per una soluzione pacifica.
Che ruolo giocano gli scrittori e gli intellettuali in genere nell’attuale situazione? In che misura possono rappresentare una spinta al cambiamento?
Il potere della letteratura mi sembra eccessivamente enfatizzato. Non foss’altro che i più anziani mutano opinioni, abiti mentali e comportamenti con molta difficoltà, mentre i giovani non paiono mostrare alcun tipo di interesse alla parola scritta. Inoltre, di fianco alla censura ufficiale, agisce sempre una sorta di autocensura. Per esempio, nonostante Tiši od vode sia un romanzo contro la guerra, i media di Sarajevo, a esclusione di “Oslobođenje” e “Dani”, lo hanno volontariamente snobbato. E allo stesso modo nella Republika Srpska c’è un vuoto di informazione su ciò che accade nella scena letteraria delle altre entità del Paese. Non ne capisco la ragione, ma penso che in un ambiente simile lo scrittore abbia uno spazio d’azione e un ruolo nel dibattito pubblico oltremodo limitati. Come tutto il resto, anche le associazioni di scrittori o le società letterarie sono divise secondo l’appartenenza etnica e la nazionalità di riferimento. Certo, alla regola corrispondono sempre le eccezioni, ma non sono molte.
Tra gli autori bosniaci contemporanei più conosciuti in Italia e in Europa ci sono Miljenko Jergović e Aleksandar Hemon, due scrittori che hanno entrambi abbandonato il Paese durante la guerra, il secondo scrive addirittura in una lingua diversa da quella madre. Quali sono, secondo te, le ragioni della marginalizzazione degli autori bosniaco erzegovesi e in particolare della nuova e prolifica generazione di scrittori?
Credo sia dovuta al generale destino delle “piccole lingue” più che ad altri motivi. Diversi grandi scrittori di epoca jugoslava non hanno ottenuto, né in Europa né altrove, il riconoscimento o l’attenzione che meritavano. Un’altra ragione è che romanzi o racconti ispirati alla guerra o al dopoguerra, o che hanno nei conflitti che hanno segnato le nostre sorti un imprescindibile scenario mentale, sono fatalmente passé. Mentre l’Europa va avanti e guarda al futuro, noi siamo ancora avvolti e paralizzati dai nostri demoni, che chiunque viva lontano dai Balcani fatica a comprendere o non ha interesse ad approfondire. Un’ulteriore motivazione si può ritrovare forse nel fatto che le cattedre universitarie all’estero sono per lo più di lingua e letteratura croata o serba, e tendono così a promuovere la traduzione di autori provenienti dalla Croazia o dalla Serbia.
Tu sei un serbo-bosniaco, vivi in Republika Srpska, una parte della Bosnia Erzegovina che spesso sembra guardare più a Belgrado che a Sarajevo. Quanto risentono il tuo impegno intellettuale e il tuo lavoro letterario di questa difficile situazione politica?
Per quanto mi riguarda, io scrivo in serbo, il mio editore è di Belgrado e senza dubbio considero il mio lavoro parte della letteratura e della cultura serba. Naturalmente sono un cittadino della Republika Srpska, dunque cerco di misurarmi con la scena letteraria e il dibattito culturale della Bosnia Erzegovina. Onestamente, non mi pongo granché la questione. Il mio mestiere è scrivere, nella maniera e nelle condizioni migliori possibili.
Tu sei solito ambientare le tue storie altrove, in un ampio spazio narrativo che va dagli Stati Uniti alla Georgia, dall’Inghilterra alla Germania. È la deformazione professionale del geografo oppure una sorta di fuga narrativa?
Un po’ entrambi, credo. Mi piace mettere a frutto i miei studi di Geografia collocando le mie storie in altri spazi, ma solo per sottolineare che le vicende e i destini umani sono o potrebbero essere universali. In un certo senso cerco di restringere il mondo e di mostrare come amore, sofferenza, guerra, tradimento e povertà si trovano in ogni angolo del pianeta. A ogni modo ci sono parti del globo che considero particolarmente interessanti e vicine al mio cuore, come la Georgia e la regione caucasica in generale. Ho voluto ambientare lì alcune short stories ‑ e non a caso Danilo Mišić trova la sua pace interiore a Batumi, una città georgiana sul Mar Nero – non alla ricerca di un luogo “esotico”, ma perché il Caucaso è uno spazio in tutto e per tutto analogo ai Balcani. Da un punto di vista storico, etnodemografico, religioso e politico, il Caucaso e i Balcani sono più simili di quanto si è soliti pensare. Capita talvolta che quando scrivo di Georgia, sto scrivendo in realtà del mio Paese.
Il tuo Paese, appunto. Hai mai pensato seriamente di andartene, di costruire la tua carriera letteraria altrove?
Nonostante sia una straordinaria fonte di ispirazione, nei suoi aspetti positivi così come in quelli negativi, il mio Paese non mostra alcun interesse per i suoi artisti, non crea le condizioni affinché essi siano un motore del suo sviluppo e dunque possano vivere, lavorare ed esprimere la propria creatività senza ostacoli reali, senza dover lottare quotidianamente per la sopravvivenza. E così non mi resta che risponderti: sì, ci penso ogni giorno che passa.
Tag:
I più letti
 Transizione energetica
Transizione energetica