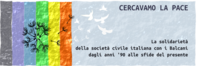Nel gorgo della Diamond Route
Il terzo di una serie di racconti che prendono spunto dal percorso formativo “Ex Jugoslavia, una guerra postmoderna. Viaggio nel cuore dell’Europa” realizzato nel settembre scorso dall’Istituto storico di Modena
«Nell’epoca della globalizzazione
la guerra non è più monopolio degli stati nazionali
né, come voleva von Clausewitz,
“la continuazione della politica con altri mezzi”.
Al suo posto c’è un altro tipo di violenza organizzata,
in cui confluiscono ragioni militari e criminalità,
economia illegale e violazione dei diritti umani…»
Mary Kaldor
Le nuove guerre
Non so quale fosse la ragione per la quale l’UNPROFOR1 avesse chiamato Diamond Route quella strada sterrata nella Bosnia centrale, forse per via della miniera di Radovan cui si poteva accedere proprio attraverso la rotta che collegava Prozor a Travnik lungo il torrente che scende dalle pendici della Vranica.
Di certo c’era che quella strada avrebbe dovuto essere sotto il controllo delle Nazioni Unite e dunque percorribile per i convogli umanitari. Ma in quegli anni imparammo che il vecchio ordine stava proprio per finire, che nelle nuove guerre non ci sarebbero state nemmeno formalmente delle regole cui attenersi e che il monopolio della violenza non sarebbe più stato riconducibile alle sole istituzioni statuali, figuriamoci in un paese dove le vecchie istituzioni erano svanite come neve al sole.
Del resto i volontari bresciani quella strada per arrivare a Zavidovići provenienti da Spalato l’avevano percorsa altre volte nei mesi precedenti, senza incontrare – almeno in apparenza – difficoltà particolari. E dunque in quel 29 maggio 1993 erano lì, sulla Diamond Route, con il loro piccolo convoglio umanitario che, rompendo l’assedio, avrebbe dovuto portare un camion a rimorchio carico di beni di prima necessità e, al ritorno in Italia, un gruppo di donne con i loro bambini. Avevano una lista di 67 persone, i visti delle autorità di confine, i pullman in attesa, una comunità che si era predisposta all’accoglienza e a dare un po’ di sollievo a queste persone stremate da una guerra che in prossimità dell’estate del ’93 già sembrava infinita. La storia, come sappiamo, non andò così.
Venticinque anni dopo, lungo quella strada ancora sterrata percorsa da camion carichi di legname e qualche rara automobile, si può appena comprendere quale potesse essere lo stato d’animo di Sergio, Fabio, Guido, Christian e Agostino quando finirono nel gorgo di una guerra diversa da quelle precedenti. E non solo perché si combatteva sull’uscio di casa nostra.
Quel gorgo che i pacifisti non avevano messo in conto aveva a che fare con le sembianze dei moderni miliziani, una generazione «allevata a suon di noiosi rituali pseudo-politici, indotta all’apatia politica e senza orientamento»2 e, in quanto deresponsabilizzata, incline alla distruzione di ciò che i padri avevano confezionato per loro.
In questo gorgo vennero travolti. Perché gli uomini agli ordini del comandante Hanefija Prijić detto Paraga, dopo averli derubati di ogni cosa, non esitarono a sparargli addosso con i loro kalashnikov. Morirono in tre, Sergio Lana, Fabio Moreni e Guido Puletti.
A raccontarci questa tragica vicenda nel luogo in cui avvenne l’agguato c’è Agostino Zanotti, uno dei due volontari (insieme a Christian Penocchio) che in quel tragico giorno di primavera riuscì a salvarsi gettandosi a capofitto lungo un pendio boscoso e poi in un torrente che gli salvò la vita.
Non so come Agostino, amico con il quale ho condiviso più di vent’anni di passione balcanica, trovi ancora la forza di ritornare lungo quella strada, per condividere con noi quelle drammatiche ore e quella dolorosa domanda – ancora oggi senza risposta – che Agostino e i suoi compagni di sventura si chiedevano mentre sul rimorchio di un trattore andavano verso il luogo della mattanza: perché?
Perché un piccolo convoglio – un camion carico di aiuti umanitari e un fuoristrada – potevano valere l’uccisione di queste persone… perché l’assassinio di quei volontari che con le sorti della guerra avevano ben poco a che fare… perché quei miliziani che mostravano i simboli islamici si accanirono con tanta crudeltà contro un convoglio diretto a Zavidovići, cittadina sotto il controllo delle milizie mussulmane… perché Unprofor non ne garantì la protezione… E poi, con rara onestà intellettuale, altri interrogativi… Improvvisazione? Superficialità e scarsa conoscenza? Quel gorgo era un puzzle troppo complesso per affrontarlo con le sole armi della ragione?
Agostino non si sottrae affatto a queste domande, perché se in quel bisogno di non volgere lo sguardo altrove c’era la considerazione, comune a tutti noi, che ogni vita nella sua irripetibilità aveva un valore assoluto, c’era altresì il senso della prudenza e del limite.
"Non c’era in noi alcuna ricerca di azioni eclatanti o di atti di eroismo", sottolinea Agostino nel suo racconto accanto alla lapide che ricorda l’eccidio. E se solo avessero avuto in quei giorni la sensazione del rischio che andavano correndo le scelte sarebbero state certamente diverse.
Ma quella guerra si svolgeva dietro l’angolo. Come assistervi nel silenzio? Come essere indifferenti all’assedio di città e borghi che avevamo conosciuto in tempo di pace come esempi di convivenza? Come guardarsi in faccia di fronte alle richieste di aiuto che cadevano nel vuoto del cinismo delle diplomazie internazionali?
Ricordo quanto nei nostri mondi ci si interrogasse – in quei mesi che nel loro inesorabile procedere diventavano anni – sul nostro stesso modo di interpretare il pacifismo, avvertendone l’impotenza e talvolta l’indifferenza a partire dalla considerazione che in quelle latitudini ogni divisione manichea fra popoli e imperialismo, o se vogliamo fra bene e male, non funzionava più. E che, fra interventismo e pacifismo di maniera, veniva interpellata anche la nostra stessa responsabilità.
Cercammo altre strade. Discutevamo di pacifismo concreto e di interposizione nonviolenta. Nacquero in quel contesto sperimentazioni innovative nel tentativo di abitare i conflitti pure in contesti di guerra. Demmo vita all’UNIP3 e ad altri luoghi di formazione perché la pace non fosse semplicemente uno stato d’animo (e tanto meno approssimazione superficiale). Sperimentammo i primi tentativi di diplomazia popolare, cercammo risposta alle necessità di accoglienza e di volontariato nei campi profughi, ci interrogammo sulle modalità di rompere l’isolamento e tenere vivi i legami famigliari e amicali attraverso piccole grandi cose come la raccolta e la consegna della posta. Nelle relazioni con i pacifisti delle diverse nazionalità jugoslave, indicammo la necessità di tradire le proprie appartenenze per mettere fine all’equivoco di una guerra che veniva descritta come etnica ma che aveva ben altre connotazioni.
Nacquero in questo contesto la Marcia dei Cinquecento che riuscì a raggiungere una Sarajevo sotto assedio e la successiva Mir Sada che si dovette fermare lungo le linee del fronte di guerra, tentativi pure con esiti contraddittori di interposizione nonviolenta: il far cessare il fuoco seppure per qualche ora, il sostegno verso la resistenza civile che cercava di non piegarsi pur sotto le bombe alla logica della guerra, la frustrazione nel dover prendere atto che nella guerra i margini per il dialogo si assottigliavano fino a sparire. Ci sembrava un grande movimento, forse lo era4.
Fu così che nella complessità delle nuove guerre, anche un piccolo convoglio di aiuti poteva diventare merce di scambio, oppure avvertimento o un messaggio incrociato nella disputa territoriale fra bande criminali, dove misurare poteri e nuove gerarchie, oppure ancora cambio di alleanze fra i signori della guerra. Che a guardar bene erano talvolta gli stessi che lucravano sugli aiuti o che gestivano i convogli per aiutare “i nostri”, così che anche il buon cuore poteva venir arruolato. Che spesso partivano dall’Italia e magari proprio dalla provincia di Brescia, ma carichi di armi made in Italy. O che raccoglievano fondi con il racconto di improbabili apparizioni, in nome di guerre che diventavano sante. Di certo, non eravamo preparati a tutto questo.
Agostino prosegue il suo racconto. La voce si fa tremula, un’emozione solo dissimulata dalla volontà di non prendersi troppo sul serio. Una componente che nel nostro viaggiare balcanico ci ha spesso aiutato a sdrammatizzare, laddove il carico di dolore rischiava di soffocarci. Ricordo in particolare un viaggio con Agostino fra Prijedor, Zavidovići e Sarajevo, i nostri racconti incrociati e la necessità di far prevalere la gioia di vivere fin quasi ad essere sopra le righe. Con noi quella volta c’era Luca Rastello, lunghe discussioni nella consapevolezza che avessero vinto loro, quelli delle auto dai vetri abbrunati che sfrecciavano nelle città fra locali notturni, traffici criminali di ogni tipo, capannoni commerciali che nascevano come i funghi. Gli stessi che qualche anno prima scorrazzavano in tuta mimetica, bandana e armi automatiche e che già allora ne avevano compreso la modernità, nell’accumulazione dei profitti di guerra come nel loro proporsi paternalistico come signori di un neo-feudalesimo. A quel punto l’humor nero di Mujo e Suljo5 ci veniva in soccorso, a stemperare quel senso di amarezza ed inquietudine che la postmodernità ci presentava e che, nell’interdipendenza, ci faceva presagire scenari futuri.
Nel racconto le immagini si sovrappongono come nel rapido scorrere di una pellicola. Gli uomini armati e l’evidenza che non si trattasse di un check-point come tanti, il teschio sulla mimetica, il capo con la faccia da gnomo, le targhe e le insegne strappate, lo sguardo allucinato del miliziano che ti punta addosso l’arma dicendo money – money, la normalità della gente dei villaggi tutt’intorno, la paura che diventa terrore, la fuga disperata con i colpi che sibilavano intorno, l’acqua del torrente che ti salva la vita, la notte trascorsa vagando e senza sapere la fine dei tuoi compagni, la diffidenza verso ogni uomo in divisa, l’impressione che tutti sapessero…
Si fermano due persone che passano sulla Diamond con la loro rampichino, sanno perché siamo lì, conoscono la vicenda e a quanto pare anche il capo… Per anni quel personaggio venne considerato un patriota ed un eroe, canzoni a lui dedicate e l’avvio di una carriera politica nel consiglio comunale di Gornji Vakuf. Tutti sapevano, tutti sanno. Niente di strano… quando conobbi Milomir Stakić, il primo ad essere condannato all’ergastolo per crimini di guerra dal Tribunale de L’Aja, era il sindaco di Prijedor.
Conosciamo forse nella storia criminali privi di consenso? E non è forse vero che i signori di questa guerra sono stati ad un passo del Premio Nobel per la Pace per quegli accordi6 che di fatto segnarono il riconoscimento della divisione “etnica” della Bosnia Erzegovina? Del resto quanti percorsi di elaborazione del conflitto – in Bosnia Erzegovina come altrove – abbiamo conosciuto? E dove e quando si è saputo andar oltre la colpa criminale, indagando quella politica e morale?
Quando Luca Rastello scrive La guerra in casa, tutta la vicenda sembrava volgere verso l’archiviazione. Un delitto comune, per rapina. «Se nulla accadrà» scrive Luca «saranno per sempre le quattro e mezza di sabato. “Senti un po’ che cazzo dicono questi!”. “Piantala, Guido, siamo sulla Diamond, la radio ci serve”. “Ehi, attento! Il camion si è fermato”»7.
Se non fosse stato per la tenacia di Agostino – accompagnato dai famigliari di Guido Puletti e da Cristian Penocchio – nel cercare la verità sull’eccidio del 29 maggio e il sostegno alla richiesta di riconoscere in quell’eccidio i tratti del crimine politico da parte delle istituzioni e della società civile bresciane, l’esito sarebbe stato scritto nella banalizzazione di una tragica rapina.
E invece, per una volta almeno, il riconoscimento da parte sia della magistratura bosniaca come di quella italiana di un crimine di natura politica, ha permesso che i processi ricostruissero qualche pagina di verità, quand’anche una risposta a tutti quei perché? appare ancora avvolta nelle nebbie della Bosnia centrale.
Meglio forse sarebbe scrivere nelle nebbie e basta. Guardo i volti dei miei compagni di viaggio, molti gli insegnanti e qualche giovane studioso che hanno scelto di essere qui e di farsi attraversare da questo ed altri racconti, venticinque anni dopo. Persone sensibili, attente. Altri non sono qui.
Eppure… gran parte di loro non ne sapevano nulla o quasi. Non parlo solo dell’eccidio della Diamond Route, penso allo sguardo distratto verso luoghi come Srebrenica, Vukovar, Omarska, Sarajevo. Molti di loro nella prima metà degli anni ’90 erano già persone adulte, altre guerre e altri scenari occupavano le cronache, fra Rwanda e Cecenia, Vicino Oriente e Afghanistan. Ma quello che avveniva di là del mare scivolava via, fra luoghi comuni e rimozione. Mi chiedo quale sia il meccanismo che seleziona le nostre coscienze ed il nostro dolore.
Nel pensare che dal 28 agosto 2018 Hanefija Prijić sia di nuovo in libertà senza aver mai riconosciuto le proprie responsabilità e aver dato risposta alla domanda cruciale che quei volontari si ponevano mentre un banale carro trainato da un ancor più banale trattore li portava verso l’eccidio, l’impressione è che il tempo si sia effettivamente fermato alle quattro e mezza di quel sabato pomeriggio.
Gornji Vakuf, ottobre 2018
1. Acronimo di United Nations Protection Force, Unprofor venne istituita con la risoluzione delle Nazioni Unite n.743 del 21 febbraio 1992 con il compito di «creare le condizioni di pace e sicurezza necessarie per raggiungere una soluzione complessiva della crisi jugoslava».
2. Rada Ivekovic, Autopsia dei Balcani. Raffaello Cortina Editore, 1999
3. Si tratta dell’International University of Peoples’ Institutions for Peace (IUPIP)
4. Vedi il Dossier di OBC-T “Cercavamo la pace” – https://www.balcanicaucaso.org/Dossier/Cercavamo-la-pace/Cercavamo-la-pace-138371
5. I tradizionali personaggi delle barzellette bosniache.
6. Stipulati tra l’1 e il 21 novembre 1995 nella base aerea USAF Wright-Patterson di Dayton nell’Ohio, gli Accordi di Dayton posero fine alla guerra in Bosnia Erzegovina. Ai colloqui parteciparono Slobodan Milosevic, Franjo Tudjman (di fatto ammettendo che la guerra in BiH era affar loro) ed Alija Izetbegovic, il mediatore statunitense Richard Holbrooke, il rappresentante europeo Carl Bildt e quello russo Igor Ivanov. Gli accordi vennero formalizzati a Parigi il 14 dicembre 1995. Con essi vennero riconosciuti i confini interni del fronte di guerra, tanto in BiH quanto fra la Croazia e la Serbia (Slavonia orientale).
7. Luca Rastello, La guerra in casa. Einaudi, 1998.