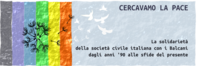Cercavano la pace (II)
Dal superamento della fase dell’emergenza nel dopo-Dayton in Bosnia Erzegovina sino al conflitto in Kosovo. La seconda puntata di un viaggio attraverso i materiali raccolti dal progetto di OBC "Cercavamo la pace"
Con la firma degli accordi di Dayton e la conclusione degli scontri armati sul territorio della Ex-Jugoslavia, si affievolisce l’attenzione suscitata dall’emergenza e con essa il coinvolgimento di una parte dell’opinione pubblica italiana. Nonostante ciò, la società civile italiana mantiene la propria presenza nell’area modificando le modalità d’azione per rispondere al mutato contesto. L’approccio emergenziale lascia gradualmente il posto ad una tipologia di intervento improntata alla ricostruzione e alla cooperazione allo sviluppo.
Dopo gli accordi di pace, la presenza della diplomazia internazionale viene sostituita dalle agenzie delle Nazioni Unite che mettono a disposizione ingenti fondi per la ricostruzione e pacificazione. I volontari italiani presenti nei Balcani, con il proprio bagaglio di esperienze maturate durante gli anni del conflitto, riescono a presentarsi come interlocutori credibili ai donatori internazionali. Matura in diversi casi una partnership destinata a consolidarsi negli anni. Già durante la guerra, molte esperienze avevano puntato a progetti di gemellaggio tra comunità, allo scopo di superare l’episodicità solidaristica e consolidare il coinvolgimento della società civile italiana. Alla fine delle ostilità, questo approccio viene potenziato: si consolidano le relazioni esistenti e si rafforza il ruolo degli enti e dei comitati locali, aprendo la strada a significative esperienze di cooperazione decentrata.
L’attenzione verso la comunità, che ha caratterizzato le attività di una parte consistente della solidarietà italiana durante il conflitto, si rafforza in questa fase e produce uno degli interventi più strutturati dell’immediato dopoguerra, vale a dire il progetto Atlante. Si tratta di un progetto animato dai tanti comitati locali italiani e realizzato in partnership con le Nazioni Unite (UNOPS e UNDP), che individua nella promozione e nel sostegno delle comunità locali la formula per consolidare le neonate istituzioni democratiche e la pace: Bergamo per Kakanj, Bologna per Tuzla, Padova per Gračanica, Brescia per Zavidovići, Trento per Prijedor, ecc. Il progetto e l’approccio che lo sottende trovano riscontro anche nel nascente progetto delle Ambasciate della Democrazia Locale, sostenute dal Consiglio d’Europa. La creazione di legami stabili, veri e propri gemellaggi che coinvolgono gli enti locali oltre alla società civile, si configura come uno degli aspetti più caratterizzanti del rapporti fra l’Italia e i paesi dello spazio post-jugoslavo.
Nel corso di questi progetti, nuovi aggettivi vengono aggiunti al sostantivo “cooperazione”. Un esempio è l’operazione Città/Città, lanciata alla fine del 1999 e improntata alla cooperazione decentrata umanitaria. Un elemento caratterizzante delle attività realizzate nell’immediato dopoguerra è lo sforzo di riflessione volto a qualificare le attività di cooperazione: l’attenzione e il dibattito intenso su questi temi contribuiscono alla diffusione di un approccio (auto)critico alla cooperazione, che ne fa emergere i limiti e le debolezze. La difficoltà di improvvisarsi operatori umanitari, di prendere posizione e capire, di fare le scelte giuste portarono ad interrogarsi sull’emergenza umanitaria, sul senso e sugli approcci possibili del fare cooperazione.
Una nuova emergenza, il Kosovo
Mentre l’attenzione della comunità internazionale e dell’opinione pubblica si concentra sui territori direttamente coinvolti negli scontri armati, la situazione in Kosovo è a lungo considerato un problema interno alla Serbia di Milošević. Da questo punto di vista la società civile, italiana e internazionale, dimostra un approccio diverso rispetto a quello dei governi. Già dal 1993 alcuni gruppi raccolgono l’appello – lanciato dalla Lega Democratica del Kosovo (LDK) presieduta da Ibrahim Rugova – a sostenere la resistenza non violenta albanese. Nel 1993 viene promossa la Campagna per una Soluzione Nonviolenta in Kosovo, che raduna organizzazioni nazionali ed enti locali e si impegna nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica italiana verso la questione kosovara. Nonostante le difficoltà incontrate nel coinvolgere le varie realtà di attivismo e volontariato, all’epoca concentrate soprattutto sull’inferno della guerra in Bosnia, il sistema di resistenza albanese in Kosovo viene visto sempre più come un modello ideale di alternativa alla contrapposizione armata nei Balcani. I rapporti si istituzionalizzano fra il 1995 e il 1997 con l’apertura dell’Ambasciata di Pace a Pristina. Nella stessa direzione agisce la Comunità di Sant’Egidio, che nel 1996 riusce ad intavolare un dialogo tra Milošević e Rugova che si conclude con un mai implementato accordo sul sistema scolastico.
Con l’intensificarsi degli scontri fra l’UCK e l’esercito serbo nel 1998, viene lanciata la campagna Kosovo I care, con l’obiettivo di portare aiuto ai profughi, già numerosi, e di fare leva sul governo italiano per favorire un intervento da parte dell’ONU per la cessazione degli scontri e la ripresa del dialogo fra le parti. Nel frattempo sul territorio kosovaro sono attivi alcuni gruppi della società civile italiana che si propongono come soggetti in grado di favorire il dialogo, come l’Operazione Colomba della Papa Giovanni XXIII.
In seguito all’intervento armato internazionale, la guerra del Kosovo assume una valenza ancora più politica, in virtù del fatto che l’Italia è coinvolta come paese belligerante. L’attivismo contro la guerra, che fino a questo momento si è concretizzato prevalentemente in azioni rivolte alle popolazioni colpite, si rivolge ora anche contro il governo italiano, contestandone il sostegno alle operazioni militari. Allo stesso tempo, si apre all’interno della società civile una riflessione sulla questione della guerra umanitaria e sulle sue contraddizioni. Le diverse letture del conflitto producono inoltre una spaccatura sul piano della solidarietà, tra chi, come ICS e poche altre organizzazioni e associazioni della società civile, rifiuta completamente la collaborazione governativa e la partecipazione alle attività della missione Arcobaleno. Nella pratica, questa divergenza di pensiero si traduce nella gestione separata dei campi profughi allestiti in Albania e Macedonia per accogliere i profughi kosovari.
Sfide e difficoltà
Le esperienze della solidarietà italiana nei Balcani rappresentano un momento particolarmente significativo per la società civile del nostro paese. Il coinvolgimento quotidiano e pervasivo influenzano abitudini e mentalità dei cittadini italiani; al contempo, non mancano criticità e difficoltà: si rende necessario confrontarsi e familiarizzare con un contesto per i più completamente sconosciuto, capire una guerra “nuova”, misurarsi con un fenomeno come il nazionalismo, considerato da molti estraneo. Sono numerosi i dibattiti e gli interrogativi che emergono nel corso degli anni Novanta e che mettono alla prova l’unitarietà e la continuità del movimento. Molti di questi nodi trovano la loro origine nel carattere inedito delle situazioni affrontate, altri riguardano più in generale il percorso di maturazione della società civile italiana.
Un primo aspetto che merita di essere ricordato è la trasformazione che interessa il movimento pacifista italiano – particolarmente coinvolto nella mobilitazione – e le sue modalità d’azione. Dopo l’esperienza degli anni Ottanta mutano le questioni con le quali il pacifismo si deve confrontare. Al centro dell’attenzione non c’è più l’accondiscendenza del governo italiano a pressioni esterne nell’ambito della guerra fredda; a partire dal 1991 si impongono come temi imprescindibili la crisi umanitaria in corso, e in secondo luogo la posizione del governo italiano e della comunità internazionale verso il conflitto. Per questo il movimento di solidarietà italiano sposta il proprio baricentro, facendo dei luoghi colpiti dal conflitto il principale scenario del proprio intervento. Alle manifestazioni nella piazze italiane – cui è legata l’immagine del pacifismo italiano nell’ultimo decennio della Guerra fredda – subentrano altre priorità e strategie di azione: si cercano interlocutori nelle zone interessate dal conflitto, e il metodo scelto è in buona parte quello della diplomazia popolare e della solidarietà concreta.
Molti i dubbi e gli interrogativi connessi a questa rinnovata impostazione: quanto ci si può effettivamente sostituire all’azione delle istituzioni? Quale il senso e l’efficacia degli aiuti? La solidarietà concreta e la diplomazia popolare si dimostrano, soprattutto in alcune circostanze, interventi potenzialmente ad alto rischio. La scelta di optare per questi metodi non è certo immune da forti critiche per i modi, le responsabilità, e le singole iniziative giudicate a volte eccessivamente provocatorie. Uno dei momenti più drammatici è senza dubbio la morte di tre volontari bresciani impegnati a consegnare aiuti umanitari: allo shock seguono le polemiche, “ecco dove erano i pacifisti” insinua qualcuno. La paura però non manca e soprattutto, risulta sempre più difficile spiegare la scelta di partire verso le zone di conflitto a chi rimaneva a casa in attesa di una telefonata. La morte dei tre volontari Guido Puletti, Sergio Lana e Fabio Moreni è un lutto trasversale alle diverse anime del movimento, che in alcuni casi si traduce in un esempio di sacrificio in grado di catalizzare ulteriore impegno.
La strage dei tre pacifisti impone in maniera drammatica la necessità di strutturare un dialogo tra la società civile e le istituzioni, affinché un coordinamento fra queste scongiuri il rischio che si ripetano episodi così gravi. Forte soprattutto della possibilità di dialogo con il governo concretizzatasi con la creazione del Tavolo di Coordinamento per la Ex-Jugoslavia, la società civile sviluppa la capacità di porsi come interlocutore credibile rispetto alle istituzioni statali (ministero della Difesa e degli Esteri), ma anche con agenzie internazionali come ACNUR ed UNDP. Risulta certamente fondamentale in questo senso la capacità di articolare e di dare una voce unitaria ai molteplici attori coinvolti, anche se la pratica non si consolida: in occasione dell’emergenza in Kosovo del 1999 il governo D’Alema – dopo aver sostenuto l’intervento Nato in Serbia – deciderà di scavalcare questo approccio dialogico in favore di un intervento diretto, la Missione Arcobaleno. Questa scelta del governo italiano viene percepita da buona parte della solidarietà italiana come un passo indietro rispetto all’esperienza degli anni precedenti. Da una gestione partecipata dell’emergenza si ritorna ad un’impostazione verticista.
Sono tuttavia soprattutto i dilemmi e le fratture relative all’intervento armato internazionale nei Balcani ad influenzare la riflessione coeva ed i ragionamenti successivi di una fetta importante della società civile italiana. Il neutralismo che prevale nella fase iniziale viene rivisto soprattutto per il protrarsi del conflitto e l’impatto delle notizie provenienti dalla Sarajevo assediata. Di fronte ad una guerra che da anni non dà tregua, la possibilità di un intervento determina crisi e contrapposizioni. Le lacerazioni maggiori si raggiungono nel 1995, l’ultimo anno di guerra in Bosnia, quando l’intervento militare internazionale comincia ad essere visto come necessario anche in alcuni ambienti della mobilitazione. Il dilemma, divisivo sia a livello individuale che di gruppo, riflette sul fatto che il sostegno ad un intervento armato, percepito sempre più come imprescindibile per porre fine alla guerra, equivalga ad un “tradire se stessi”. Fra le molte prese di posizione autorevoli che alimentano il dibattito, va annoverata quella di Alexander Langer. Lo stesso dibattito si riaccende in occasione della crisi del Kosovo, ulteriormente acuito e politicizzato in quanto l’Italia vi è coinvolta come paese belligerante e la Nato agisce senza l’avvallo delle Nazioni Unite.
La società civile italiana fa il suo ingresso negli anni 2000 con un importante bagaglio di esperienze lasciato dal decennio precedente. Sono molti, tra i partecipanti ai movimenti globali affermatisi a cavallo del nuovo millennio, coloro che vengono dalle esperienze nei Balcani. Dagli anni Ottanta sono cambiate le prospettive, la visione politica, l’organizzazione e le reti, le modalità d’azione della solidarietà italiana. Quanto si tratti di cambiamenti strutturali è tema di discussione. All’espansione in termini di competenze e capacità di riflessione politica elaborate nel corso di quel decennio, fa da contraltare la consapevolezza dei limiti propri di quell’esperienza. Mentre il contesto di fine anni ’80 incoraggiava la fiducia nelle potenzialità della società civile anche in ambito internazionale, i vincoli a questa capacità si sono riscontrati tramite l’esperienza. L’equilibrio fra queste due componenti è in continua ridefinizione e le sfide poste dalle crisi in corso oggi continuano ad interrogarlo. Il percorso attraverso la varietà dei materiali presentati in questo testo – una selezione di quanto raccolto finora grazie alla piattaforma di crowd-sourcing – testimonia la capacità della società civile di confrontarsi con il contesto di allora. Le numerose questioni e gli interrogativi emersi in questo lavoro rappresentano l’oggetto di studio della ricerca Cercavamo la pace di OBC, uno sforzo di ricostruzione e di interpretazione che proseguirà nei prossimi mesi.
Tag: Cercavamo la pace